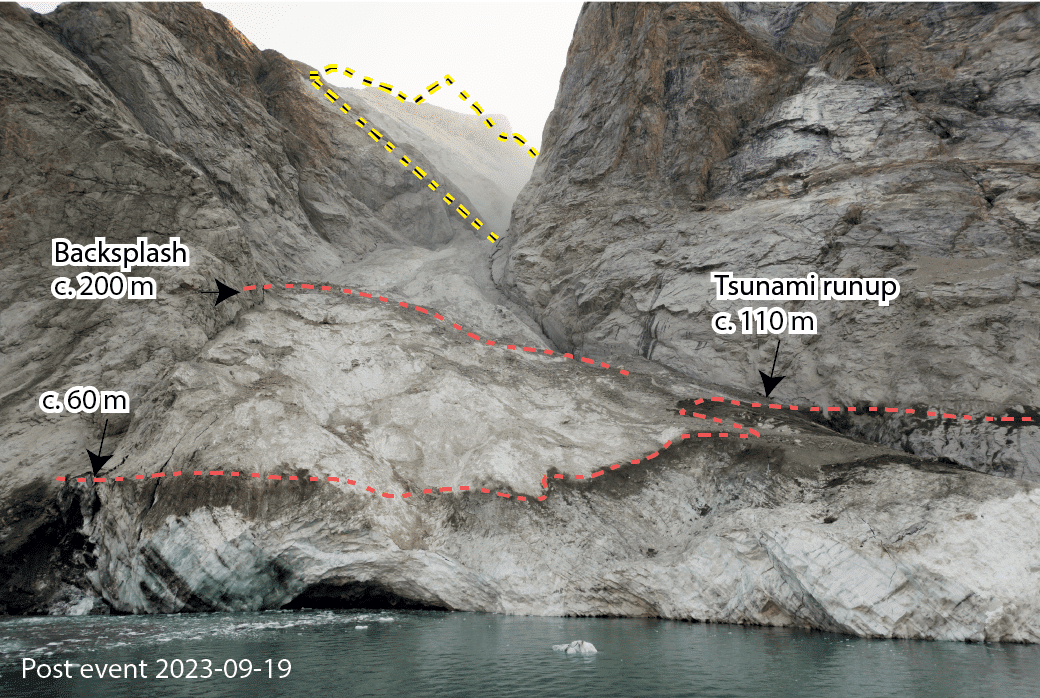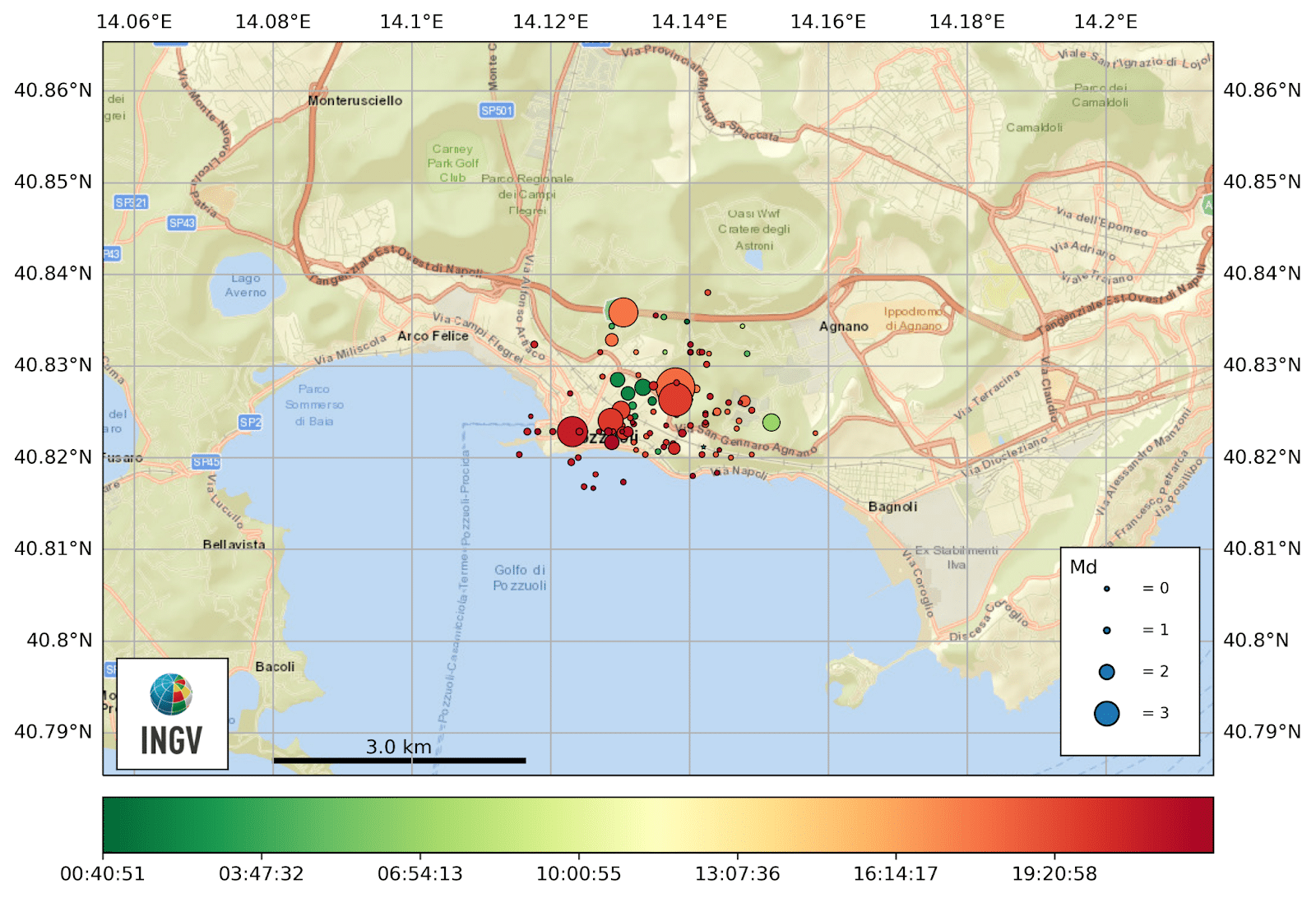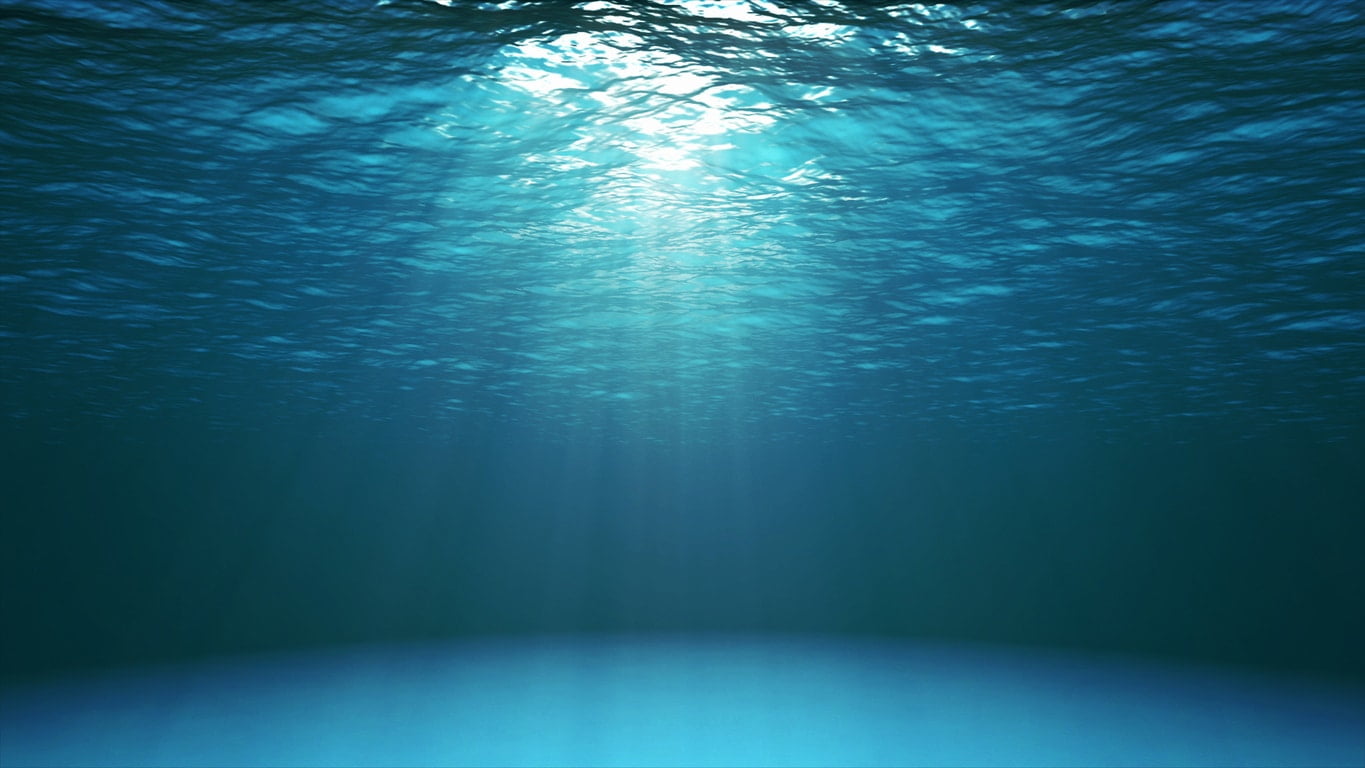Allarme Ingv: Venezia a rischio inondazioni estreme entro 2150
Venezia e la sua laguna potrebbero essere esposte a inondazioni estreme entro il 2150 a causa dell’aumento del livello del mare e dell’abbassamento del terreno: un fenomeno noto come ‘subsidenza‘. L’allarme arriva dallo studio multidisciplinare Multi-Temporal Relative Sea Level Rise Scenarios up to 2150 for the Venice Lagoon condotto dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con enti italiani e stranieri, recentemente pubblicato sulla rivista scientifica ‘Remote Sensing’.
Il documento analizza le proiezioni climatiche più aggiornate dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e i dati geodetici disponibili per stimare l’estensione delle superfici esposte all’allagamento nei prossimi decenni, a causa dell’aumento del livello marino. I risultati ipotizzano scenari critici per l’intera laguna e il MoSE, attualmente progettato per proteggere Venezia dalle acque alte fino a un’altezza di 3 metri di differenza tra il mare aperto e la laguna e un livello medio del mare di 60 cm nel 2100, potrebbe essere superato dal mare verso la fine di questo secolo. “L’indagine è stata condotta con lo scopo di fornire informazioni sulla prossima evoluzione dell’innalzamento del livello del mare nella Laguna di Venezia per comprendere come questo possa influenzare una delle città più iconiche al mondo”, spiega Marco Anzidei, primo autore della ricerca dell’INGV. Lo studio combina dati geodetici, topografici e proiezioni climatiche per valutare l’impatto delle variazioni del livello del mare sulle coste e sulle isole della laguna nei prossimi decenni.
“Per stimare gli effetti dell’aumento del livello del mare nella Laguna di Venezia entro il 2150, lo studio ha adottato un approccio multidisciplinare basato su differenti tipologie di dati, tra i quali quelli geodetici provenienti dalle reti di stazioni Global Navigation Satellite System, note come GNSS, i dati satellitari Synthetic Aperture Radar – SAR (che insieme alle stazioni GNSS consente di misurare i movimenti del suolo con precisione millimetrica), le serie temporali del livello del mare raccolte dalla rete di mareografi dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dal Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia e i dati topografici ad alta risoluzione messi a disposizione dal CO.RI.LA e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)”, osservano Anzidei e Cristiano Tolomei, ricercatori dell’INGV. Le analisi condotte hanno permesso di proiettare i livelli del mare attesi per la Laguna di Venezia fino al 2150, fornendo anche mappe dettagliate dei possibili scenari di inondazione per il 2050, il 2100 e il 2150, in assenza di sistemi di protezione della laguna da livelli del mare più alti di oggi. “I risultati indicano che nel peggiore dei casi il livello del mare del 2150 potrebbe aumentare fino a 3,47 metri sopra il riferimento della stazione mareografica di Punta della Salute, situata nel Canale della Giudecca, in caso di eventi estremi di alta marea, simili a quelli avvenuti nel 1966 e più recentemente nel 2019. Il territorio potenzialmente sommerso entro il 2150, inoltre, raggiungerebbe i 139 km², con un’estensione che potrebbe arrivare a 226 km² (pari al 64% dell’area investigata) in caso di queste acque alte eccezionali. I dati evidenziano che senza ulteriori interventi specifici Venezia sarà maggiormente esposta a fenomeni di inondazione, con un impatto significativo sulla popolazione e sul patrimonio storico”, aggiungono Tommaso Alberti e Daniele Trippanera, ricercatori dell’INGV. Lo studio, che è stato finanziato dal Ministero dell’Università e Ricerca nell’ambito del progetto PRIN – GAIA, e che prosegue gli altri studi già pubblicati su Venezia nell’ambito del progetto europeo SAVEMEDCOASTS2 (www.savemedcoasts2.eu), evidenzia anche come l’aumento del livello del mare nella Laguna avvenga da tempi storici e che la sua vulnerabilità sia oggi amplificata dagli effetti del cambiamento climatico e dalla continua subsidenza del suolo, che raggiunge valori fino a 7 mm all’anno.
Le aree più basse della laguna risulterebbero quindi maggiormente esposte al rischio di allagamento, con implicazioni critiche per le infrastrutture costiere e le attività economiche. “Gli scenari delineati suggeriscono che è necessario intraprendere prima possibile degli aggiornamenti alla pianificazione territoriale e ai piani di rischio da parte dei decisori politici e degli enti locali, con azioni concrete per proteggere Venezia e la sua laguna. Solo attraverso una gestione responsabile e consapevole – conclude Anzidei –, sarà possibile preservare la città, la sua popolazione e un patrimonio culturale unico al mondo dalle conseguenze dell’innalzamento del livello del mare atteso nei prossimi decenni”.