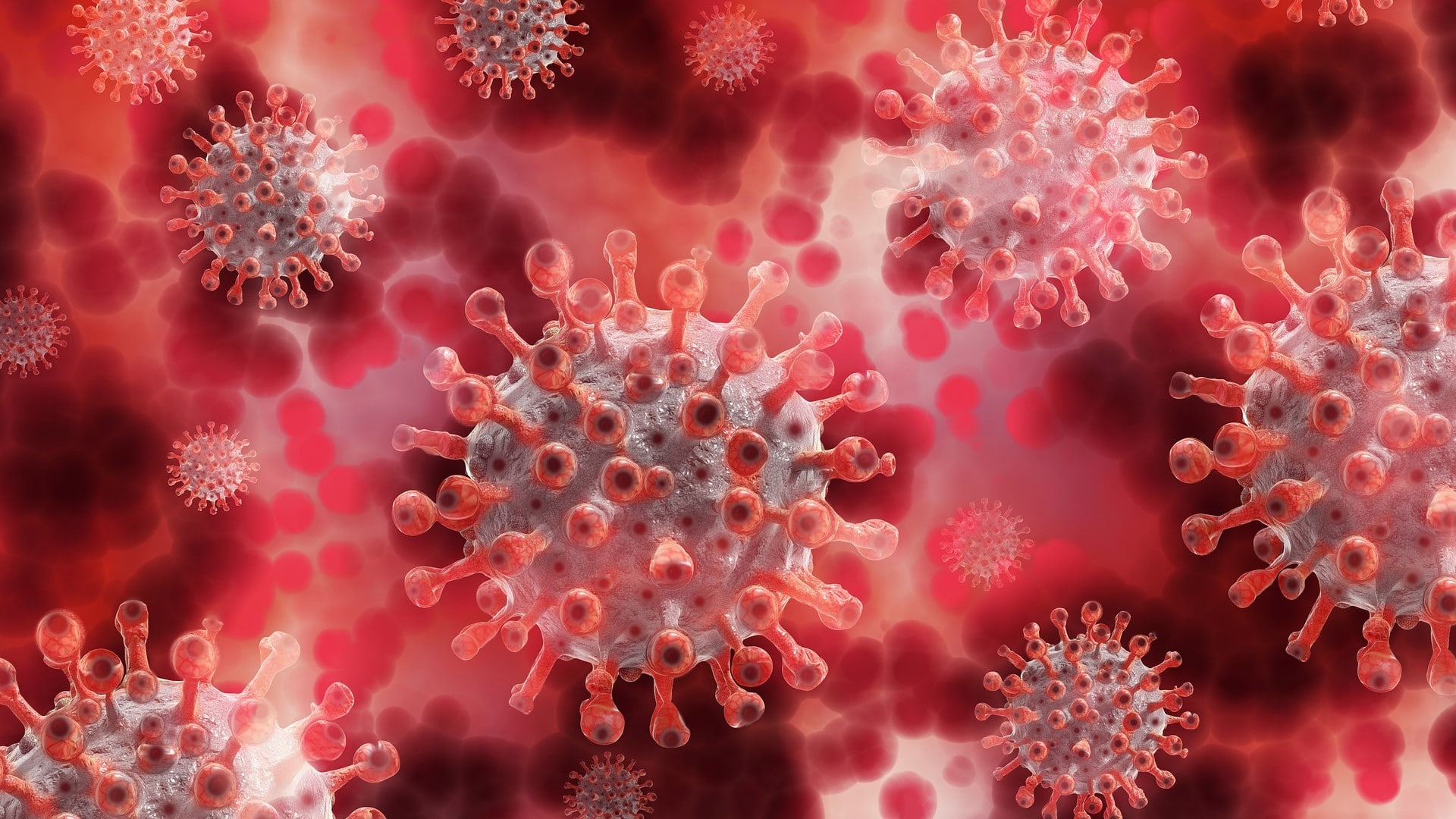Diminuiscono le emissioni ma aumentano eventi meteo estremi
Il Rapporto Bes (Benessere equo e sostenibile) 2021 dell’Istat rivela un ritratto drammatico dell’Italia, con un aumento dei divari nella popolazione e l’arretramento del benessere soprattutto fra donne e giovani. Nel report un lungo capitolo è dedicato alle tematiche ambientali. Il cui quadro è ancora decisamente influenzato dalla pandemia, con la riduzione delle emissioni di CO2 a causa delle prolungate chiusure di attività economiche e l’attenuarsi dell’inquinamento da PM2,5, che rimane, tuttavia, elevato e senza miglioramenti apprezzabili. Dagli indicatori del Bes emerge che per effetto dei cambiamenti climatici aumentano gli eventi meteo-climatici estremi come periodi di caldo, assenza di pioggia e precipitazioni estreme. Fenomeni che, tra l’altro, acuiscono il rischio delle popolazioni esposte a frane e alluvioni. Sono ancora forti le criticità nella distribuzione dell’acqua potabile e nella raccolta e nel trattamento delle acque reflue urbane. La superficie delle aree terrestri protette, che ricopre oltre un quinto del territorio nazionale, e la disponibilità di verde pubblico pro capite nelle città italiane, non subiscono avanzamenti sostanziali negli ultimi anni. Seppur a un ritmo minore rispetto a quello degli anni passati, continua l’incremento del consumo di suolo prodotto dalle coperture artificiali impermeabili. Si riduce la produzione pro capite di rifiuti urbani per effetto del ciclo economico e prosegue la riduzione della quota ancora smaltita in discarica. Si conferma l’incremento degli ultimi anni della percentuale di energia elettrica da fonti rinnovabili.
INQUINAMENTO DA PM2,5
Per la qualità dell’aria, nel 2020 si rileva una diminuzione della percentuale dei superamenti di PM2,5 che si attestano al 77,4%, valore più basso dell’indicatore dal 2010, mentre nell’anno prepandemico (2019) risultavano l’81,9%. Questo andamento di attenuazione del fenomeno dell’inquinamento da PM2,5 non si riscontra nelle ripartizioni nord occidentale e orientale dove storicamente si osservano i valori più elevati dell’indicatore, che nel 2020 sono stabili rispetto all’anno precedente.
LE EMISSIONI DI CO2 E GAS EFFETTO SERRA
Diminuiscono nettamente nel 2020 le emissioni di CO2 e di altri gas climalteranti (o gas effetto serra) generate dalle attività economiche e dalle famiglie, raggiungendo il valore di 6,6 tonnellate di CO2 equivalente per abitante, per effetto delle restrizioni imposte nel periodo del lockdown. Si conferma la flessione iniziata nel 2008, anno in cui le tonnellate pro capite emesse erano 9,8.
TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI
Sono sempre più evidenti gli effetti dei cambiamenti climatici in termini di temperature e precipitazioni. Nel 2021 le temperature minime e massime risultano maggiori rispetto alla media climatica (periodo di riferimento 1981-2010). L’intensità dei giorni di caldo negli anni 2011-2021 risulta sempre maggiore rispetto alla mediana del periodo di riferimento in tutte le ripartizioni. Nel 2021 i giorni di caldo risultano assenti nel Nord, stazionari al Centro (+18 giorni) e mostrano scarti positivi maggiori nel Sud (25 giorni) e nelle Isole per 13 giorni. Riguardo alle precipitazioni lo scarto rispetto alla mediana del periodo di riferimento a livello nazionale è pari a +2%, ma la situazione è più eterogenea e varia molto con la latitudine, passando da scarti negativi nel Nord (con punte superiori a -11% in Piemonte ed Emilia-Romagna) e in parte del Centro, fino ad anomalie positive diffuse nel Sud e molto elevate nelle Isole (+27,6%). Nel 2021 si osserva una riduzione dei giorni consecutivi non piovosi a scala nazionale, dovuta in particolare alle ripartizioni del Nord e delle Isole, mentre al Sud si osserva un aumento (+6 giorni). Nel 2020 si rileva una riduzione dei volumi di acqua movimentati nelle reti comunali dei capoluoghi rispetto al 2018. I volumi immessi in rete si contraggono di oltre il 4%, a fronte del -1,6% dei volumi erogati. Ne consegue una riduzione delle perdite totali di rete di circa 1 punto percentuale, proseguendo la tendenza degli anni precedenti. Anche la pandemia può aver generato delle modifiche nei volumi movimentati in distribuzione, infatti, in alcuni comuni a forte vocazione turistica, come Rimini e Venezia, si registra un’importante riduzione dei volumi erogati, -11,8% e -13,9% rispetto al 2018.
RIFIUTI URBANI
Nel 2020 la produzione di rifiuti urbani in Italia è scesa a 28,9 milioni di tonnellate (-3,6% dell’ammontare complessivo rispetto al 2019), pari a 487 chilogrammi per abitante (-16 chilogrammi pro capite) tornando quasi al valore pro capite più basso dal 2010, registrato nel 2015 (486,2). Nel 2020, sono stati conferiti in discarica il 20,1% del totale dei rifiuti urbani; era il 20,9% nel 2019 e il 46,3% nel 2010. La quota del Nord-ovest e del Nord-est risulta molto al di sotto della media, Centro e Sud hanno andamento e valori più prossimi alla media, mentre nelle Isole si osservano quote molto maggiori, si tratta di valori al lordo dei flussi in entrata e in uscita dalle regioni e delle ripartizioni e che non permettono quindi una valutazione sulla performance dei territori. Nel 2020 sono stati consumati 45.920 milioni di tonnellate di materia, circa l’8% in meno rispetto all’anno precedente e in controtendenza rispetto alla graduale crescita registrata nel periodo 2017-2019.
LA SENSIBILITÀ DELLE PERSONE AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Gli effetti dei cambiamenti climatici e dell’aumento dell’effetto serra rappresentano uno dei problemi ambientali che preoccupano maggiormente le persone. Tuttavia, se fino al 2019 la percentuale di persone di 14 anni e più che ritengono che questo sia uno dei problemi ambientali principali era in costante crescita, nel biennio 2020-2021 si registra un’inversione di tendenza che riguarda tutto il territorio (dal 71% del 2019 al 66,5% del 2021). Tale decremento e stato più significativo nel Nord-est, dal 73,6% al 68,2%, e nelle Isole, dove si riduce dal 72,8% al 64,1%. Nel 2021 il livello di interesse per queste tematiche torna a quello registrato nel 2018 (66,6%), evidenziando un aumento di attenzione in concomitanza con i movimenti di protesta a livello globale del 2019-2020. Inoltre, è ragionevole ipotizzare che le preoccupazioni per la pandemia e di conseguenza per la crisi economica siano state preponderanti.