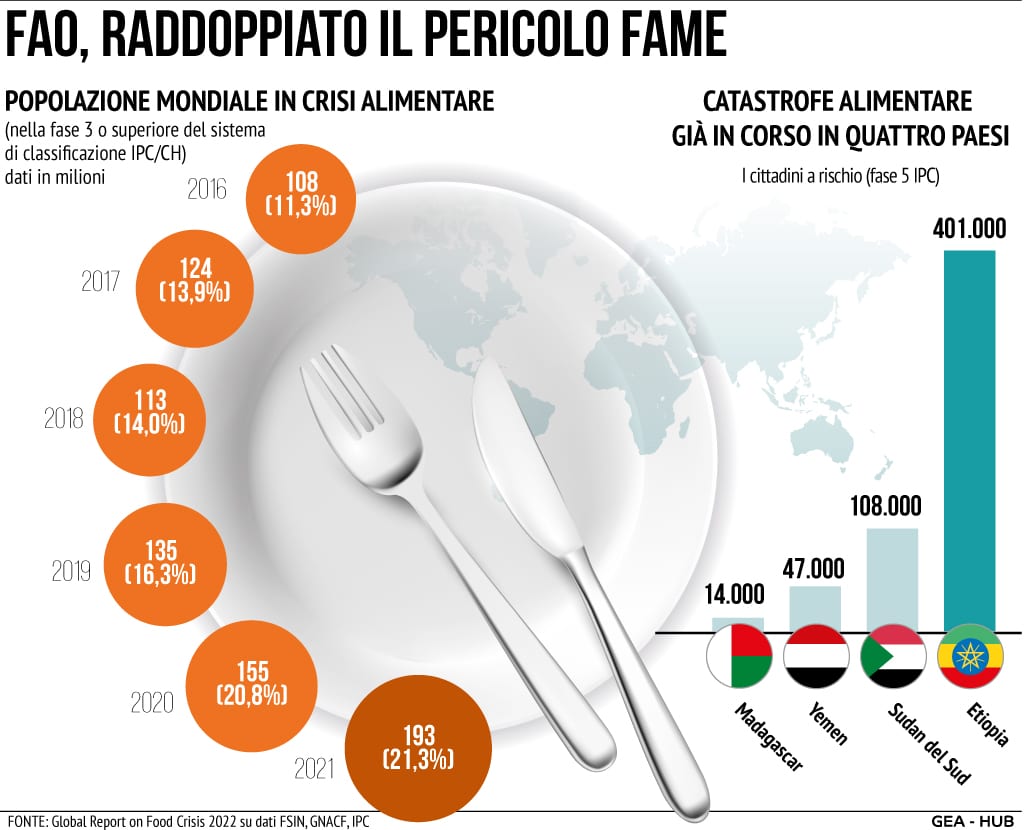Il Green Deal europeo non considera la globalizzazione
Il Green Deal guarda al futuro, ma è ancora troppo ancorato al passato e troppo sbilanciato ad un’offerta che non considera però consumi interni. In sostanza un’iniziativa che rischia di restare fine a sé stessa, se non si corre ai ripari e non si procede a un immediato cambio di rotta. Systemiq mette in luce le criticità dell’agenda sostenibile a dodici stelle, attraverso uno studio di insieme. Perché in un mondo globale e globalizzato c’è qualcosa di più della sensazione che l’Europa dimenticato il contesto interazionale. Non a caso l’analisi viene intitolata ‘Le implicazioni globali dell’attuazione del Green Deal europeo’, da un organismo non proprio qualunque. Systemiq nasce nel 2016 per guidare il raggiungimento dell’Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell’Onu. Nello staff anche Janez Potocnik, che della materia se ne intende. Conosce l’Italia e l’Italia si ricorda di lui, poiché fui lui, in veste di commissario per l’Ambiente nella seconda Commissione Barroso, a dover gestire, tra le altre cose, la delicata questione della gestione dei rifiuti.
Systemiq riconosce le ambizioni dei Ventisette. Il Green Deal europeo definisce un approccio integrato a una transizione verde e giusta entro il 2050 e una visione per un futuro climaticamente neutro. Peccato che gli attuali impegni e le relative politiche dell’Ue “si concentrano principalmente sul lato dell’offerta, affrontando a malapena le misure dal lato della domanda o il contesto globale e gli effetti internazionali della transizione dell’Europa verso la sostenibilità ecologica e sociale”. Istituzioni comunitarie e governi nazionali, al netto delle migliore intenzioni, “non affrontano il principale fattore di emissioni e degrado ambientale, ovvero il consumo eccessivo nei paesi ad alto reddito, compresa l’Europa”.
Il problema è quello solito, di un’Europa povera di risorse energetiche e materie prime, che deve reperire all’estero. Per questo motivo anche assumendo progressi in termini di efficienza, questi “non risolveranno la crisi delle risorse, o la crisi della biodiversità”. L’Ue ha bisogno di una nuova politica estera e di una nuova dimensione esterna se vuole vincere la scommessa della green economy. “Il successo della transizione europea è legato alla transizione globale”, e se l’Ue continua a procedere da sola, e ad avere partner quali Cina, India, economia emergenti e potenze economiche non allineate agli standard a dodici stelle, il Green Deal rischia di tramutarsi in un boomerang in termini di competitività. Non solo. L’approccio seguito non risponde alla necessità di una transizione davvero globale. L’approccio storico consistente nell’esternalizzare gran parte della produzione (e delle emissioni) europee a paesi con risorse e manodopera a basso costo “è incompatibile con l’ambizione di garantire la neutralità climatica, la resilienza e lo sviluppo sostenibile e di mantenere l’attività umana nel suo insieme entro i confini del pianeta”.
È tutto l’impianto della strategia che viene rimesso in discussione. L’Ue guarda a fornitori stranieri, approvvigionamenti, ma nel fare questo sbaglia. “Per il bene della transizione globale, nonché del Green Deal europeo, l’UE deve ridurre le sue importazioni di materiali, facilitata da una transizione verso un’economia circolare”. Solo così si avrà “un’economia europea che consuma meno dalle lunghe catene di approvvigionamento globali, più resiliente, oltre che più sostenibile”. Ma l’Europa non sembra averlo capito, anzi. “ Un esempio lampante dell’incapacità di considerare gli effetti internazionali sono gli sforzi dell’Europa per sostituire il petrolio e il gas russo”, criticano gli analisti. “Acquistando le risorse disponibili sui mercati internazionali, i governi europei stanno facendo salire i prezzi dell’energia per le persone e i P aesi che possono permetterseli meno”.