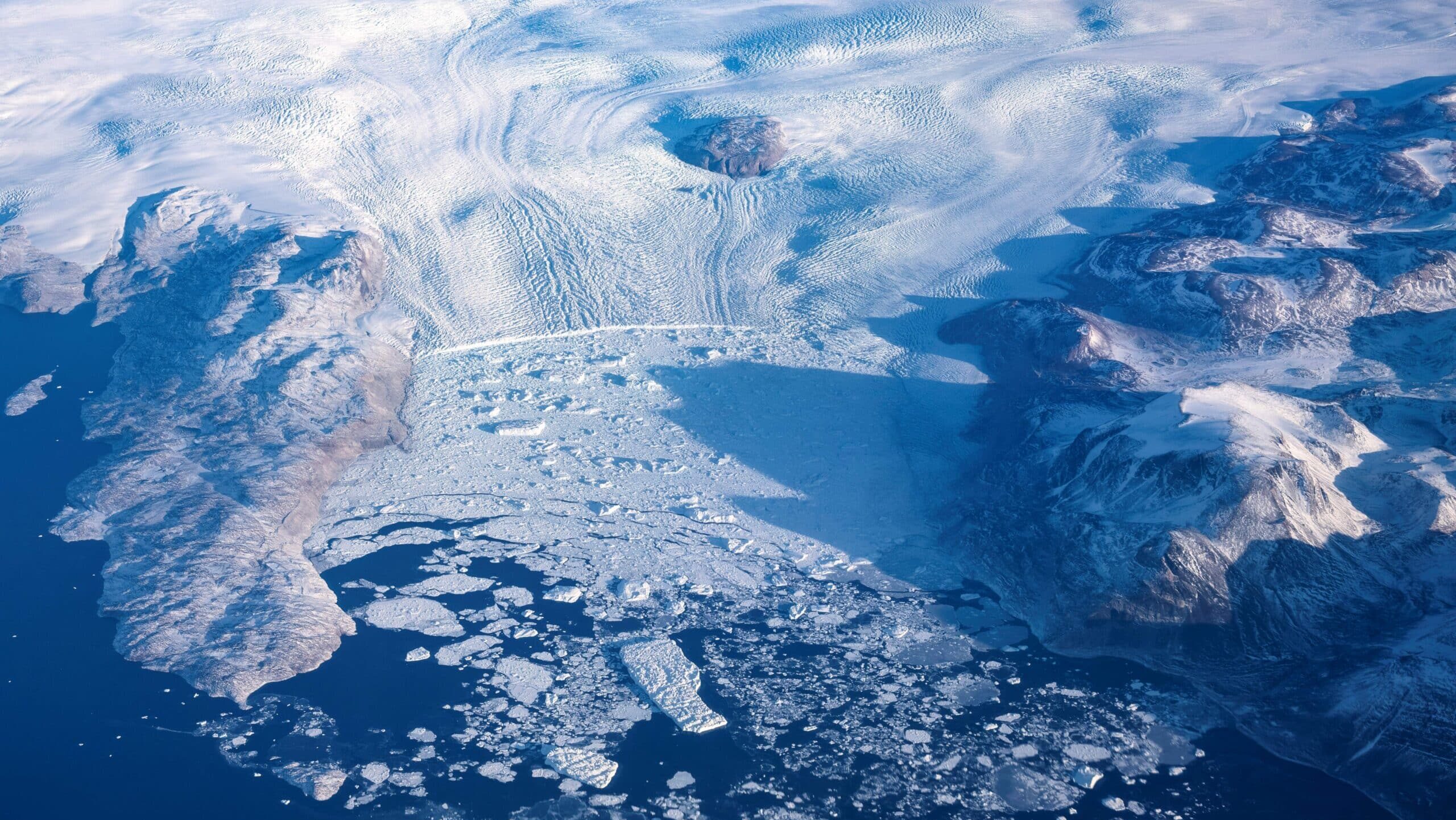
Clima, Ipcc riunito in Cina: è battaglia politica sul calendario del prossimo rapporto
L’Ipcc (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico), il gruppo di esperti climatici incaricati dall’ONU, si riunisce da oggi in Cina per far adottare dai rappresentanti dei Paesi del mondo il calendario e il contenuto dei suoi lavori scientifici, dietro ai quali si gioca una vera e propria lotta geopolitica.
Creato nel 1988 per informare i responsabili politici, l’Ipcc ha appena iniziato il settimo ciclo di lavoro. Entro il 2029, questo ciclo dovrebbe portare a un grande rapporto di riferimento, composto da voluminosi rapporti intermedi e tematici. A quale ritmo e per quale contenuto? È ciò che i paesi devono decidere durante questa riunione che si tiene fino al 28 febbraio a Hangzhou, in un contesto caratterizzato dai due anni più caldi mai registrati e dall’annunciato ritiro degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi sul clima.
La questione è se i tre principali capitoli del rapporto finale – che riguardano la fisica, gli impatti climatici e le soluzioni per ridurre i livelli di gas serra – possano essere prodotti abbastanza rapidamente da fare da base scientifica per il “bilancio globale” dell’ONU sul clima nel 2028. Questo bilancio, redatto ogni cinque anni per analizzare gli sforzi dell’umanità per rispettare l’accordo di Parigi, è un documento chiave dei negoziati annuali sul clima.
Il primo bilancio, nel 2023, ha tracciato un quadro severo del ritardo accumulato dall’umanità nel ridurre le sue emissioni di gas serra, che avrebbero dovuto diminuire del 43% tra il 2019 e il 2030 ma non sono ancora in calo. In risposta, la COP28 di Dubai alla fine del 2023 si era conclusa con un impegno senza precedenti a una “transizione” verso l’uscita dai combustibili fossili, nonostante importanti concessioni all’industria e ai paesi produttori.
Molti paesi ricchi e le nazioni in via di sviluppo più esposte, in particolare i piccoli Stati insulari, sono favorevoli a un calendario accelerato, ma si scontrano con le obiezioni di alcuni produttori di petrolio o grandi inquinatori le cui emissioni sono in aumento, come India e Cina. Per la Coalizione per l’ambizione elevata, che riunisce paesi europei e paesi vulnerabili dal punto di vista climatico, basare il “bilancio globale” del 2028 su dati scientifici solidi e aggiornati è un elemento cruciale per il rispetto dell’accordo di Parigi del 2015. Secondo la dichiarazione pubblicata sabato, la rottura di questo legame “comprometterebbe la credibilità e l’integrità” di questo accordo, che mira a contenere il riscaldamento ben al di sotto dei 2°C e a proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5°C. Ma Cina, Arabia Saudita, Russia e India sono tra i paesi che hanno giudicato il calendario proposto troppo precipitoso, secondo il resoconto delle sessioni precedenti redatto dall’International Institute for Sustainable Development. Gli osservatori temono che la sessione in Cina sia l’ultima possibilità di trovare un accordo. “Penso che il motivo per cui le discussioni sono state così accese sia la situazione attuale: la pressione geopolitica, l’onere finanziario degli impatti del cambiamento climatico e la transizione verso l’abbandono delle energie fossili”, ha dichiarato una fonte vicina alle discussioni. Secondo l’ultima sintesi dell’IPCC, all’inizio del 2023, il mondo è sulla buona strada per superare la soglia di riscaldamento a lungo termine di 1,5°C all’inizio degli anni 2030. Ma recenti studi suggeriscono che questa fase potrebbe essere superata prima della fine di questo decennio. Il 7° ciclo del Giec prevede anche pubblicazioni tematiche.
Un rapporto, molto atteso, riguarderà “il cambiamento climatico e le città”, dove vive più della metà dell’umanità. È previsto per il 2027. L’Ipcc deve anche produrre un documento inedito sui metodi, balbettanti e criticati, di cattura e stoccaggio della CO2. E una metodologia per valutare meglio le emissioni e l’impatto degli inquinanti a breve durata (metano, ossido di azoto e particolato), meno controllati della CO2, ma che svolgono un ruolo importante nel riscaldamento globale.


