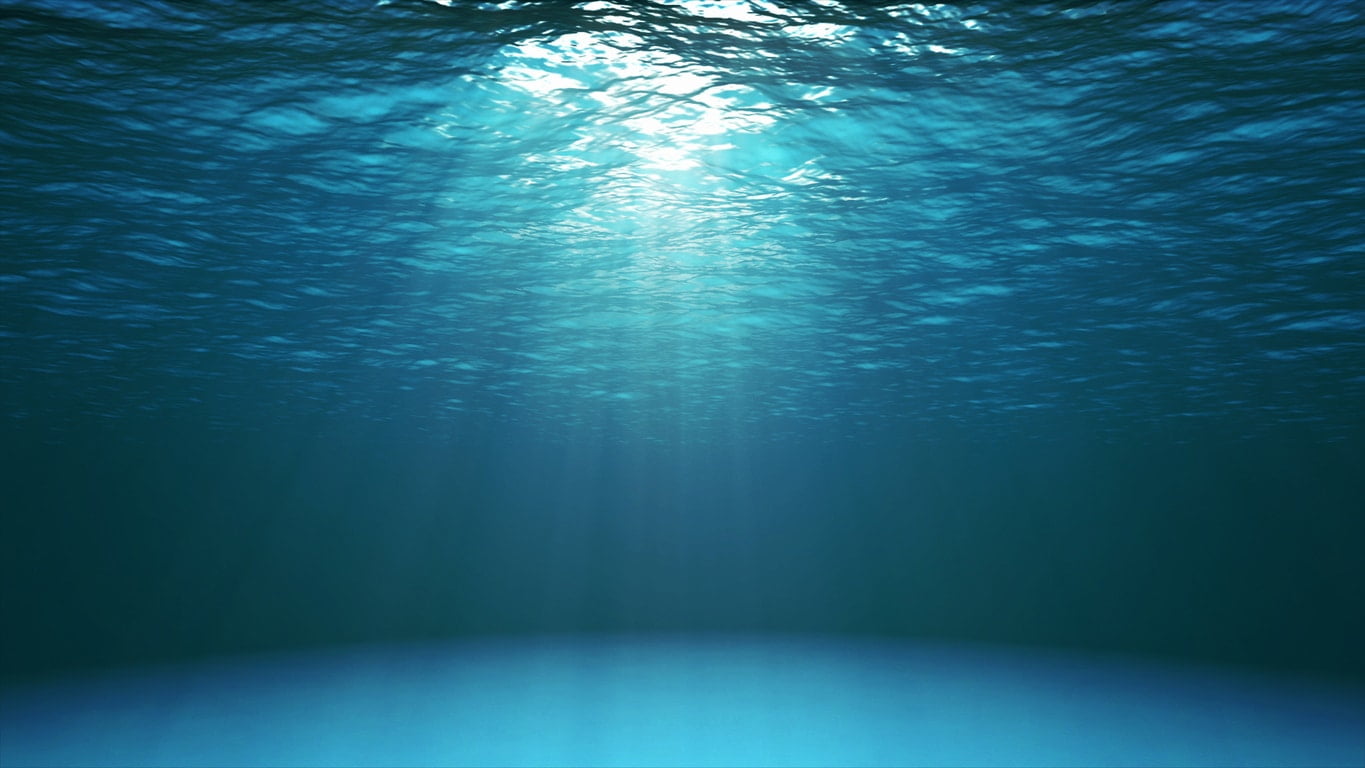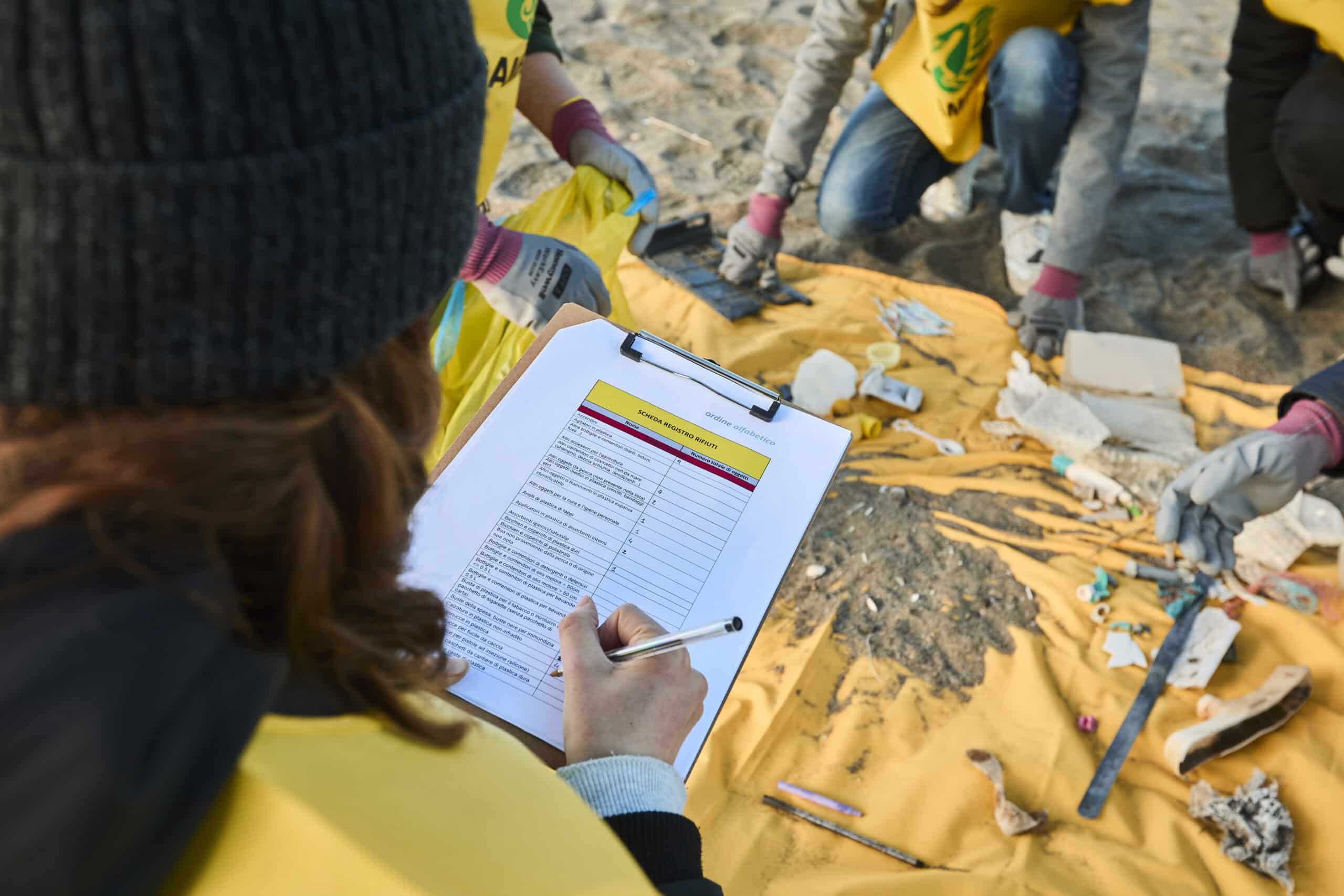Mediterraneo bollente, clima impazzito: allarme rosso sui rischi per l’intero ecosistema
Il mare Mediterraneo è sempre più caldo: uno dei principali hotspot climatici a livello globale è anche un ecosistema complesso e fragile che rappresenta una sorta di laboratorio naturale per lo studio degli impatti del cambiamento climatico. A fare il punto su una situazione sempre più allarmante è Fondazione Marevivo, che da 40 anni si occupa di tutela del mare. Secondo l’ultima analisi, il mare Mediterraneo si sta scaldando a un ritmo che va dal 20% al 50% più veloce rispetto alla media globale ed è un trend in continua crescita, se si considera che la velocità di riscaldamento dell’acqua nell’ultimo decennio è addirittura raddoppiata rispetto al precedente. Si prevede che entro il 2100 la temperatura della superficie dell’acqua aumenterà dai 3.5° C ai 4.5° C in più rispetto ad oggi (dati IPCC AR6). “L’estate 2025 è iniziata con temperature ben più calde delle peggiori previsioni che eserciteranno un’ulteriore pressione sugli ecosistemi già compromessi e sulle economie e società vulnerabili – spiega Rosalba Giugni, presidente di Marevivo. – Il Mediterraneo sta perdendo la capacità di rimescolamento delle acque e di raffreddamento e questo incide sulla sua funzione fondamentale di termoregolare il clima”.
Fondazione Marevivo insiste su un punto cruciale: “La vita nel mare profondo è possibile grazie al freddo e se il Mediterraneo, uno dei principali hotspot climatici a livello globale, continuerà a scaldarsi sempre di più contribuendo a modificare l’equilibrio termico, non solo le specie marine ne subiranno le conseguenze, ma l’intera vita sulla Terra“. Dall’inizio degli anni ‘80, le temperature medie della superficie del Mediterraneo sono aumentate in tutto il bacino, ma con forti differenze subregionali che vanno da +0,29 a +0,44°C per decennio. Per 2°C di riscaldamento globale sopra il valore preindustriale, le temperature diurne massime nel Mediterraneo aumenteranno probabilmente di 3,3 °C; con 4 °C di riscaldamento globale, quasi tutte le notti saranno tropicali con diminuzione dell’escursione termica tra giorno e notte. Tutto ciò avrà ricadute su vari aspetti.
CICLO DELL’ACQUA DOLCE. La massa dei ghiacciai nella regione mediterranea dovrebbe continuare a diminuire fino alla completa scomparsa della maggior parte dei ghiacciai di montagna entro la fine del secolo. Inoltre, c’è stata una diminuzione delle precipitazioni invernali sulle parti centrali e meridionali del bacino dalla seconda metà del XX secolo.
CORRENTI MARINE. Le alterazioni di temperatura e salinità stanno cambiando le correnti termoaline, fondamentali per l’equilibrio climatico del Mediterraneo. Le acque più calde in superficie impediscono il rimescolamento con gli strati profondi ricchi di nutrienti.
INNALZAMENTO DEL LIVELLO DEL MARE. Secondo la Fondazione Marevivo, il Mediterraneo è aumentato di 1,4 mm all’anno nel corso del 21esimo secolo e l’aumento ha subito un’accelerazione fino a 2,8 mm all’anno negli ultimi anni. Verso il 2100, secondo lo scenario, il livello medio del mare nel bacino sarà probabilmente da 40 a 100 cm più alto che alla fine del XX secolo, questo causerà un aumento della frequenza e dell’intensità delle inondazioni costiere e dell’erosione.
TROPICALIZZAZIONE, SPECIE ALIENE INVASIVE E MIGRAZIONI. Quasi 1000 specie sono migrate nel Mediterraneo. L’aumento della temperatura del mare significa che i nuovi arrivati possono sopravvivere in aree sempre più vaste del Mediterraneo, dove pochi decenni fa le acque sarebbero state troppo fredde per loro. E molte specie stanno prosperando a scapito delle specie native. Inoltre triglie, sardine, acciughe e naselli, stanno migrando verso nord o verso acque più profonde in cerca di temperature più adatte. Questo modifica i cicli riproduttivi e mina la sostenibilità della pesca tradizionale, con conseguenze economiche e culturali.
ECONOMIA E SALUTE. Negli ultimi 20 anni, la quota del prodotto interno lordo riferibile al turismo è aumentata del 60% nei paesi mediterranei. Il cambiamento climatico avrà probabilmente un impatto sul comfort termico dei turisti durante l’alta stagione con il susseguirsi di ondate di calore ed eventi meteorologici violenti. L’innalzamento del livello del mare avrà probabilmente effetti sulle spiagge e sui siti storici localizzati in prossimità delle coste. L’effetto dell’innalzamento del livello del mare, con un cambiamento nelle caratteristiche delle tempeste, influenzerà probabilmente in modo significativo le operazioni portuali, rallentando le operazioni commerciali e la produttività. Entro il 2100, il rischio di alluvione potrebbe aumentare del 50% e il rischio di erosione del 13% in tutta la regione mediterranea.