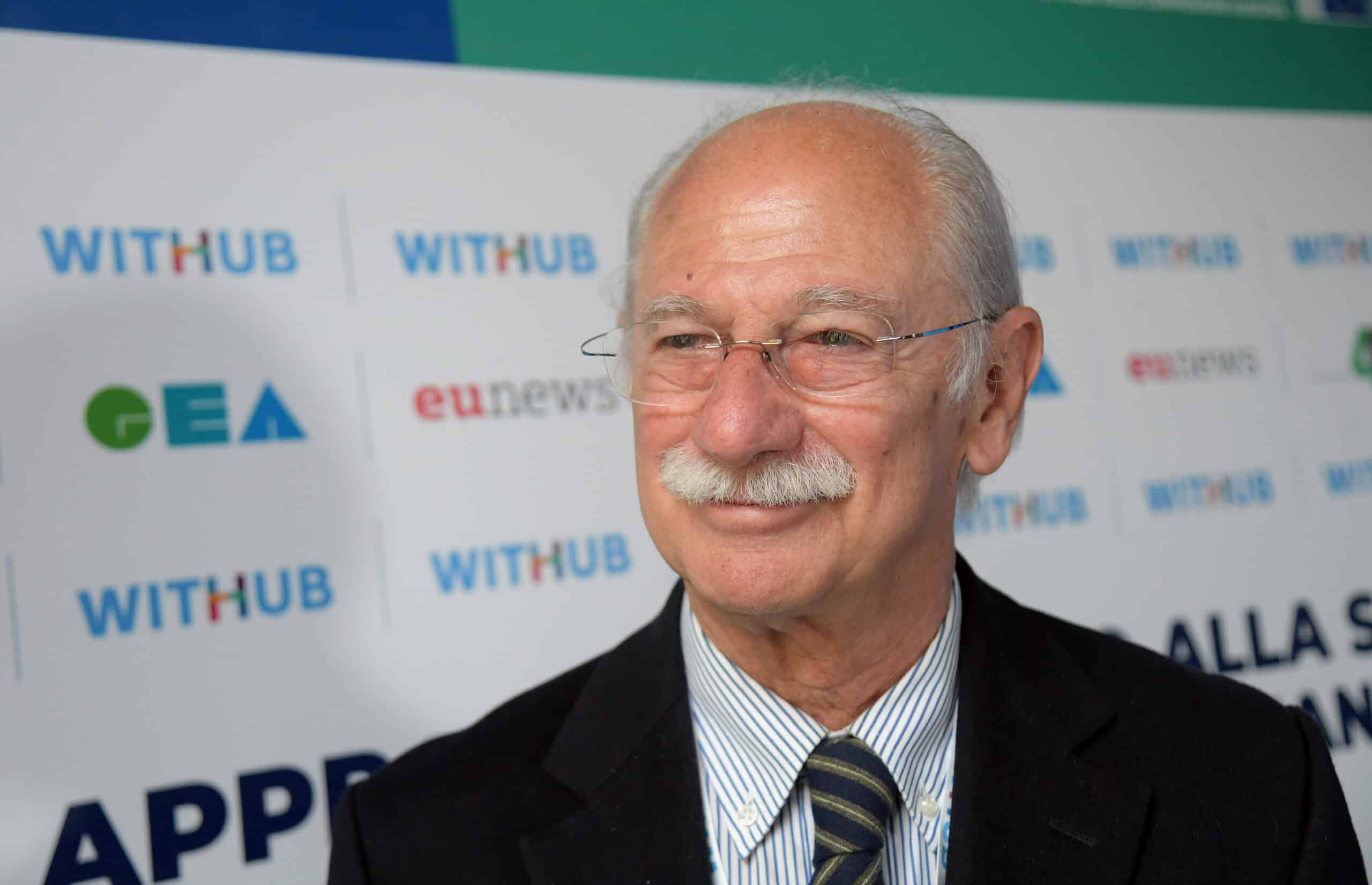Smog, ogni anno il 7,6% delle morti globali è causato dalle polveri sottili
L’esposizione a breve e lungo termine all’inquinamento atmosferico da particolato fine (PM2,5) è legata a un aumento del rischio di ricovero in ospedale per gravi malattie cardiache e polmonari: è quanto emerge da due ampi studi statunitensi, pubblicati da The BMJ. Insieme, i risultati suggeriscono che non esiste una soglia di sicurezza per la salute di cuore e polmoni.
Secondo lo studio Global Burden of Disease, l’esposizione al PM2,5 è responsabile di circa il 7,6% della mortalità totale a livello globale e del 4,2% degli anni di vita aggiustati per la disabilità (una misura degli anni vissuti in buona salute). Alla luce di queste numerose evidenze, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha aggiornato le linee guida sulla qualità dell’aria nel 2021, raccomandando che i livelli medi annuali di PM2,5 non superino i 5 μg/m3 e quelli nelle 24 ore non superino i 15 μg/m3 per più di 3-4 giorni all’anno.
Nel primo studio, i ricercatori hanno collegato i livelli medi giornalieri di PM2,5 ai codici di avviamento postale delle abitazioni di quasi 60 milioni di adulti statunitensi (84% bianchi, 55% donne) di età pari o superiore a 65 anni dal 2000 al 2016. Hanno poi utilizzato i dati dell’assicurazione Medicare per monitorare i ricoveri ospedalieri per una media di otto anni. Dopo aver tenuto conto di una serie di fattori economici, sanitari e sociali, l’esposizione media al PM2,5 nell’arco di tre anni è stata associata a un aumento del rischio di primi ricoveri ospedalieri per sette tipi principali di malattie cardiovascolari: cardiopatia ischemica, malattie cerebrovascolari, insufficienza cardiaca, cardiomiopatia, aritmia, cardiopatia valvolare e aneurismi dell’aorta toracica e addominale.
Rispetto a esposizioni pari o inferiori a 5 μg/m3 (la linea guida dell’OMS sulla qualità dell’aria per il PM2,5 annuale), le esposizioni tra 9 e 10 μg/m3, che comprendevano la media nazionale statunitense di 9,7 μg/m3 durante il periodo di studio, erano associate a un aumento del 29% del rischio di ricovero ospedaliero per malattie cardiovascolari. Su scala assoluta, il rischio di ricovero in ospedale per malattie cardiovascolari è aumentato dal 2,59% con esposizioni pari o inferiori a 5 μg/m3 al 3,35% con esposizioni comprese tra 9 e 10 μg/m3. “Questo significa che se riuscissimo a ridurre il PM2,5 annuale al di sotto di 5 µg/m3, potremmo evitare il 23% di ricoveri ospedalieri per malattie cardiovascolari”, dicono i ricercatori.
Questi effetti cardiovascolari persistono per almeno tre anni dopo l’esposizione al PM2,5 e la suscettibilità varia in base all’età, all’istruzione, all’accesso ai servizi sanitari e al livello di deprivazione dell’area. I ricercatori affermano che i risultati suggeriscono che non esiste una soglia di sicurezza per l’effetto cronico del PM2,5 sulla salute cardiovascolare complessiva e che si potrebbero ottenere benefici sostanziali aderendo alle linee guida dell’OMS sulla qualità dell’aria.
Nel secondo studio, i ricercatori hanno utilizzato le concentrazioni giornaliere di PM2,5 a livello di contea e i dati delle dichiarazioni mediche per monitorare i ricoveri ospedalieri e le visite al pronto soccorso per cause naturali, malattie cardiovascolari e respiratorie per 50 milioni di adulti statunitensi di età superiore ai 18 anni dal 2010 al 2016. Durante il periodo di studio, sono stati registrati più di 10 milioni di ricoveri ospedalieri e 24 milioni di visite al pronto soccorso.
È emerso che l’esposizione a breve termine al PM2,5, anche a concentrazioni inferiori al nuovo limite guida dell’OMS per la qualità dell’aria, era associata in modo statisticamente significativo a tassi più elevati di ricoveri ospedalieri per cause naturali, malattie cardiovascolari e respiratorie, nonché a visite al pronto soccorso per malattie respiratorie. Ad esempio, nei giorni in cui i livelli giornalieri di PM2,5 erano al di sotto del nuovo limite di riferimento dell’OMS per la qualità dell’aria di 15 μg/m3, un aumento di 10 μg/m3 di PM2,5 è stato associato a 1,87 ricoveri ospedalieri in più al giorno per milione di adulti di età superiore ai 18 anni.
Entrambi i team di ricerca riconoscono diversi limiti, come la possibile errata classificazione dell’esposizione, e sottolineano che altri fattori non misurati possono aver influenzato i risultati. Inoltre, i riscontri potrebbero non essere applicabili agli individui senza assicurazione medica, ai bambini e agli adolescenti e a coloro che vivono fuori dagli Stati Uniti. Tuttavia, nel complesso, questi nuovi risultati forniscono un valido riferimento per i futuri standard nazionali sull’inquinamento atmosferico.


 Con questa iniziativa si “mettono le radici gli obiettivi che ci eravamo dati con il Libro Bianco del Verde: riportare la natura nelle nostre città e preservare le nostre aree verdi, facendole rifiorire grazie alle competenze di coloro che operano nel settore”,
Con questa iniziativa si “mettono le radici gli obiettivi che ci eravamo dati con il Libro Bianco del Verde: riportare la natura nelle nostre città e preservare le nostre aree verdi, facendole rifiorire grazie alle competenze di coloro che operano nel settore”,