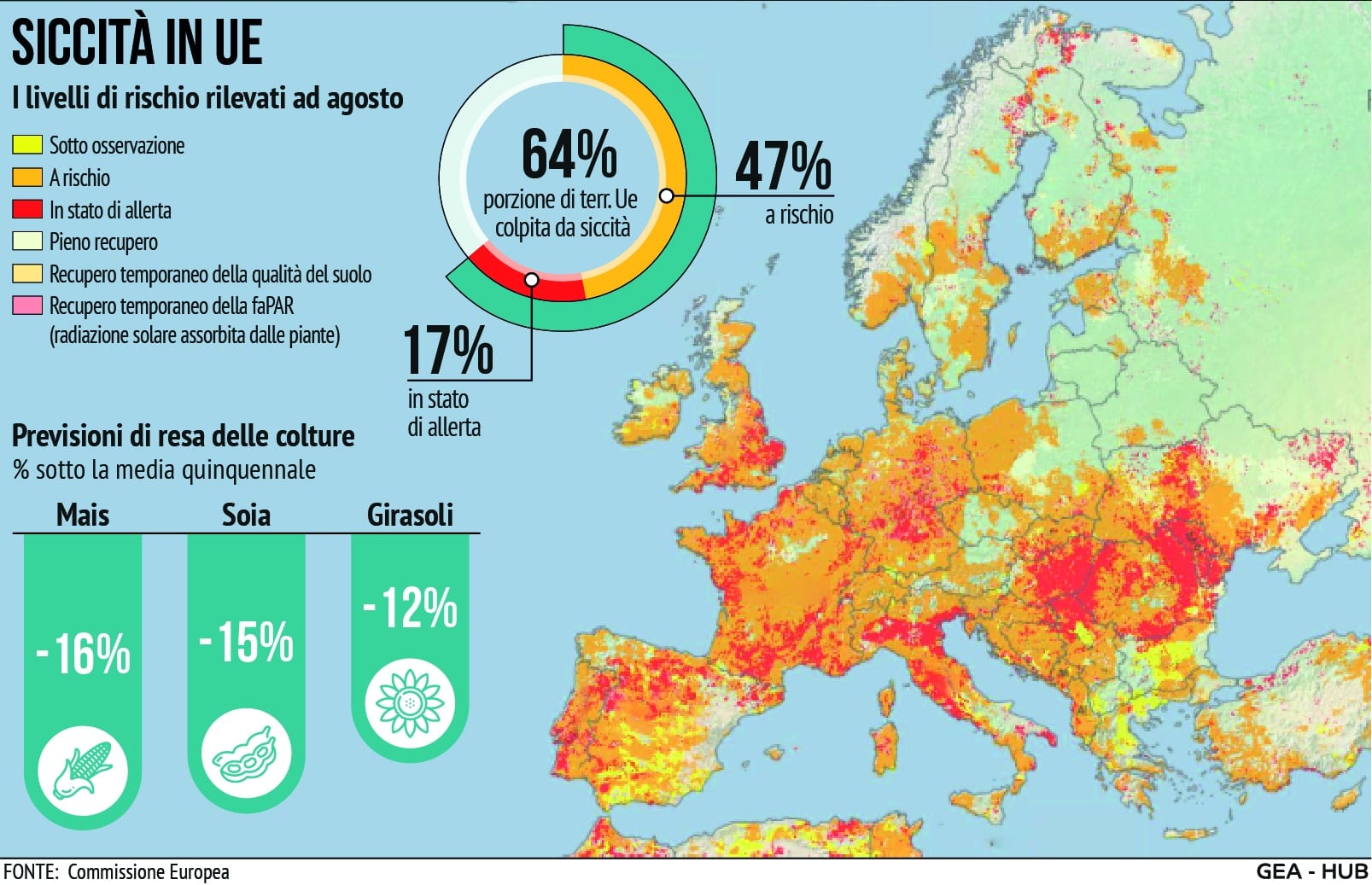La proposta al vaglio dei governi: price cap sul gas a 275 euro/MWh
Un meccanismo di correzione del mercato da attivare automaticamente di fronte a picchi di prezzo sul mercato olandese usato per le transazioni nell’Ue, il TTF (Title Transfer Facility). Dopo non poche indecisioni, è da Strasburgo (dove è riunito l’Europarlamento) che la Commissione europea ha avanzato oggi nei dettagli la proposta per introdurre uno strumento temporaneo di correzione del mercato (MCM – Market Correction Mechanism), di cui la scorsa settimana aveva presentato ai governi uno schema privo dei dettagli essenziali, tra cui il prezzo di riferimento per farlo scattare.
Il nome tecnico scelto dall’esecutivo è quello di un meccanismo di correzione del mercato, ma nei fatti si traduce in un prezzo massimo “di sicurezza” da applicare in automatico sulle transazioni quando sono soddisfatte due condizioni contemporaneamente: quando il prezzo del gas sul TTF supera i 275 euro per megawattora (MWh) per un periodo di due settimane e quando i prezzi del gas sul TTF sono superiori di 58 euro rispetto al prezzo di riferimento del GNL per 10 giorni consecutivi nelle due settimane di scambi. Il prezzo di riferimento del GNL viene calcolato sulla media giornaliera di un paniere di parametri di riferimento globali, tra cui la Commissione Ue cita il Mercato Spot Giornaliero del Mediterraneo, il Mercato Spot Giornaliero dell’Europa Nordoccidentale.
Di fronte a entrambe le condizioni, ha chiarito Simson in conferenza stampa, il tetto massimo che impedisce le transazioni sul mercato olandese si applicherebbe automaticamente, senza un ulteriore passaggio decisionale a livello politico. Nello specifico, la proposta della Commissione prevede che sia l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) a pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale Ue, informandone l’Esecutivo europeo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e la Banca centrale europea (BCE). Proprio a queste tre autorità di controllo, insieme al Gas Coordination Group e all’European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSO-G), spetta il compito di monitoraggio dello strumento e della sicurezza dell’approvvigionamento in Ue. La commissaria estone ha assicurato il meccanismo è progettato “per essere efficace”, ma senza compromettere la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Ue. Come ‘freno di emergenza’, la Commissione ha previsto che il meccanismo possa essere sospeso o disattivato a seconda dei casi attraverso due procedimenti diversi: può essere disattivato automaticamente quando la seconda condizione di attivazione (ovvero la differenza tra il prezzo TTF e il prezzo di riferimento del GNL) viene meno per dieci giorni; oppure, la Commissione europea propone che possa essere solo sospeso (dietro decisione della Commissione stessa) “quando ci sono rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione”, ha chiarito Simson. Secondo la Commissione, la proposta dovrebbe entrare in vigore già dal 1° gennaio 2023 e restare in vigore per un anno, fa leva sull’articolo 122 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dunque prevede l’approvazione a maggioranza qualificata degli Stati membri al Consiglio (quando il 55% degli Stati membri vota a favore, ovvero 15 paesi su 27; e quando gli Stati membri che appoggiano la proposta rappresentano almeno il 65% della popolazione totale dell’Ue).
La prima occasione di confronto e dibattito tra gli Stati membri sarà domani nella riunione degli ambasciatori dei 27 stati membri che si incontreranno al Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti presso l’Ue. Ma il primo confronto a livello politico sulla questione sarà giovedì al Consiglio Energia che si terrà a Bruxelles, dove i ministri sono chiamati a dare il via libera al terzo pacchetto di misure di emergenza presentato dalla Commissione lo scorso 18 ottobre (che comprende l’obbligo di acquisti congiunti di gas e solidarietà in caso di tagli alle forniture) e alla proposta di regolamento per accelerare i permessi sulle infrastrutture energetiche rinnovabili. Sul price cap, visti i tempi stretti, si prevede solo un primo confronto, fonti europee chiariscono che è troppo ottimistico sperare in un accordo già in settimana. I ministri dell’energia hanno in programma, da calendario, un’altra riunione il 6 dicembre, ma non è da escludere che la questione possa finire direttamente sul tavolo dei capi di stato e governo il 15-16 dicembre al Vertice Ue.
La soglia dei 275 euro/MWh è stata stabilita dopo varie indecisioni da parte de, scelta accuratamente alta in parte perché la Commissione europea spera di non attivare mai il meccanismo (lo vuole usare da deterrente) in parte perché sa che nei negoziati gli Stati membri giocheranno al ribasso per abbassarla. La maggior parte dei governi sposa l’idea di un limite di prezzo che si aggira tra i 150-180 euro per megawattora. Ad agosto, il mese che viene preso come riferimento per il picco, i prezzi si sono avvicinati ai 310 euro/MWh ma non sono mai andati oltre la soglia dei 275 euro/MWh per un periodo consecutivo di due settimane, il che rende improbabile che a queste condizioni il cap sia attivato realmente.
Motivo di attrito con i governi sulla proposta sarà quindi la fascia di prezzo, ma sicuramente anche il fatto che la decisione di sospendere il meccanismo rimarrebbe in capo alla Commissione europea. E’ sicuro che gli Stati membri, in sede di negoziato politico, cercheranno di spostare l’asse delle competenze sulla sospensione del meccanismo al Consiglio stesso.