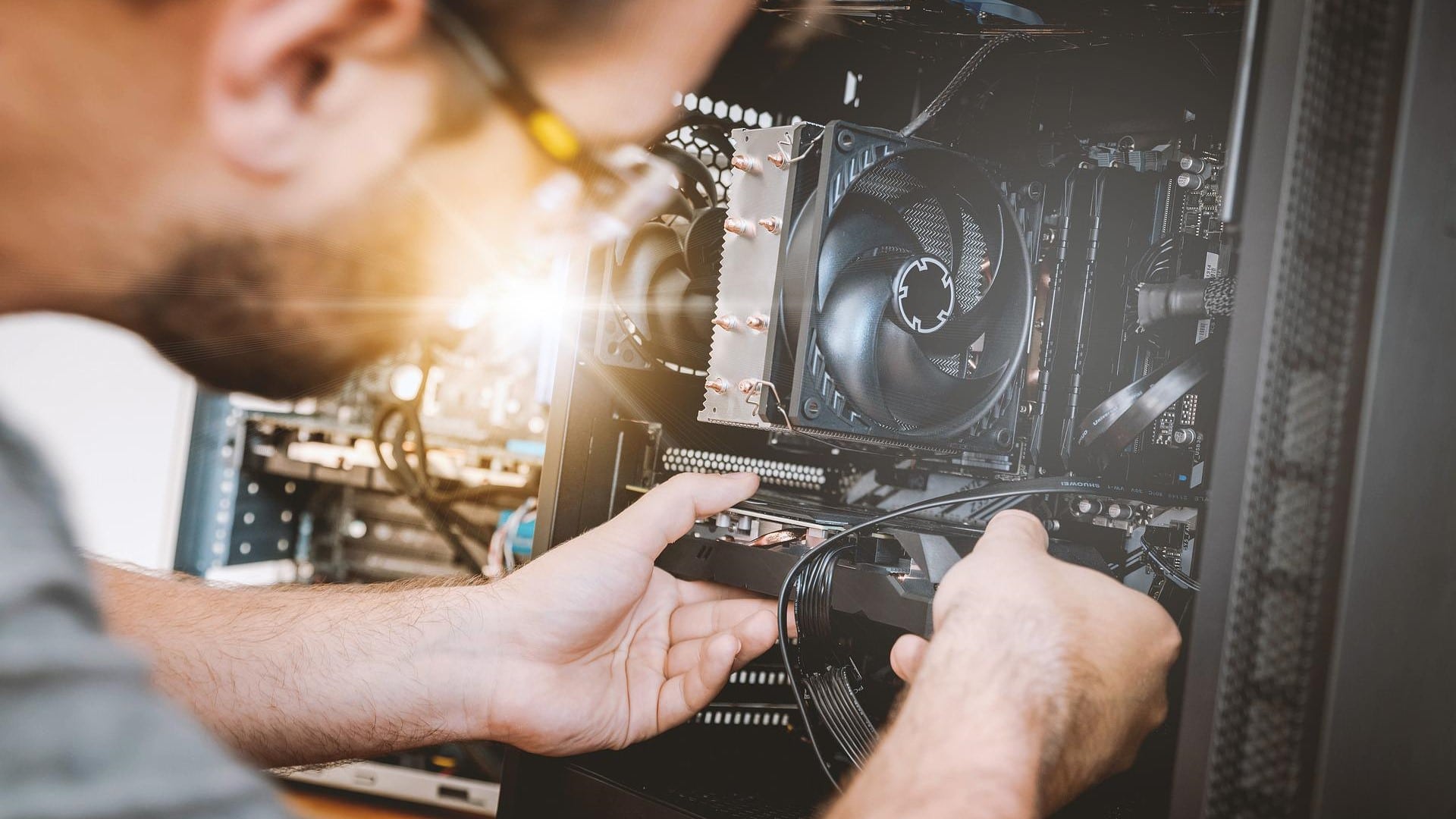
Cavazzini (Verdi): “In Ue diritto alla riparazione diventi storia di successo”
Il diritto alla riparazione come perno della strategia dell’Unione Europea per contrastare l’obsolescenza programmata e le pratiche sleali in ambito digitale, ma soprattutto per cercare di mettere un freno a uno spreco di rifiuti elettronici che ormai ammonta a 11mila tonnellate ogni anno nell’Ue. In attesa della proposta della Commissione Europea – annunciata dal gabinetto guidato da Ursula von der Leyen entro l’autunno 2022 – sono gli eurodeputati a voler fare da pungolo per alzare il più in alto possibile l’asticella delle ambizioni comunitarie. In particolare è questa l’intenzione della presidente della commissione per il Mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) del Parlamento Ue e relatrice sul diritto alla riparazione, Anna Cavazzini. In un’intervista rilasciata a GEA – Green Economy Agency, l’eurodeputata tedesca del gruppo Verdi ha spiegato quali sono le prerogative dell’Eurocamera e come fare di questa iniziativa un vero punto di svolta per i diritti dei cittadini dell’Unione.
Presidente Cavazzini, qual è la linea rossa per il Parlamento Europeo in vista dell’imminente proposta della Commissione sul diritto alla riparazione?
“Il Parlamento ha definito chiaramente la sua posizione, ci aspettiamo che la Commissione si occupi del nucleo centrale del diritto alla riparazione, ovvero l’accesso ai pezzi di ricambio e ai manuali per gli attori del settore, compresi i consumatori. Abbiamo bisogno di migliori informazioni sulla durata e sulla riparabilità per consentire acquisti sostenibili. Allo stesso tempo, gli incentivi alla riparazione, anziché alla sostituzione, devono trovare riscontro nelle garanzie, nella responsabilità estesa del produttore e negli appalti pubblici”.
Quale parte della proposta rischia di essere la più critica?
“Dobbiamo fare in modo che i prodotti facilmente riparabili diventino una storia di successo non solo per i consumatori e il pianeta, ma anche per le imprese, i commercianti e i produttori. Abbiamo bisogno di un indice di riparazione che convinca i consumatori a spendere un po’ di più al momento dell’acquisto, ma solo se il prodotto dura di più. Questa richiesta sarà un incentivo per le aziende a passare alla riparabilità in fase di progettazione”.
C’è il pericolo che l’obsolescenza programmata rimanga nella pratica?
“L’obsolescenza programmata è particolarmente difficile da bandire, poiché molti operatori del settore ne negano l’esistenza. Inoltre, attualmente è il consumatore a doverla dimostrare. Ecco perché è necessaria un’inversione dell’onere della prova sul produttore, oltre all’inclusione dell’obsolescenza programmata nell’elenco delle pratiche commerciali sleali”.
A oggi abbiamo però una proposta della Commissione sulla modifica della direttiva sui diritti dei consumatori, a proposito della durata e riparabilità dei prodotti. Qual è la sua opinione?
“La proposta della Commissione sull’aggiornamento dei diritti dei consumatori va nella giusta direzione: le scelte sostenibili promuoveranno la transizione verde e l’economia circolare. Anche per quanto riguarda la riparabilità e la durata dei prodotti , le informazioni affidabili per i consumatori sono fondamentali. Siamo anche soddisfatti di vedere che la Commissione sta affrontando la questione dell’obsolescenza programmata, anche noi vorremmo un divieto totale”.
Quali altre iniziative possono essere adottate per implementare il concetto di diritto alla riparazione?
“Alcuni degli elementi fondamentali del diritto alla riparazione possono essere affrontati modificando, per esempio, la direttiva sulle vendite di beni che regola le garanzie: in caso di rottura di un prodotto, l’opzione della riparazione dovrebbe essere preferibile alla sostituzione. Servono poi ulteriori incentivi per rendere la riparazione la prima scelta dei consumatori, attualmente è troppo costosa e troppo lenta”.
E come risolvere il problema dei costi?
“Può essere affrontato a livello di Stati membri. Per esempio, attraverso la riduzione dell’Iva per i servizi di riparazione. Il ritmo delle riparazioni sarà più veloce quando questo mercato non sarà più disfunzionale e ci saranno più attori, non solo le officine autorizzate”.
Un’ultima domanda. Come possiamo stimare il contributo del diritto alla riparazione al Green Deal europeo?
“Il diritto alla riparazione funziona su entrambi i fronti nella transizione verso un’economia circolare. Da una parte, consente ai consumatori di riparare invece di buttare e comprare di più. Dall’altra, si risparmiano risorse mantenendo i prodotti in uso più a lungo. Insieme al riciclo alla fine del ciclo di vita, è un elemento tangibile del Green Deal europeo, che contribuirà a proteggere il clima e l’ambiente”.
(Photo credits: Jan Vašek)








