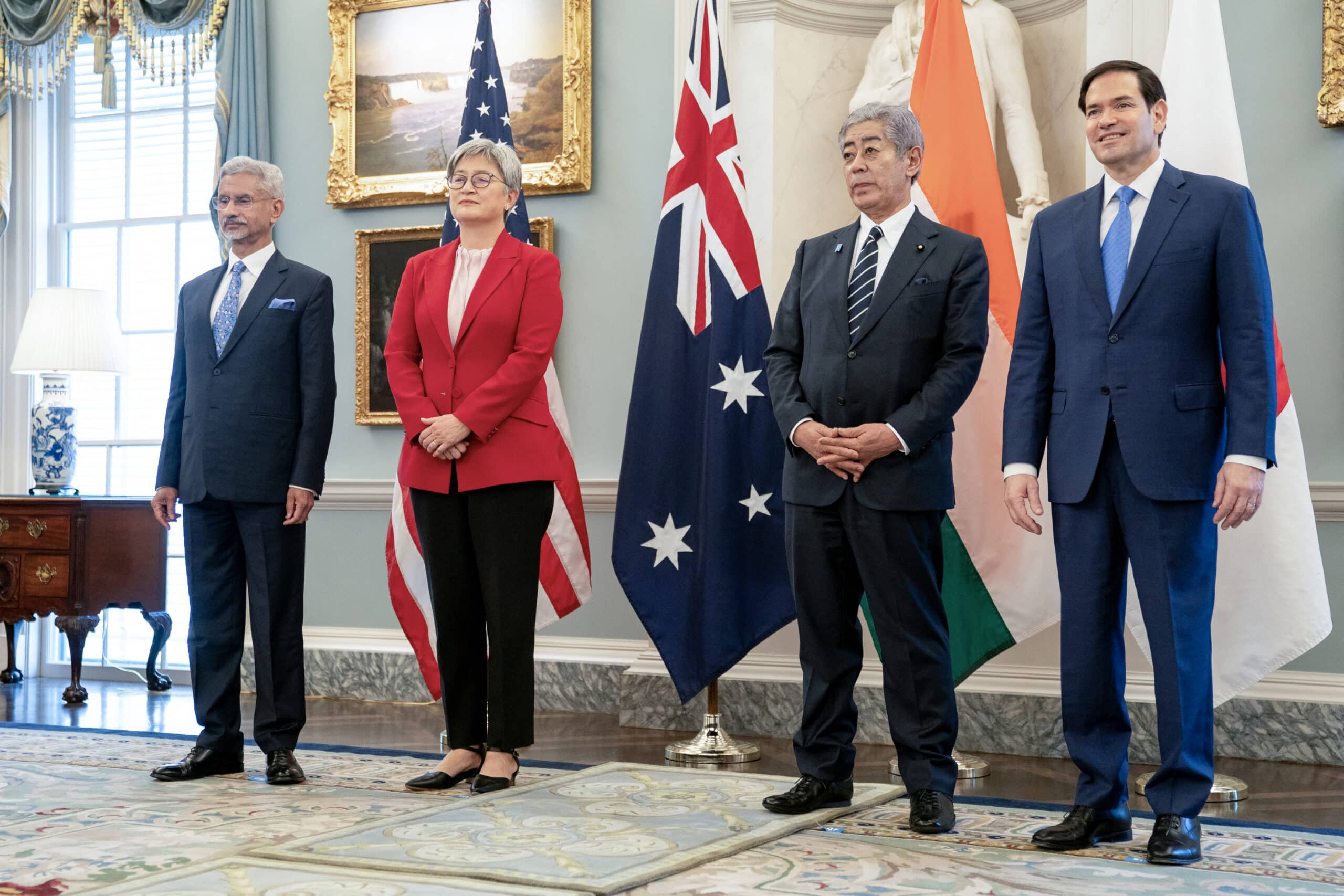Transizione energetica, correggere il tiro prima che sia troppo tardi
Il dibattito politico ed economico internazionale è segnato da tempo dal tema della ‘transizione energetica’, ma gli ultimi diciotto mesi hanno mostrato chiaramente come questo obiettivo sia molto più sfidante e complesso di quello che si poteva immaginare. Da molte parti, senza mettere in questione l’obiettivo della decarbonizzazione che tutti condividono, si sottolinea che esso va perseguito con razionalità e pragmatismo, abbandonando visioni estremiste e unilaterali che hanno messo in secondo piano problemi importantissimi come la sicurezza energetica e la disponibilità di materie prime necessarie per la transizione.
Anche negli Usa e in Europa, aree nelle quali sono state adottate misure imponenti per perseguire l’obiettivo della transizione e della decarbonizzazione (come ad esempio l’Inflation Reduction Act negli Usa e il RePowerEu in Europa), lo sviluppo, la diffusione e la crescita delle nuove tecnologie su cui si basa la transizione avverrà in un tempo molto più lungo di quello inizialmente previsto. E ciò perché le economie sviluppate non sono in grado di passare in pochi anni da un modello economico basato sugli idrocarburi ad un altro basato esclusivamente sulle energie rinnovabili.
E la recente crisi energetica causata dall’aggressione russa dell’Ucraina lo ha mostrato con chiarezza. Il mondo, ad esempio, sta usando oggi tre volte più carbone di quanto ne usasse dieci anni fa, e nel 2022 si è raggiunto il record storico nel consumo di questa fonte di energia. Ciò si deve certamente alla crescita dei fabbisogni energetici di molti Paesi del mondo in via di sviluppo che hanno trovato nel carbone la fonte più conveniente, ma anche al fatto che molti paesi europei, Germania e Italia in testa, che avevano deciso di chiudere le loro centrali elettriche a carbone, hanno dovuto fare marcia indietro per fronteggiare la mancanza di gas e l’esplosione dei prezzi energetici causati dalla guerra.
Alla luce di ciò è lecito porsi la domanda: ma perché le famiglie e le imprese europee, che sono responsabili di non più del 9% delle emissioni mondiali di CO2, devono essere quelle che sopportano di più il peso della transizione? Se per ipotesi tutte le industrie europee, che sono responsabili di meno del 4% di tutte le emissioni mondiali di CO2, chiudessero i battenti contemporaneamente, l’effetto sulle emissioni mondiali e quindi sulla causa primaria del climate change sarebbe insignificante.
In un interessante paper del 2021 del Peterson Institute for International Economics un importante economista francese, Jean Pisani-Ferry, ha affermato che muoversi troppo rapidamente verso l’obiettivo di emissioni zero potrebbe provocare una drammatica crisi dell’offerta industriale, ancora più grave di quella creata dallo shock energetico dell’inizio degli anni 70 conseguente alla guerra arabo-israeliana. L’economista mette in guardia dal fatto che un processo di transizione energetica precipitoso potrebbe provocare disastri, e sollecita i policy makers a rendersene conto e ad assumere le decisioni adeguate.
Quali sono i fatti nuovi che hanno cambiato così radicalmente la prospettiva? Innanzitutto la sicurezza energetica, come detto, è tornata ad essere la priorità. E la sicurezza energetica è fatta di disponibilità di fonti e di prezzi ragionevoli dell’energia. Il Presidente degli Usa Biden ad esempio, benché sia molto concentrato sugli obiettivi della transizione, nel corso dell’ultimo anno ha sollecitato le compagnie petrolifere nazionali a incrementare la produzione, così da aumentare le Strategic Petroleum Reserve come non era mai avvenuto con le precedenti Amministrazioni.
I verdi tedeschi al governo della Germania hanno spinto moltissimo per aumentare la capacità di impianti di rigassificazione del Paese, così da incrementare significativamente le importazioni di LNG (gas naturale liquido) dagli Stati Uniti. E in non più di 200 giorni la Germania è stata capace di dotarsi di nuovi rigassificatori galleggianti come quelli che dobbiamo fare anche in Italia, ma che sono in ritardo a Piombino per l’opposizione del Sindaco, che proviene dalle fila del partito del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
La seconda questione riguarda la dimensione del problema. Oggi 100 trilioni di dollari Usa (centomila miliardi di dollari!) dell’economia mondiale dipendono da più dell’80% di approvvigionamento energetico da idrocarburi, e nulla come un così gigantesco e complesso sistema energetico mondiale può essere rapidamente e facilmente cambiato. In un interessante volume fresco di stampa, ‘How The World Really Works’, di uno studioso di economia dell’energia, Vaclav Smil, si sottolinea come i quattro pilastri della moderna civilizzazione – cemento, acciaio, plastica e ammonio (per i fertilizzanti) – siano ciascuno fortemente dipendente dall’attuale sistema energetico.
C’è poi un terzo punto fondamentale: la divisione tra Nord e Sud del mondo. Nell’emisfero Nord del mondo, in particolare Stati Uniti d’America e Europa, il tema del climate change è al primo posto dell’agenda politica. Ma nell’emisfero Sud questa priorità coesiste con altre priorità come la promozione della crescita economica, la riduzione della povertà e il miglioramento della qualità della vita e della salute con la riduzione della combustione di legno e rifiuti attraverso un uso più intenso del gas naturale.
Questa divisione è stata plasticamente rappresentata lo scorso anno da un voto di denuncia e censura del Parlamento Europeo (di cui i media a dire il vero hanno parlato assai poco) relativo alla costruzione di una nuova pipeline per il gas dall’Uganda attraverso la Tanzania fino all’Oceano Indiano.
Il Parlamento Europeo ha stigmatizzato e condannato la realizzazione di questa infrastruttura perché il progetto poteva avere aspetti negativi per il clima, l’ambiente e ‘i diritti umani’. Nello stesso tempo lo stesso Parlamento dava il suo voto favorevole per un’infrastruttura analoga tra la Francia e il Belgio, paesi nei quali il reddito pro-capite è rispettivamente 50 e 60 volte maggiore di quello dell’Uganda, dove la nuova pipeline è vista come un fattore determinante per lo sviluppo del Paese. La risoluzione europea ha provocato in Africa reazioni furiose. Lo speaker del parlamento dell’Uganda ha denunciato l’atteggiamento europeo come il migliore esempio “dell’alto livello di neocolonialismo e di imperialismo contro la sovranità dell’Uganda e della Tanzania”.
Il quarto nodo è rappresentato dai fabbisogni di nuovi materiali per la transizione. L’elettrificazione dei sistemi energetici, industriali e di trasporto alla base della transizione richiede un’enormità di nuove materie prime: rame, cobalto, nickel, litio e terre rare, che possono essere reperite soltanto con nuove e intensive attività minerarie enormemente energivore. Si pone il serio problema dell’aumento esponenziale della loro produzione, che se si guardano i numeri è stato giustamente definito sconvolgente: entro il 2040 la produzione di nickel dovrà crescere di 41 volte, quella di cobalto 21 volte, quella di rame di 28 volte e quella di graffite di 28 volte. Perché un così grande consumo di queste materie prime? Semplice: in termini di chilogrammi di minerali necessari per la produzione di un megawatt di energia elettrica gli impianti eolici offshore ne richiedono 16 tonnellate, il solare fotovoltaico 6,8, quando una centrale turbogas chiede appena 1,1 tonnellate. Le energie convenzionali compreso il nucleare sembrano tutte essere assai meno consumatrici di minerali di quanto non siano le fonti rinnovabili (naturalmente solo per la costruzione degli impianti).
E con riferimento all’offerta? Scrive Marcello Minenna su ‘Il Sole 24 Ore’ di domenica scorsa: “…al ritmo attuale di estrazione e considerati i progetti di espansione della produzione già avviati, la domanda globale di rame supererà l’offerta già nel 2025. Non solo. Senza un nuovo piano aggressivo di incremento della capacità produttiva (che vuol dire nuovi giganteschi investimenti minerari) l’offerta comincerà a declinare a partire dal 2024, amplificando il gap con le necessità dell’economia globale. Stesso destino è previsto per il cobalto, con la domanda che supererà l’offerta nel 2024 e nel 2030 dovrebbe essere 2,5 volte maggiore della capacità produttiva globale, prevista sostanzialmente stabile. Per il litio nel 2030 senza uno sforzo senza precedenti per espandere l’estrazione il fabbisogno globale sarebbe 2,5 volte l’offerta”.
Tutto ciò significa come detto nuovi giganteschi investimenti minerari, con altissimi consumi di energia connessi, che la cultura ambientalista vede come il fumo negli occhi. Senza contare che tali fabbisogni sono destinati a creare nuove influenze geo-politiche e nuove dipendenze in particolare a favore della Cina. L’industria chimica cinese raffina il 40% del rame, il 35% del nickel, il 65% del cobalto e il 58% del litio prodotti a livello mondiale. Sulle terre rare si può parlare di monopolio cinese non solo nella produzione ma anche nella raffinazione. Quanto detto dimostra ancora una volta che un approccio ideologico e dogmatico alla transizione energetica rischia di provocare disastri economici e sociali alle economie dell’occidente. Occorre al contrario perseguire la via della neutralità tecnologica, che significa non privilegiare solo le fonti rinnovabili e l’elettrificazione ma anche le altre tecnologie che conducono alla decarbonizzazione di processi, e prodotti come il nucleare di nuova generazione, i biocombustibili e il biogas, le tecnologie di cattura, stoccaggio e utilizzo delle CO2.
La politica deve prendere nota di queste contraddizioni e correggere il tiro sui metodi e sui tempi della transizione energetica prima che sia troppo tardi.