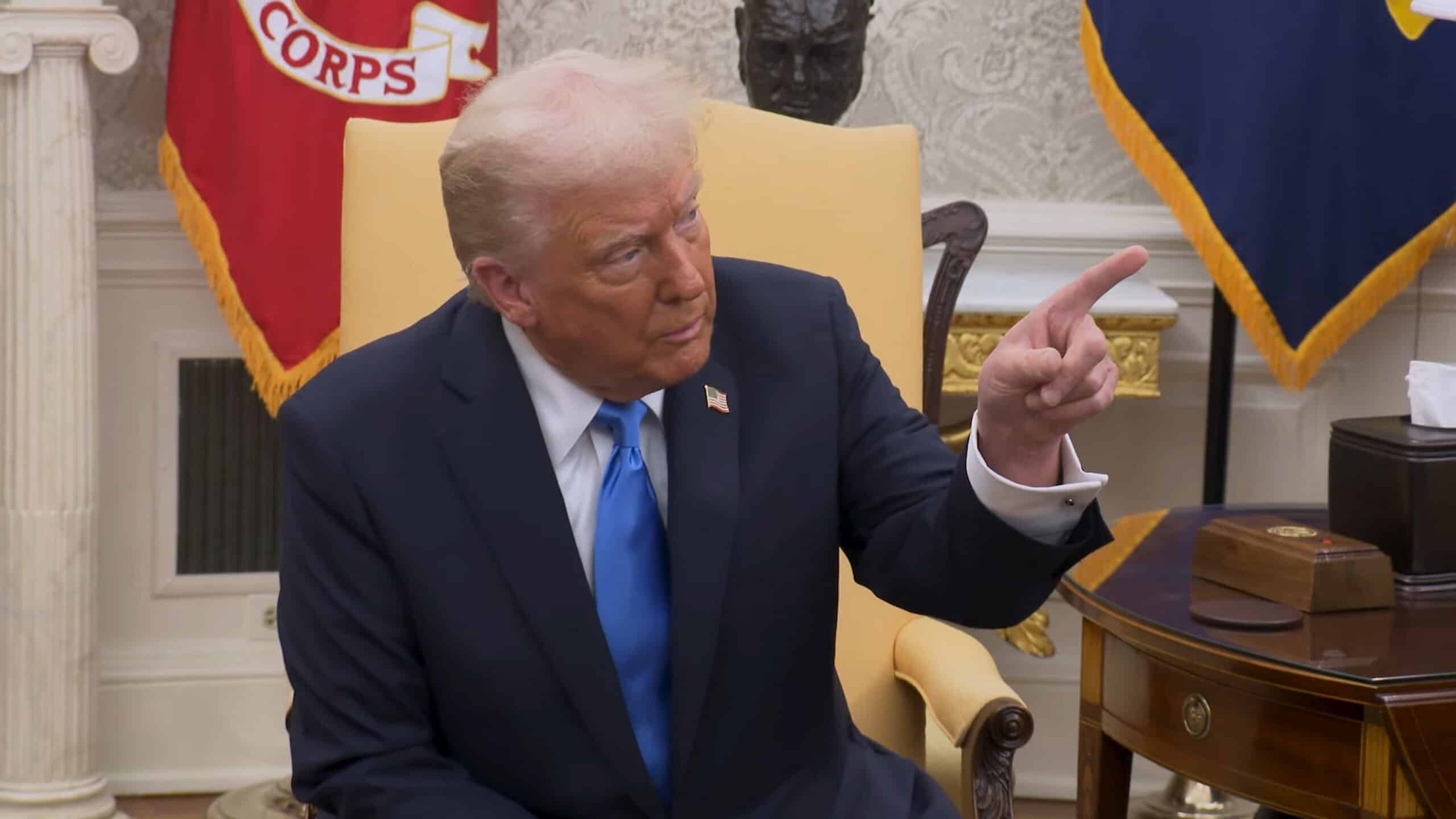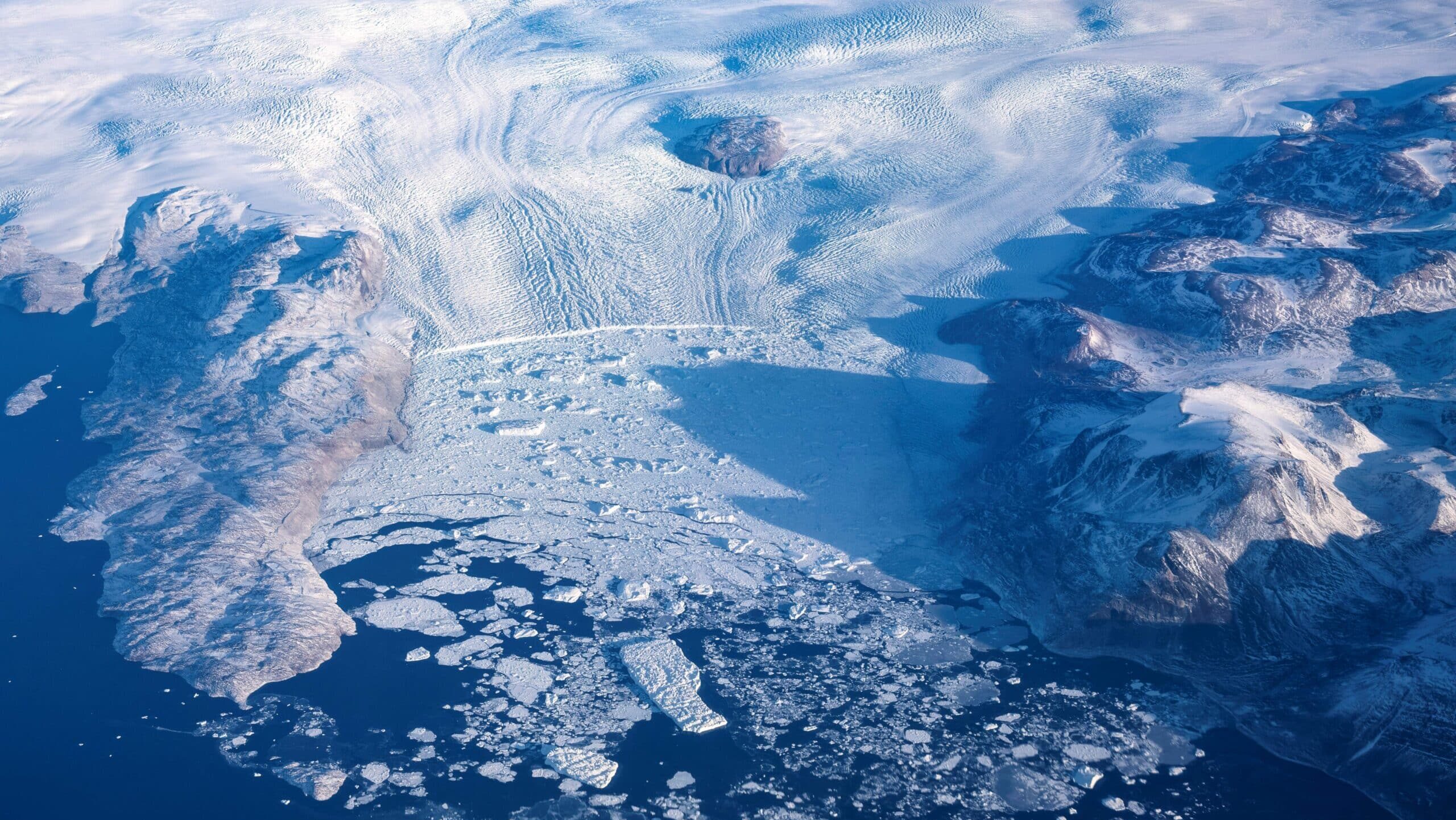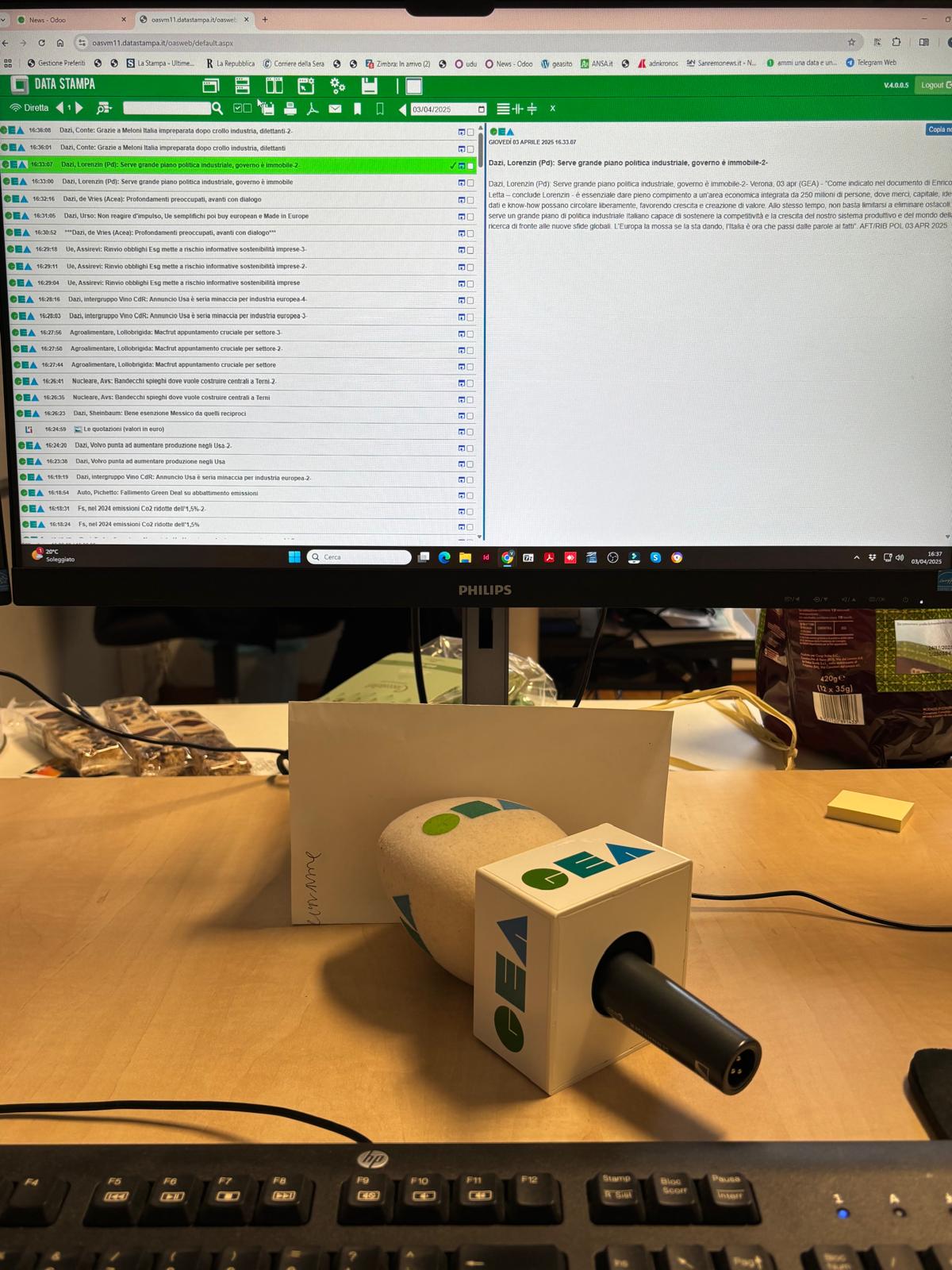
GEA festeggia il terzo compleanno Pronta alle nuove sfide del 2025
Il terzo compleanno, che festeggiamo oggi, segna una svolta nella traiettoria di GEA e nel suo processo di crescita. Il 2024 è stato molto importante ma il 2025 – per come è cominciato – dovrebbe esserlo ancora di più in capo a una serie di dinamiche che, poco alla volta, si stanno accomodando. Non c’erano dubbi sulla bontà del progetto, però pochi pensavano che ce l’avremmo fatta così e così in fretta. Una media di oltre 400 takes al giorno, 15 tra focus, schede e interviste, il supporto della data visualization, il canale video dei GeaTalk: noi siamo questi. Semplicemente e onestamente questi.
Prima di qualsiasi considerazione è doveroso ringraziare chi si è adoperato in azienda per fare crescere l’agenzia che nel 2022 era un’ardita scommessa e che adesso è una felice realtà. Dunque, grazie alle splendide redazioni di Torino, Roma, Milano, Verona e Bruxelles, grazie agli infografisti, grazie alla divisione video, grazie al reparto IT, grazie ai Pm, grazie al reparto commerciale. E grazie, ovviamente, all’editore che continua a credere in un progetto capace di generarne altri, altrettanto ambiziosi. Grazie, infine, alle istituzioni e alle aziende che non smettono di darci fiducia: cercheremo, con umiltà e dedizione al lavoro, di non deludere nessuno.
Il ‘chi si loda si imbroda’ è un antico adagio che suggerisce di rimanere sempre imbullonati alla realtà. E’ un concetto molto sabaudo, il ‘low profile’ come scelta, quasi come vocazione. Ed è proprio per questo che non va rimarcato cosa abbiamo fatto di buono negli ultimi 12 mesi ma è necessario soffermarsi su cosa ci aspetta nei prossimi dodici. Ci facciamo un’unica concessione: abbiamo imparato a volerci bene perché ce lo meritiamo. Ma colleghe e colleghi sanno che ci sarà da pedalare, spesso non in pianura, quasi mai in discesa; che ci attendono appuntamenti ineludibili in un contesto geopolitico delicatissimo e che l’agenzia è solo all’inizio di un lungo cammino; che sarà determinante il consolidamento dei rapporti con il mondo politico e istituzionale; che diventerà decisivo il gemellaggio sempre più stretto con la ‘costola’ Connact nell’ambito di una convegnistica interconnessa tra Roma e Bruxelles.
Insomma, c’è massima convergenza sul fatto che arriverà il momento in cui ognuno avrà quel che si merita, ma per raggiungere quella meta manca ancora un miglio e nessuno di GEA culla illusioni e/o spera in qualche sponda. Come sempre, faremo tutto e lo faremo da soli.
In questi tre anni abbiamo parlato di ambiente, sostenibilità, green deal, energia, economia circolare con passione e obiettività: continueremo a farlo senza sovrastrutture, preservando la nostra verticalità che resta un unicum nel panorama delle agenzie nazionali. Ma lo faremo anche in ambiti che nel recente passato non appartenevano al nostro dna e che hanno allargato il perimetro delle nostre competenze: dalla difesa allo spazio, dalle tlc al pharma, dal turismo alle politiche sociali, fino alla sicurezza e al lavoro, alle guerre in Ucraina e nel Mar Rosso, ai dazi e alle loro ricadute sull’economia.
Riavvolgendo il nastro a quell’ormai lontano 4 aprile 2022, GEA è nata e si sviluppata sulla base di due concetti: la cultura del lavoro e l’indipendenza che determina da sempre la possibilità di esprimersi liberamente. Il resto sono la professionalità e il trasporto di chi si sbatte e combatte tutti i giorni, con l’orgoglio di crescere un prodotto nuovo in un frangente non certo favorevole per l’editoria. Ed è per questo che il nostro compleanno – permettetecelo – vale (un poco) di più.