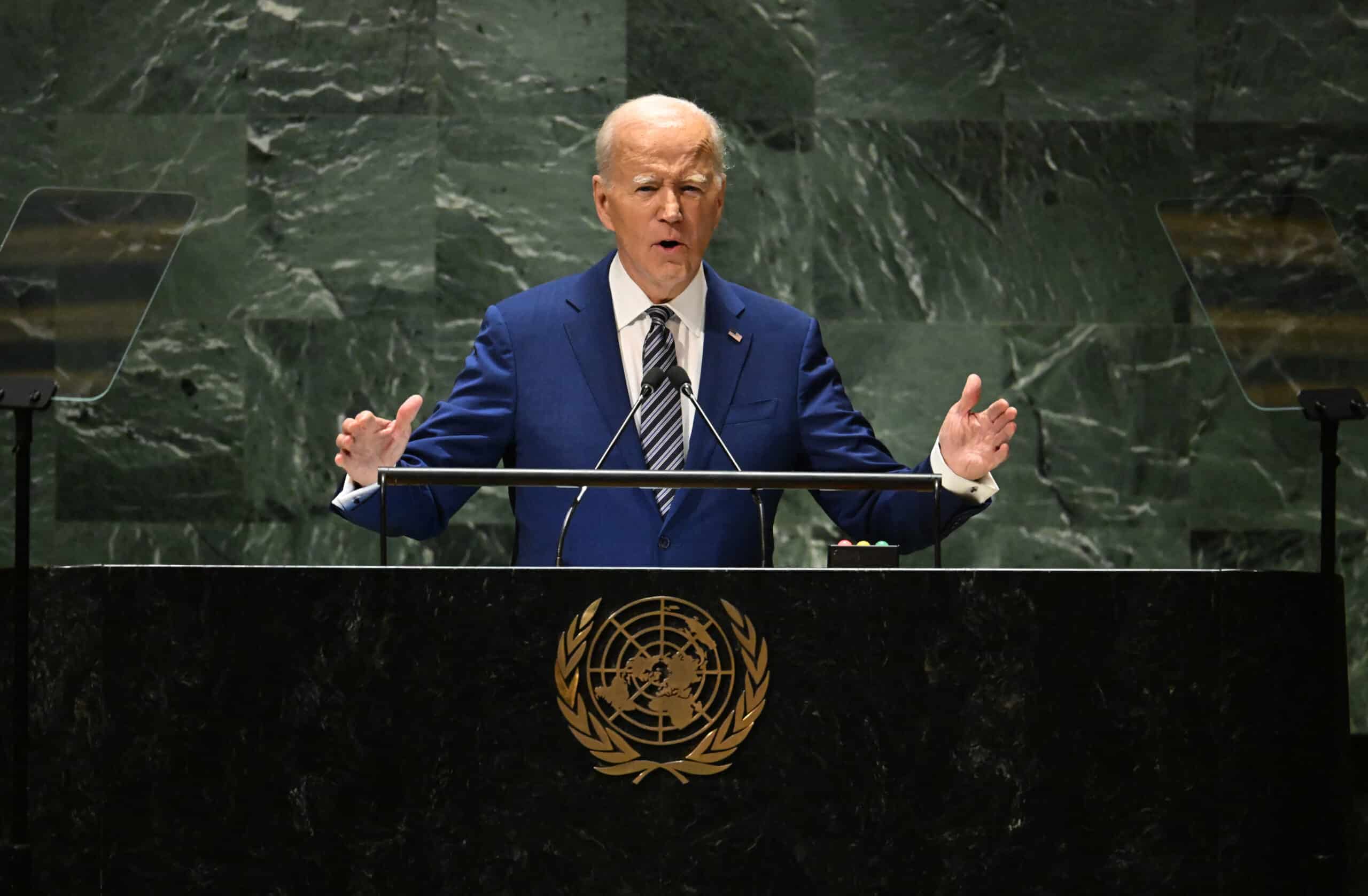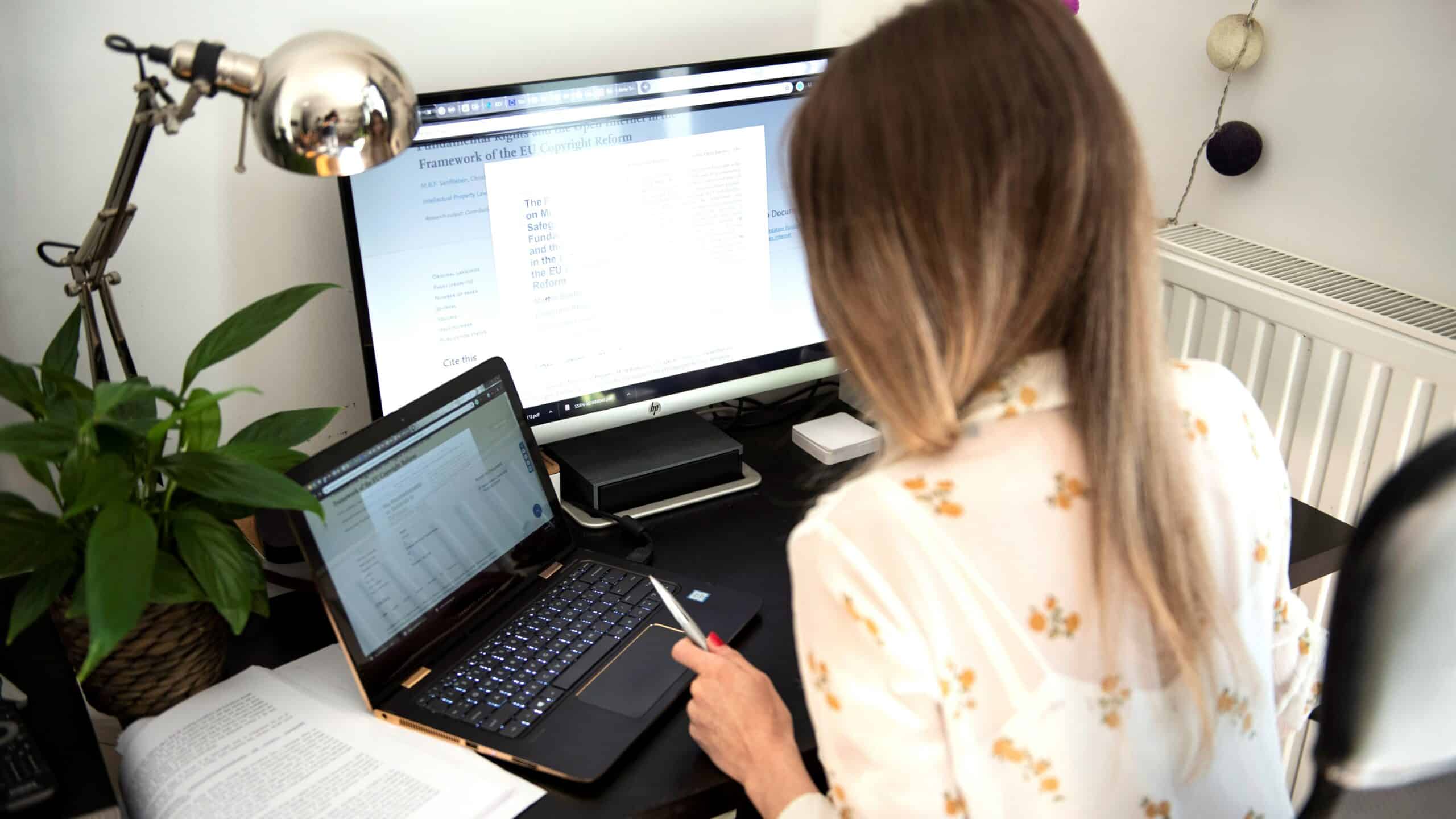L’India verso l’energia pulita: ma gli sforzi non bastano, serve accelerare
L’India deve aumentare la sua capacità di produzione di energia solare di almeno il 36% all’anno per i prossimi cinque anni per raggiungere i suoi obiettivi di mix energetico. E’ quanto emerge da uno studio del think-tank britannico Ember, secondo il quale il Paese ha anche urgente bisogno di modernizzare la rete elettrica e di aumentare la capacità di stoccaggio per far fronte alla natura intermittente delle fonti di energia rinnovabili.
Il rapporto, tuttavia, evidenzia segnali di progresso nel Paese più popoloso del mondo, che dipende in larga misura dal carbone, una fonte energetica altamente inquinante, per la produzione di energia. Secondo Ember, gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili sono in aumento e quest’anno l’India ha commissionato un numero record di pannelli solari.
Il rapporto si basa sul National Electricity Plan (NEP) del Paese, presentato quest’anno. Questo documento, che guarda al 2032, prevede che l’India continuerà a fare affidamento sul carbone, ma con le energie rinnovabili che rappresenteranno una quota sempre maggiore del suo mix di generazione elettrica.
Se nel 2022 l’energia solare rappresentava solo il 5% della produzione totale di elettricità dell’India, il NEP prevede che raggiungerà il 25% entro un decennio. Ma per raggiungere questo obiettivo, la capacità dovrà essere aumentata massicciamente ogni anno per almeno i prossimi cinque anni, secondo Ember.
L’India ha anche bisogno di più soluzioni di stoccaggio per far fronte alla variabilità della produzione di energia solare ed eolica, con il rischio di blackout. Ospite del G20 di quest’anno, ha visto le sue emissioni pro capite di carbone aumentare del 29% negli ultimi sette anni e ha evitato qualsiasi politica volta a ridurre gradualmente il carbone. Nuova Delhi ha annunciato l’obiettivo della neutralità del carbonio entro il 2070, in ritardo rispetto a molti altri Paesi.