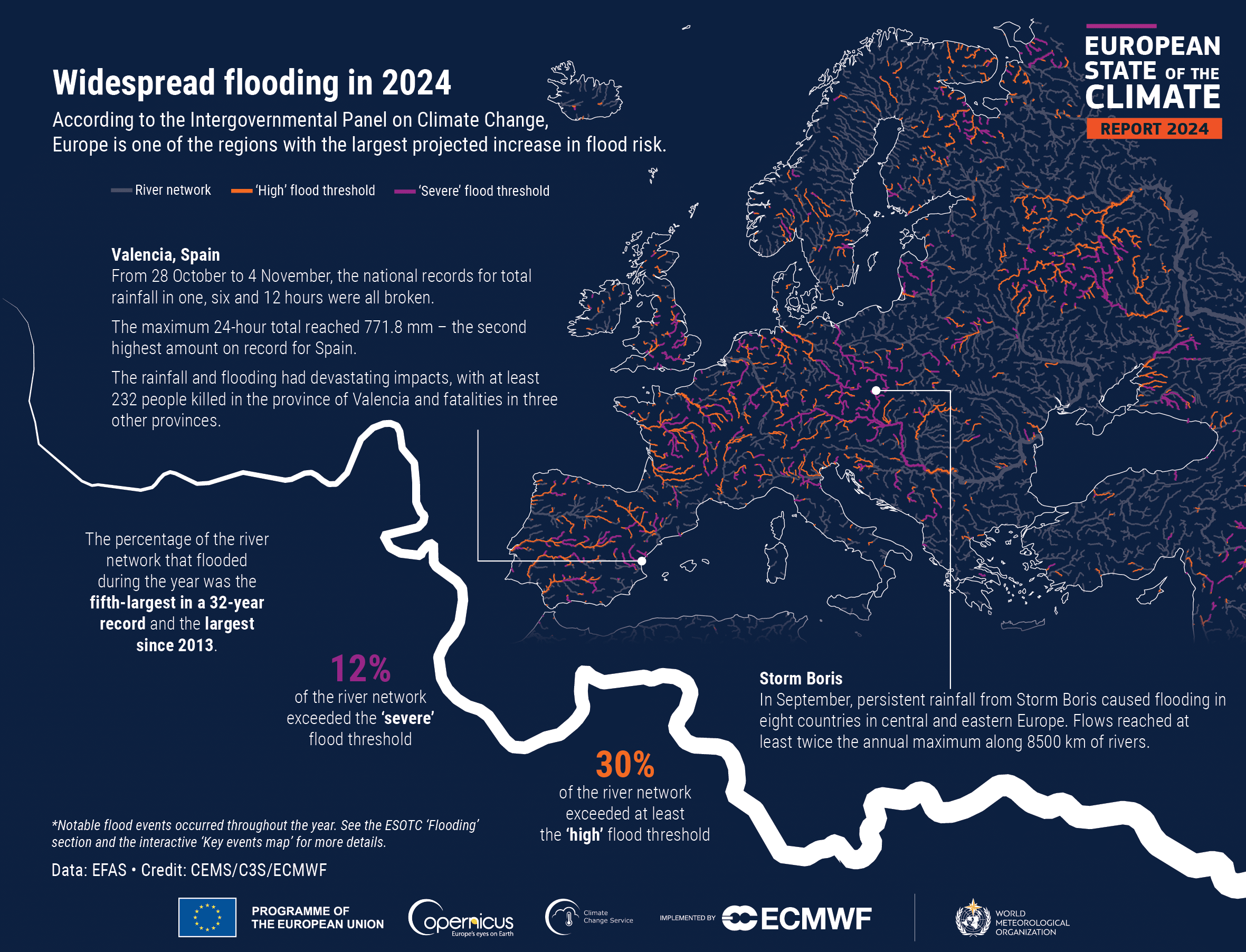Clima, aprile 2025 da record: è il secondo più caldo di sempre
Le temperature globali sono rimaste a livelli storicamente elevati nel mese di aprile, proseguendo una serie di quasi due anni di caldo senza precedenti sul pianeta che sta sconvolgendo la comunità scientifica sulla velocità del riscaldamento globale. A livello globale, aprile 2025 è il secondo mese più caldo dopo aprile 2024, come riferisce l’osservatorio europeo Copernicus, che si basa su miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, stazioni meteorologiche e altri strumenti.
Il mese scorso ha così prolungato una serie ininterrotta di record o quasi record di temperature che dura dal luglio 2023, ovvero da quasi due anni. Da allora, con una sola eccezione, tutti i mesi sono stati almeno 1,5 °C più caldi rispetto alla media dell’era preindustriale (1850-1900).
Tuttavia, molti scienziati si aspettavano che il periodo 2023-2024, i due anni più caldi mai registrati al mondo, sarebbe stato seguito da una tregua, quando le condizioni più calde del fenomeno El Niño si sarebbero attenuate. “Con il 2025, la situazione avrebbe dovuto stabilizzarsi, invece continuiamo a rimanere in questa fase di riscaldamento accelerato”, spiega Johan Rockström, direttore dell’Istituto di Potsdam per l’impatto climatico in Germania. “Sembra che siamo bloccati” e la causa “non è del tutto chiara, ma è un segnale molto preoccupante”, aggiunge.
Gli ultimi due anni “sono stati eccezionali”, riferisce all’AFP Samantha Burgess, del centro europeo che gestisce Copernicus. “Rimangono nella fascia prevista dai modelli climatici per oggi, ma siamo nella parte alta”. Una delle spiegazioni risiede nel fatto che il fenomeno La Nina, opposto a El Nino e sinonimo di influenza rinfrescante, è in realtà solo di “debole intensità” da dicembre, secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale, e potrebbe già diminuire nei prossimi mesi.
Una cinquantina di climatologi di fama mondiale, guidati dal britannico Piers Forster, stimano che il clima si sia già riscaldato in media di 1,36 °C nel 2024. È la conclusione di una versione preliminare del loro studio che aggiorna ogni anno i dati chiave dell’Ipcc, il gruppo di esperti sul clima incaricato dall’Onu. Copernicus ha una stima attuale molto simile, pari a 1,39 °C. La soglia di 1,5 °C di riscaldamento, la più ambiziosa dell’accordo di Parigi, sta per essere raggiunta in modo stabile, calcolata su diversi decenni, secondo molti scienziati. Copernicus ritiene che potrebbe avvenire entro il 2029. “Mancano quattro anni. La realtà è che supereremo 1,5 °C”, afferma Samantha Burgess.
“Al ritmo attuale, l’obiettivo di 1,5 °C sarà superato prima del 2030”, stima anche Julien Cattiaux, climatologo del Cnrs, intervistato dall’Afp. “Si dice che ogni decimo di grado conta”, perché moltiplica siccità, ondate di calore e altre catastrofi meteorologiche, “ma attualmente si susseguono rapidamente”, avverte lo scienziato. Ma “ora quello che bisogna cercare di fare è mantenere il riscaldamento globale il più vicino possibile” all’obiettivo iniziale, perché “non è la stessa cosa puntare a un riscaldamento di 2°C alla fine del secolo o di 4°C”, ricorda.
Che la combustione di energie fossili – carbone, petrolio e gas – sia responsabile della maggior parte del riscaldamento non è oggetto di dibattito tra i climatologi. Ma si moltiplicano le discussioni e gli studi per quantificare l’influenza climatica dell’evoluzione delle nuvole, della diminuzione dell’inquinamento atmosferico o della capacità della Terra di immagazzinare il carbonio in pozzi naturali come le foreste e gli oceani. Le rilevazioni annuali delle temperature globali risalgono al 1850. Ma le carote di ghiaccio, i sedimenti sul fondo dell’oceano e altri “archivi climatici” consentono di stabilire che il clima attuale non ha precedenti da almeno 120.000 anni.