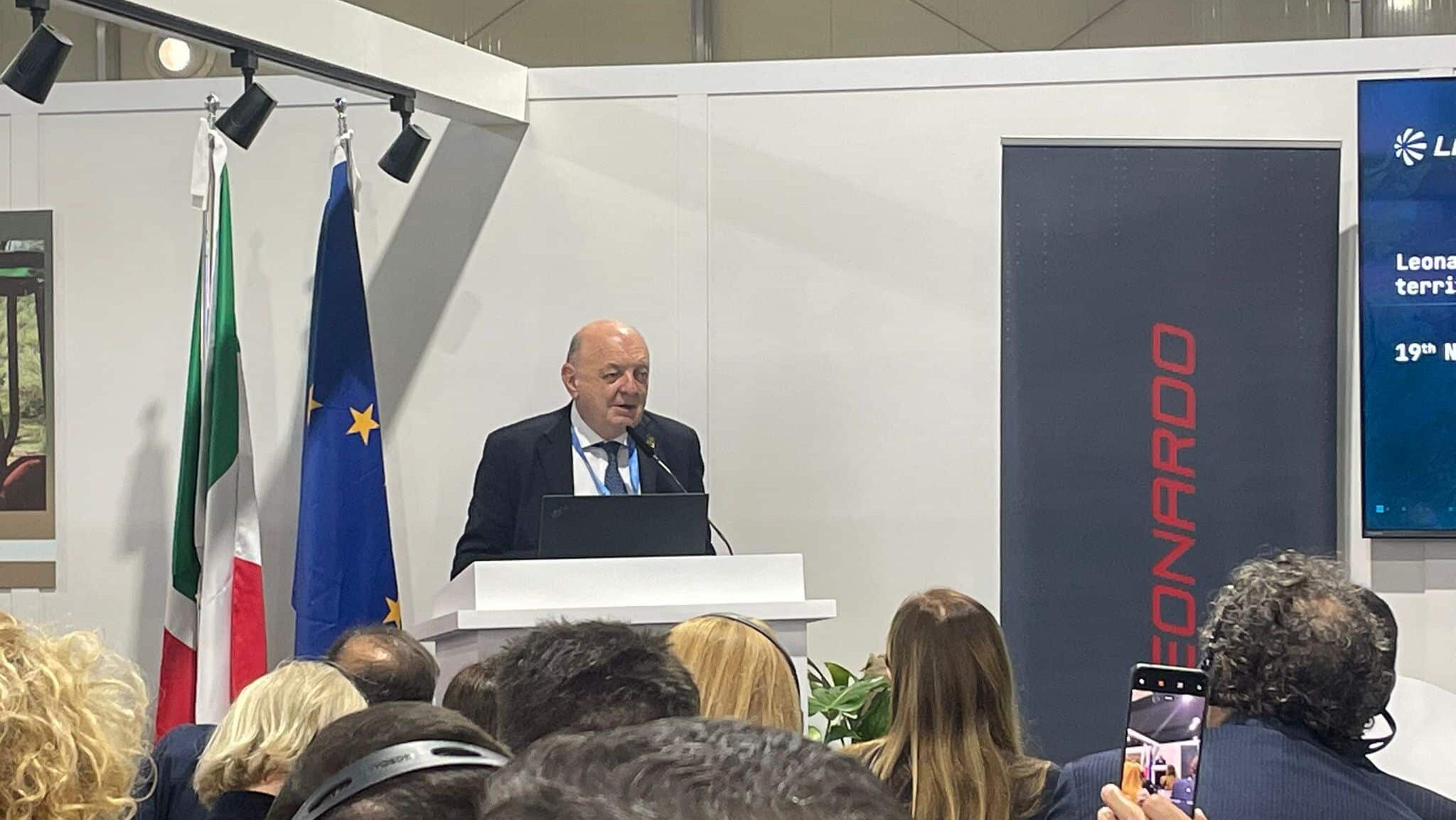Cop29, sulla finanza la bozza della discordia. A Baku si cerca il compromesso
“Unacceptable”, semplicemente inaccettabile. E’ la parola più ripetuta di oggi nello stadio di Baku, che ospita il decimo giorno di lavori della Cop29: serpeggia tra gli analisti, tuona in plenaria. La prima bozza sulla finanza climatica viene respinta da tutti. Perché non offre nessuna idea di compromesso tra i Paesi sviluppati e i Paesi in via di sviluppo, si limita a fotografare la situazione attuale. Il documento non indica una cifra precisa da stanziare o mobilitare e offre due scenari, che riflettono le posizioni dei due gruppi di Paesi.
La prima opzione è vicina ai ‘developing’, i paesi in via di sviluppo. Prevede che il nuovo obiettivo di finanza climatica, da stabilire alla conferenza annuale delle Nazioni Unite, si basi esclusivamente sui fondi dei Paesi sviluppati, che sono obbligati a contribuire secondo i testi delle Nazioni Unite, in virtù delle proprie responsabilità storiche sull’inquinamento. Secondo questa prima opzione, almeno mille miliardi di dollari all’anno devono essere forniti da fondi pubblici dei Paesi ricchi – essenzialmente Europa, Stati Uniti e Giappone – e da fondi privati associati, “nel periodo 2025-2035”, essenzialmente sotto forma di sovvenzioni piuttosto che di prestiti. Si tratta di un importo dieci volte superiore ai 100 miliardi che i Paesi ricchi si erano impegnati a fornire nel periodo 2020-2025, in parte solo sotto forma di sovvenzioni.
La seconda opzione è quella che accontenta il blocco dei Paesi sviluppati. Qui l’obiettivo finanziario sarebbe “un aumento dei finanziamenti globali per l’azione a favore del clima” di almeno mille miliardi di dollari all’anno da raggiungere “entro il 2035” a partire da almeno ‘100 milioni+’, cioè una cifra sicuramente superiore ai 100 milioni ma non si sa di quanto. In più, questa opzione includerebbe “tutte le fonti di finanziamento”, compresi i fondi pubblici di ogni Paese del mondo, i fondi privati e le nuove tasse globali, come quelle sull’aviazione o sul trasporto marittimo. Questa opzione evita di indicare una cifra per l’impegno dei Paesi ricchi, che fin dall’inizio del vertice hanno dichiarato di voler stabilire le modalità di erogazione e di monitoraggio dei fondi, prima di proporre una cifra.
Non c’è quindi un incontro a metà strada sulle due posizioni. Ecco perché le prime reazioni sono incandescenti. “Non intendo indorare la pillola. Il testo così com’è ora è chiaramente inaccettabile“, taglia corto il commissario europeo al Clima, Wopke Hoekstra. Lamenta innanzi tutto l’assenza dell’impegno a uscire dai fossili, che era stato preso a Dubai lo scorso anno: “Non possiamo accettare l’idea che, a quanto pare, per alcuni la precedente Cop non si è svolta”, afferma, ricordando che il programma dell’Ue non prevedeva solo di ribadire il consenso dell’unione, ma anche di rafforzarlo e renderlo operativo. E le nuove tasse che incrementerebbero il fondo clima, osserva, “vanno in realtà nella direzione opposta”. Sull’aspetto finanziario, per Hoekstra serve prima “un’infrastruttura migliore”, più chiarezza anche sui finanziamenti del settore pubblico per l’adattamento, sugli elementi da prendere in considerazione per arrivare a una cifra significativa. Quindi, insiste, “c’è molto lavoro da fare per la presidenza e per tutte le parti coinvolte”.
Anche il ministro italiano Gilberto Pichetto denuncia l’assenza di idee di compromesso nel primo documento: “Ci aspettiamo progressi“, scandisce, nella speranza di avere quanto prima una “proposta di mediazione”.
Il testo “non offre alcun progresso, nessun segnale sulle aspettative di piani nazionali ambiziosi, né uno spazio per discutere l’ambizione collettiva dei piani da presentare l’anno prossimo“, commenta Jennifer Morgan, inviata speciale della Germania per il clima, per cui questa “non può e non deve essere la nostra risposta alla sofferenza di milioni di persone nel mondo”. La Germania chiede messaggi chiari sui prossimi impegni climatici, riduzioni assolute delle emissioni a livello economico in linea con 1,5 gradi e il rinnovo dell’impegno a eliminare gradualmente tutti i sussidi ai combustibili fossili che non affrontano la povertà energetica o la transizione nel più breve tempo possibile. Il gruppo dei Paesi arabi fa sapere che rifiuterà qualsiasi testo che abbia come obiettivo i “combustibili fossili”. Lo mette in chiaro in plenaria il rappresentante, il saudita Albara Tawfiq, alla Conferenza ONU sul clima di Baku, nel penultimo giorno teorico della COP29. Sul piede di guerra i piccoli Paesi insulari, quelli più a rischio di scomparire con le conseguenze del cambiamento climatico. “Il tempo dei giochi politici è finito”, avverte il rappresentante, il samoano Cedric Schuster, a nome dell’alleanza Aosis, ribadendo che il mondo non può permettersi di andare in direzione opposta a quella dell’Accordo di Parigi.
Il rappresentante dei G77 (l’organizzazione intergovernativa delle Nazioni Unite, formata da 134 paesi del mondo in via di sviluppo) ripete come un mantra da giorni ai ministri e alle delegazioni di non lasciare Baku “senza stabilire una cifra chiara” sulla finanza climatica. Spiega che i Paesi in via di sviluppo chiedono ai Paesi ricchi “almeno” 500 miliardi di dollari all’anno di finanziamenti per il clima entro il 2030, per raggiungere mille miliardi con fondi pubblici, senza perdere di vista l’obiettivo di 1,3 trillions.
Molti elementi non sono “né soddisfacenti né accettabili” anche per la Cina. Il rappresentante Xia Yingxian, ribadisce intanto in plenaria il rifiuto di qualsiasi testo che obblighi la Cina a contribuire agli aiuti finanziari internazionali per i Paesi in via di sviluppo (mentre l’Europa e gli altri Paesi ricchi vorrebbero includere ufficialmente il denaro già fornito dalla Cina nel totale). Pechino invita “tutte le parti a incontrarsi a metà strada”, ponendosi come una potenza equilibratrice tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo. Il delegato suggerisce che il contributo obbligatorio dei Paesi sviluppati “sia ben superiore a 100 miliardi di dollari all’anno”.
Su tutti, l’appello di Antonio Guterres al compromesso: “Il tempo stringe“, esorta. Confessa di percepire “una certa propensione all’accordo“, pur ammettendo l’esistenza di differenze importanti. Chiede una “grande spinta per portare le discussioni oltre il traguardo” per realizzare un “pacchetto ambizioso ed equilibrato” su tutte le questioni in sospeso, con al centro un nuovo obiettivo finanziario. “Il fallimento non è un’opzione“, avverte. Quello che serve è chiaro, per il segretario dell’Onu: “Un accordo su un nuovo ambizioso obiettivo di finanziamento del clima a Baku“, da cui ripartire l’anno prossimo a Belem, in Amazzonia.
Occhi puntati sulla nuova bozza, che dovrebbe contemplare una sola opzione, un compromesso tra le parti. La sfida sarà, per gli analisti, fare in modo che il documento finale non sia un ‘fantadocumento’, che non parli di qualcosa che non esiste e che non passi l’idea che la Conferenza delle Parti possa partorire della carta straccia.