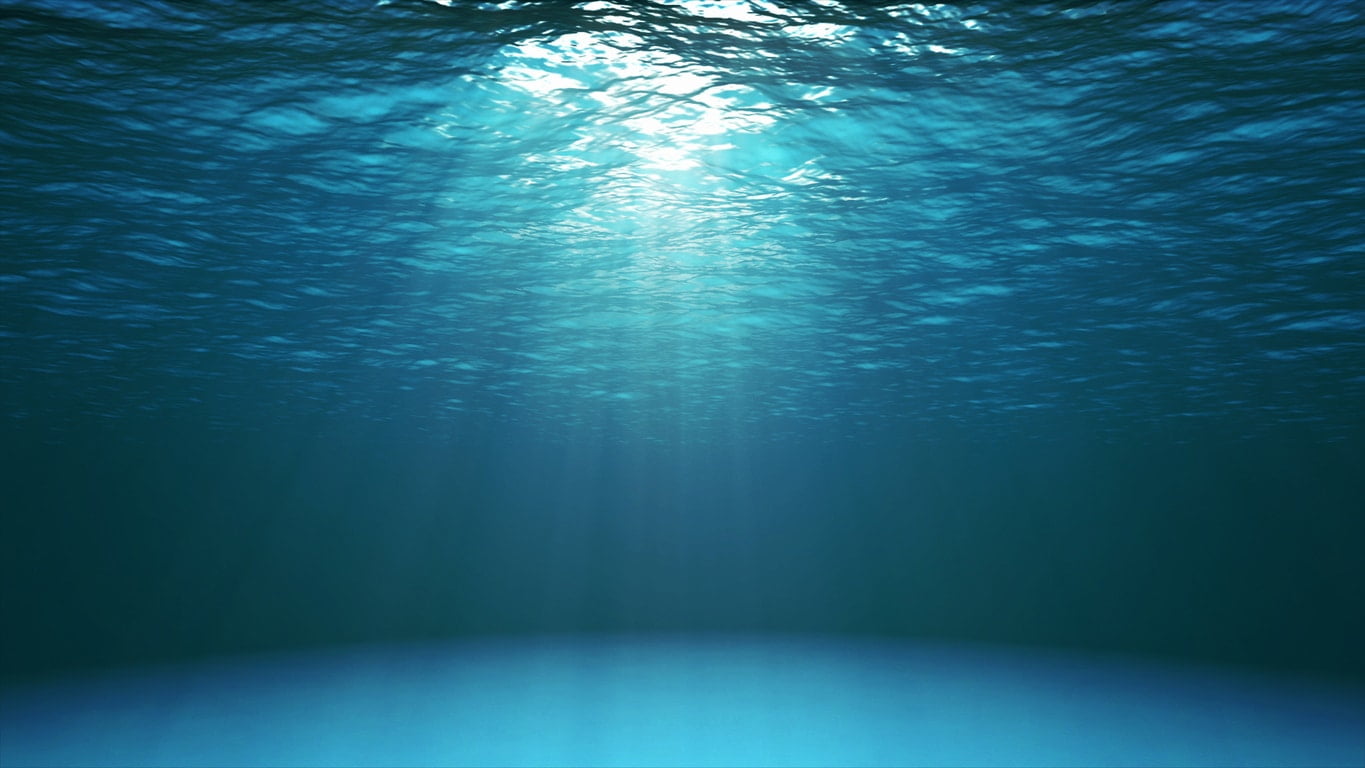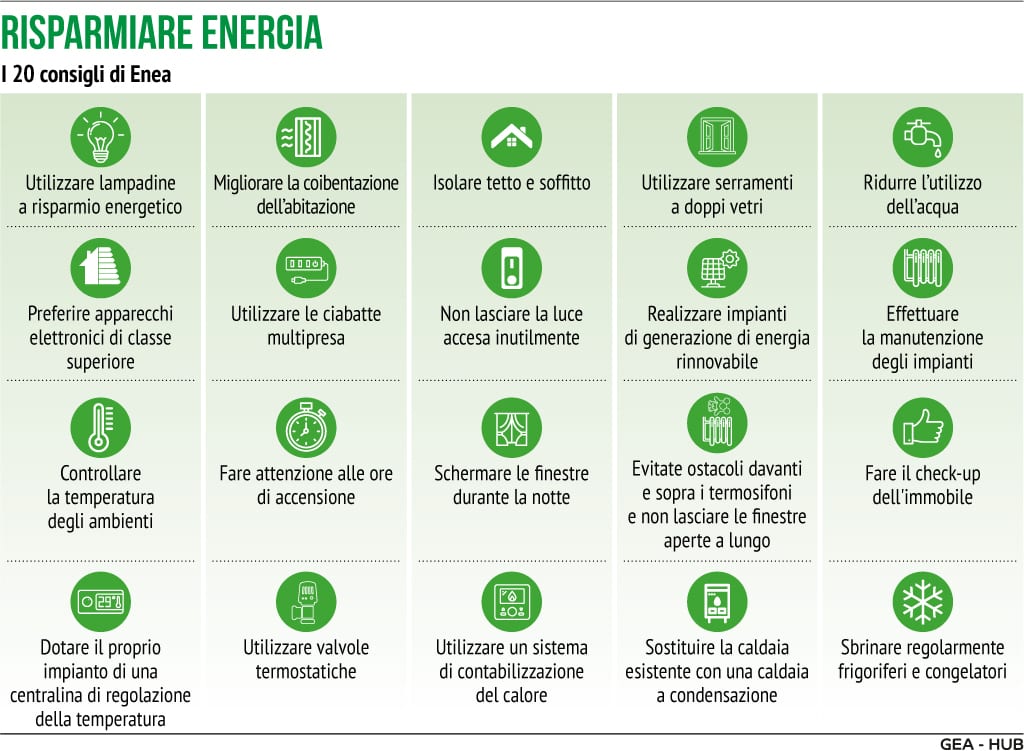Dodici ricercatori isolati per 9 mesi in Antartide per studiare il clima
Dodici scienziati trascorreranno nove mesi in completo isolamento per studiare il clima e la biomedicina. Prende, infatti, il via nella base italo-francese Concordia, a 3.300 metri di altitudine nel continente antartico, la 19esima campagna invernale del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e gestito da ENEA per l’organizzazione e la logistica e dal Cnr per il coordinamento scientifico. Sono 12 gli esperti selezionati che trascorreranno nove mesi in completo isolamento: 5 italiani del PNRA, 6 francesi dell’Istituto polare Paul Emile Victor (IPEV) e un medico tedesco dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Durante tutto l’inverno polare, infatti, la stazione non sarà più raggiungibile a causa delle temperature esterne proibitive, che possono scendere fino a -80°C. In questi mesi saranno condotti studi su clima, glaciologia, fisica e chimica dell’atmosfera e biomedicina e diverse attività di manutenzione della stazione.
L’inizio del winterover coincide ogni anno con la chiusura della stazione costiera Mario Zucchelli a Baia Terra Nova, che serra i battenti per riaprire il prossimo ottobre con l’arrivo del contingente della nuova spedizione estiva. Nel corso dell’attuale campagna sono stati condotti oltre 50 progetti di ricerca su scienze dell’atmosfera, geologia, paleoclima, biologia, oceanografia e astronomia, nonostante le difficoltà causate dal ridotto spessore del ghiaccio. I dati raccolti in Antartide saranno poi elaborati e analizzati nei laboratori di diversi enti di ricerca e università italiane. Hanno partecipato alla spedizione 240 ricercatori e tecnici, tra cui 23 esperti militari di Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Vigili del fuoco.
Dopo la chiusura della base Zucchelli, le attività di ricerca proseguono, oltre che a Concordia, anche a bordo della nave Laura Bassi, impegnata nella seconda campagna oceanografica nel Mare di Ross con studi dedicati alla geofisica. La rompighiaccio italiana, di proprietà dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), si è resa protagonista nei giorni scorsi di un record mondiale toccando il punto più a sud dell’emisfero raggiungibile via nave. Le condizioni del mare, straordinariamente libero dai ghiacci, hanno consentito ai ricercatori di effettuare importanti analisi, profilature e attività di pesca scientifica. La Laura Bassi rientrerà al porto di Lyttelton in Nuova Zelanda i primi di marzo, mentre il rientro in Italia è atteso per la seconda metà di aprile.
(Photocredit ENEA)