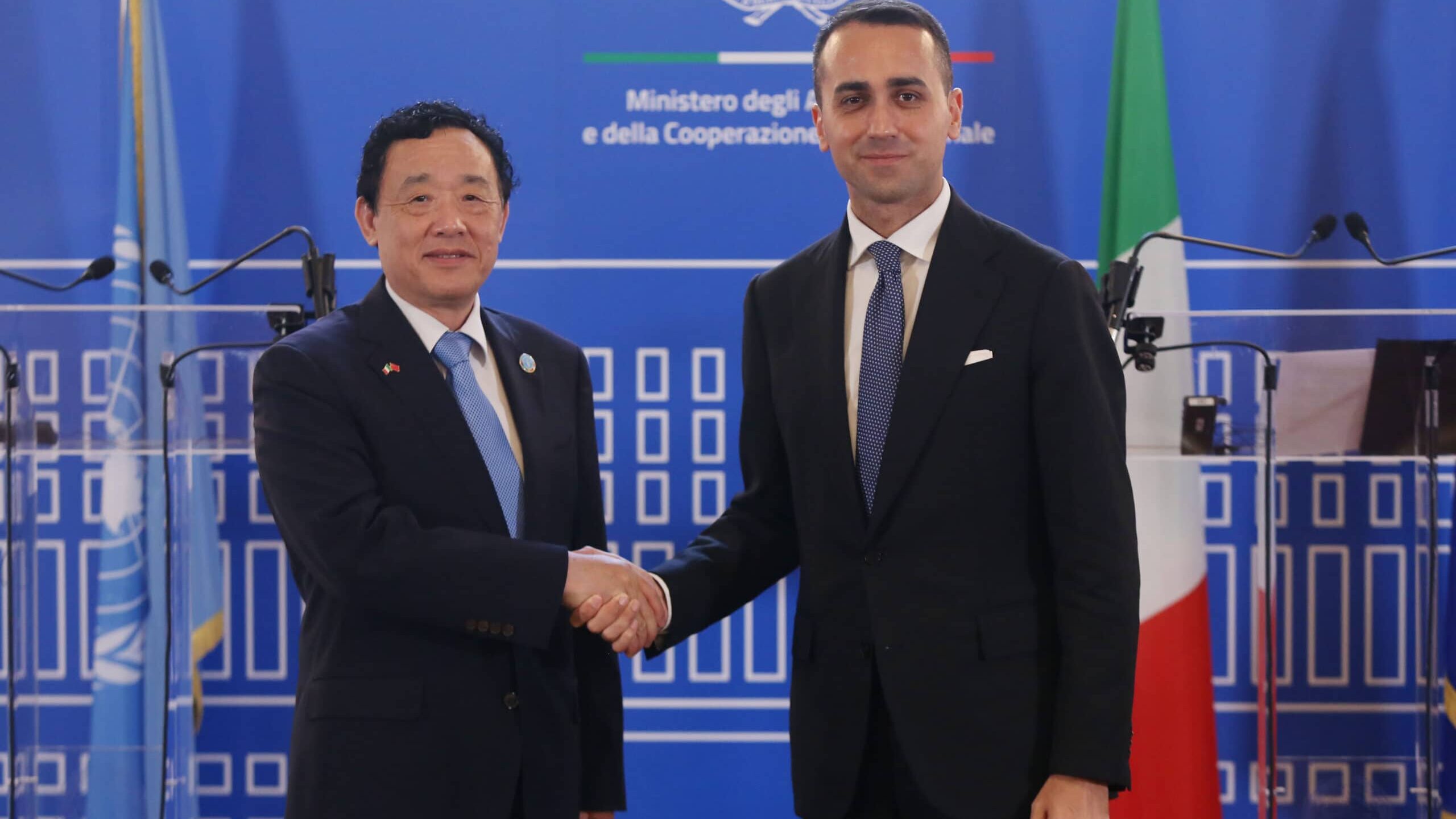La Fao chiede misure più incisive per migliorare e tutelare la gestione delle risorse ittiche
La Pesca eccessiva si è ridotta drasticamente nel Mediterraneo e nel Mar Nero, ma lo sfruttamento delle specie più commerciali è ancora lungi dall’essere sostenibile. L’ultima edizione del rapporto ‘Stato della Pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero’, pubblicato dalla Commissione generale per la Pesca nel Mediterraneo (Gfcm), che fa capo all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), registra una diminuzione dello sfruttamento eccessivo delle risorse nell’area, soprattutto con riferimento alle specie più importanti, dalla sogliola dell’Adriatico al nasello europeo, che sono oggetto di piani di gestione multilaterali. Tuttavia, il 73% delle specie commerciali è ancora interessato da una Pesca eccessiva, mentre la pressione della Pesca, pur essendo diminuita nel tempo, continua a essere doppia rispetto al volume considerato sostenibile.
Il rapporto precisa che nel Mediterraneo e nel Mar Nero, dove un abitante su mille è pescatore, migliorare la gestione delle risorse ittiche è vitale, sia per l’economia locale sia per la conservazione della biodiversità. Non a caso, l’edizione 2022 del documento biennale è stata pubblicata in occasione della Cop15 sulla biodiversità che si apre oggi in Canada.
Nel suo precedente rapporto, la Gfcm stimava il sovrasfruttamento per il 75% delle specie commercializzate nel 2018 e per l’88% nel 2012. Un segnale incoraggiante, visto che quest’anno è stata registrata “una notevole riduzione della Pesca eccessiva degli stock di nasello europeo nel Mediterraneo, rombo chiodato nel Mar Nero e sogliola comune nell’Adriatico, che attualmente sono oggetto di uno o più piani di gestione”. È fondamentale per i Paesi interessati “invertire la tendenza al ribasso delle risorse acquatiche” e “stabilire legami tra redditività e sostenibilità”, ha affermato Miguel Bernal, segretario esecutivo della Gfcm. Per questo, nella Strategia per il 2030, i membri della Gfcm hanno fissato nuovi obiettivi per far fronte alle criticità. “La nuova strategia offre una visione ambiziosa e richiede un impegno collettivo più coraggioso rispetto al passato”, ha aggiunto.
Nel Mediterraneo e nel Mar Nero la Pesca genera introiti annui per 2,9 miliardi di dollari e si stima crei mezzo milione di posti di lavoro lungo tutta la catena di valore. In media, uno ogni mille abitanti delle zone costiere della regione è un pescatore; in alcune zone costiere, il dato può essere fino a dieci volte maggiore. Tuttavia, la forza lavoro sta invecchiando. Nel 2020 più della metà di tutti gli equipaggi aveva più di 40 anni, mentre i giovani di età inferiore ai 25 anni erano soltanto il 10 percento. Stando ai più recenti dati contenuti nel rapporto, il fenomeno si sta aggravando.
“Una trasformazione blu” del settore della Pesca, ovvero il rispetto degli ecosistemi marini, “è l’unico modo per garantire che questo settore continui a sostenere la produzione alimentare e i mezzi di sussistenza delle generazioni attuali e future”, afferma Manuel Barange, direttore della Divisione della Pesca e dell’acquacoltura della Fao.
La Gfcm che riunisce 23 Paesi, è stata creata nel 1949 per svolgere un ruolo attivo nella conservazione degli stock ittici nelle acque internazionali del Mediterraneo. Le zone in cui la Pesca è vietata o regolamentata sono il risultato di negoziati, in particolare tra autorità e pescatori. Attualmente circa due terzi dell’area del Mediterraneo e del Mar Nero sono protetti in dieci zone di Pesca regolamentate, istituite proprio dalla Cfcm.