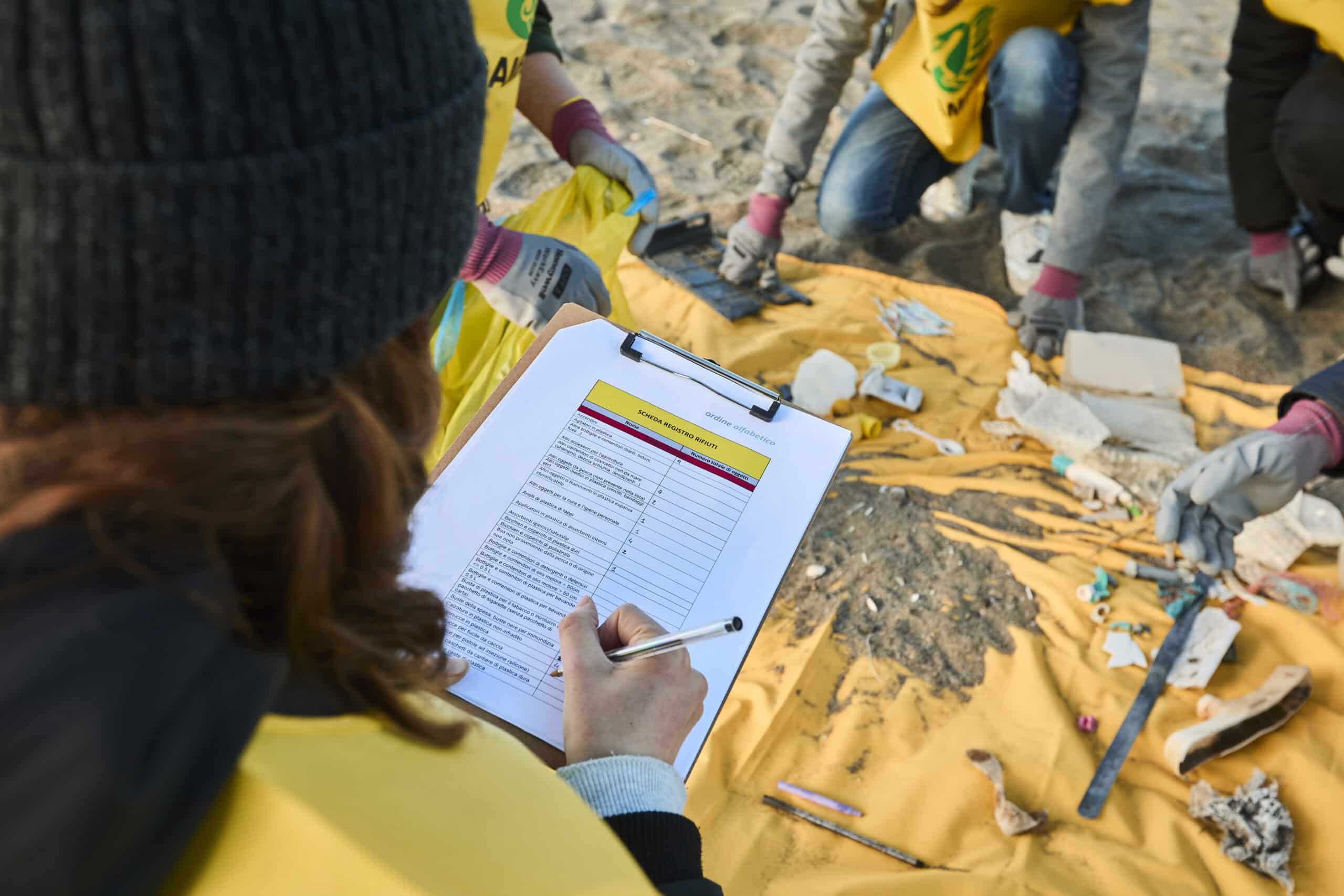Lo smog diminuisce nelle città italiane: solo 13 sopra i limiti giornalieri di PM10 nel 2025
Lo smog nelle città italiane diminuisce, anche se non abbastanza per cambiare davvero rotta. Nel 2025 scendono a 13 i capoluoghi di provincia che hanno superato i limiti giornalieri di PM10 (50 microgrammi per metro cubo per un massimo di 35 giorni all’anno), contro i 25 del 2024, i 18 del 2023 e i 29 del 2022. Lo rileva Legambiente nel suo nuovo rapporto ‘Mal’Aria di città 2026’, spiegando che “si tratta di uno dei dati più positivi degli ultimi anni, ma che non deve far abbassare la guardia”. Se si guarda al 2030, anno in cui entreranno in vigore dei nuovi e più stringenti limiti europei sulla qualità dell’aria (20 µg/m³ per il PM10, 20 µg/m³ per l’NO2, 10 µg/m³ per il PM2.5), l’Italia resta ancora lontana dai parametri richiesti: applicandoli ad oggi, sarebbe fuorilegge il 53% delle città per il PM10, il 73% per il PM2.5 e il 38% per l’NO2. Un alert preoccupante a cui si aggiunge anche la nuova procedura di infrazione avviata a gennaio 2026 dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per il mancato aggiornamento del Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico previsto dalla direttiva NEC 2016. La quarta che si aggiunge alle tre già aperte negli anni precedenti per il superamento dei valori limite degli inquinanti atmosferici stabiliti dalla Direttiva Quadro Aria (AQD).
Al Governo l’associazione ambientalista torna a chiedere di rafforzare – e non indebolire – le politiche per la qualità dell’aria, intervenendo su tutte le principali fonti emissive – trasporti, riscaldamento domestico, industrie, agricoltura e allevamenti intensivi – e garantendo risorse adeguate, soprattutto nei territori più esposti come il bacino padano, dove i recenti tagli ai fondi rischiano di compromettere i risultati raggiunti e di allontanare ulteriormente l’obiettivo 2030. Nel 2025 sono 13 i capoluoghi di provincia che hanno superato il limite giornaliero di PM10, fissato dalla normativa europea a 50 microgrammi per metro cubo e consentito per un massimo di 35 giorni all’anno. La maglia nera quest’anno va a Palermo, con la centralina di Belgio che ha registrato 89 giorni oltre il limite, seguita da Milano (centralina Marche) con 66 sforamenti, Napoli (Ospedale Pellegrini) con 64 e Ragusa (Campo di Atletica) con 61. Sotto le sessanta giornate si collocano Frosinone con 55 sforamenti, Lodi e Monza con 48, Cremona e Verona con 44, Modena con 40, Torino con 39, Rovigo con 37 e Venezia con 36 giorni di superamento. Nel resto dei capoluoghi monitorati non si registrano sforamenti oltre i limiti di legge e, come già avvenuto negli ultimi anni, nessuna città supera i valori annuali previsti dalla normativa vigente per PM10, PM2.5 e biossido di azoto. La fotografia cambia radicalmente quando si guarda ai nuovi limiti che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2030 con la revisione della Direttiva europea sulla qualità dell’aria: il 53% dei capoluoghi italiani (55 città su 103) non rispetta già ora il limite previsto per il PM10 di 20 microgrammi per metro cubo al 2030. Le situazioni più distanti dall’obiettivo si registrano a Cremona, dove serve una riduzione del 35%, seguita da Lodi con il 32%, Cagliari e Verona con il 31%, Torino e Napoli con il 30%. La situazione è ancora più critica per il PM2.5, dove 68 città su 93, pari al 73%, hanno una media annuale superiore a 10 microgrammi per metro cubo. I casi più problematici sono Monza, che ha una media annuale attuale di 25 microgrammi per metro cubo e dovrebbe ridurre le concentrazioni del 60%, Cremona con il 55%, Rovigo con il 53%, Milano e Pavia con il 50%, Vicenza sempre con il 50%. Per quanto riguarda il biossido di azoto, 40 città su 105, pari al 38%, non rispettano il nuovo valore di 20 microgrammi per metro cubo, con le situazioni più distanti dall’obiettivo registrate a Napoli dove serve una riduzione del 47%, Torino e Palermo con il 39%, Milano con il 38%, Como e Catania con il 33%.
“I miglioramenti registrati nel 2025 sono tra i più positivi degli ultimi anni, ma restano fragili e non sostenuti da scelte coerenti”, dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente. “È irragionevole che, proprio mentre iniziano a emergere segnali concreti, il Governo scelga di tagliare le risorse invece di consolidare questi progressi. La scelta di ridurre drasticamente già dal 2026 – e per tutto il prossimo triennio – le risorse destinate al Fondo per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano non va nella giusta direzione. Lasciare soli i territori più complicati del Paese è una scelta miope, che espone l’Italia a nuove procedure d’infrazione e sanzioni, come dimostra l’ultima procedura avviata dalla Commissione europea nel febbraio 2026 per il mancato aggiornamento del Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico previsto dalla direttiva NEC. Serve invece un cambio di passo: investire con continuità nel trasporto pubblico e nella mobilità sostenibile, accelerare la riqualificazione energetica degli edifici e il superamento delle fonti più inquinanti nel riscaldamento domestico e dal comparto industriale, intervenire in modo strutturale su agricoltura e allevamenti intensivi“.
Il dato più preoccupante, secondo Legambiente, è la lentezza con cui molte città stanno riducendo le concentrazioni di inquinanti anno dopo anno. Questa edizione di Mal’Aria ha analizzato i dati di PM10 degli ultimi quindici anni (2011-2025), calcolando attraverso una media mobile quinquennale la tendenza in ogni città e stimando i valori che potrebbero essere raggiunti entro il 2030. Delle 89 città analizzate, 49 nel 2025 registrano valori di PM10 superiori al nuovo limite europeo di 20 microgrammi per metro cubo. Di queste, 33 rischiano concretamente di non raggiungere l’obiettivo mantenendo l’attuale ritmo di riduzione: Cremona potrebbe scendere solo a 27 µg/mc, Lodi a 25, Verona a 27, Cagliari a 26. Situazione critica anche per Napoli, Modena, Milano, Pavia, Torino, Vicenza, Palermo e Ragusa (oggi a 28 µg/mc) che potrebbero rimanere tra i 23 e i 27 µg/mc. Potrebbero invece centrare l’obiettivo città come Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Caserta, Como, Firenze, Foggia, Latina, Lucca, Ravenna, Roma, Salerno, Sondrio, Trento e Vercelli, oggi sopra la soglia dei 20 µg/mc ma sulla traiettoria giusta per centrare l’obiettivo al 2030.
“I risultati del 2025, tra i più positivi degli ultimi anni, vanno letti alla luce di condizioni meteorologiche favorevoli e della progressiva riduzione delle emissioni dovute al miglioramento tecnologico, non come frutto di politiche strutturali pienamente efficaci. L’analisi dei trend degli ultimi quindici anni è chiara: molte città riducono le concentrazioni di PM10 troppo lentamente per rispettare i limiti europei del 2030 e tutelare la salute delle persone. Raggiungere i nuovi parametri, più stringenti rispetto ai precedenti e più vicini ai livelli indicati dalle linee guida dell’OMS, è fondamentale per ridurre morti premature e impatti sanitari“, dichiara Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente. “Non possiamo rallentare: nel 2023 le vittime del PM2,5 in Europa sono state circa 238.000, di cui 43.000 italiane, concentrate in pianura padana. Una conta drammatica che ci condanna a restare maglia nera europea. Serve dunque ulteriori sforzi da parte di tutte le forze in gioco per continuare a ridurre l’inquinamento nel nostro Paese“.