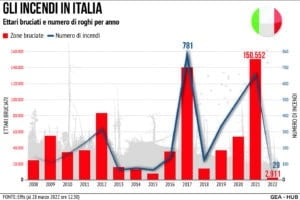Scipione, aiutaci a scacciare gli Inattivisti
Ci prepariamo a un’altra forte ondata di caldo e di siccità, lo potete leggere anche nei nostri articoli e lanci di agenzia. È l’occasione per ricordarci di stare all’erta nei confronti del cosiddetto ‘inattivismo’, il veleno più tossico a cui dobbiamo far fronte mentre siamo alle prese con il cambiamento climatico. Ne parlava una ricerca pubblicata due anni fa (l’1 luglio 2020) dalla Cambridge University Press: Discourses of climate delay (William F. Lamb et altri), ovvero ‘Discorsi sul ritardo climatico’). Ne ha parlato anche il climatologo Michael Mann nel suo libro ‘La guerra del clima’.
Lamb e i suoi colleghi scrivevano che “I ‘discorsi sul ritardo climatico’ pervadono gli attuali dibattiti sull’azione per il clima. Questi discorsi accettano l’esistenza del cambiamento climatico, ma giustificano l’inazione o gli sforzi inadeguati. Nelle discussioni contemporanee su quali azioni dovrebbero essere intraprese, da chi e con quale velocità, i sostenitori del ritardo climatico sostengono la necessità di un’azione minima o di un’azione intrapresa da altri. Concentrano l’attenzione sugli effetti sociali negativi delle politiche climatiche e sollevano il dubbio che la mitigazione sia possibile”. In pratica, non abbiamo ancora capito nulla. Gli stessi che fino a pochissimo tempo fa negavano l’esistenza stessa del cambiamento climatico, oggi non possono più farlo di fronte all’evidenza assoluta ma trovano un altro modo per ostacolare ogni possibile azione. Lo fanno, spiegano i ricercatori, sostenendo che qualcun altro deve iniziare ad agire prima di me/noi, che non è possibile mitigare il cambiamento climatico, che un cambiamento radicale non è necessario, che il cambiamento sarà devastante, enfatizzante ogni possibile effetto negativo del cambiamento e ‘dimenticando’ tutti gli effetti positivi (anche economici e geopolitici) compreso il fatto che la direzione in cui stiamo andando senza cambiamenti renderebbe la vita umana sempre più complessa.
Oggi siamo già in attesa di Scipione. Parliamo di un anticiclone, ovvero una zona di alta pressione in cui la condizione meteorologica è stabilmente serena. Si prospettano temperature fino a 40 gradi e soprattutto l’acuirsi della siccità, già grave date le scarse precipitazioni invernali e le ormai quasi esaurite riserve di neve in alta montagna (anch’essa scarsissima nel corso dello scorso inverno).
L’emergenza è seria e tra gli altri ce lo ricordano le associazioni degli agricoltori che hanno già lanciato l’allarme perché sono a rischio coltivazioni di cereali e frutta. Ma ce lo hanno ricordato nei giorni scorsi i gestori dei rifugi alpini, che potrebbero non avere acqua (o energia) già a fine giugno anticipando gli effetti di quanto potrebbe accadere più a valle. E ce lo hanno ricordato gli scienziati che hanno rilevato la mancano di due metri di neve su uno dei ghiacciai del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta.
Ma l’inattivismo è in agguato, sempre. E assume risvolti grotteschi. Mentre ascolto e leggo questa serie di appelli mi torna alla mente un episodio: l’intervista ascoltata – incredulo – in tv a Pasqua, quando il presidente di una delle società che gestiscono impianti sciistici sulle Alpi (inutile fare il nome, interessa il concetto non la gogna sulla persona) tracciava gongolante un bilancio della stagione: “È andata benissimo, per noi l’assenza di precipitazioni è stata un bene perché c’era sempre il sole e quindi eravamo regolarmente pieni di sciatori. La neve potevamo spararla con i cannoni, tanto l’acqua da queste parti per il momento non manca”. Va bene la soddisfazione per il risultato economico positivo, ma vantare anche un disastro ambientale come fattore positivo mi è parso davvero incredibile. Speriamo che Scipione ci aiuti almeno a cancellare un po’ di Inattivismo.