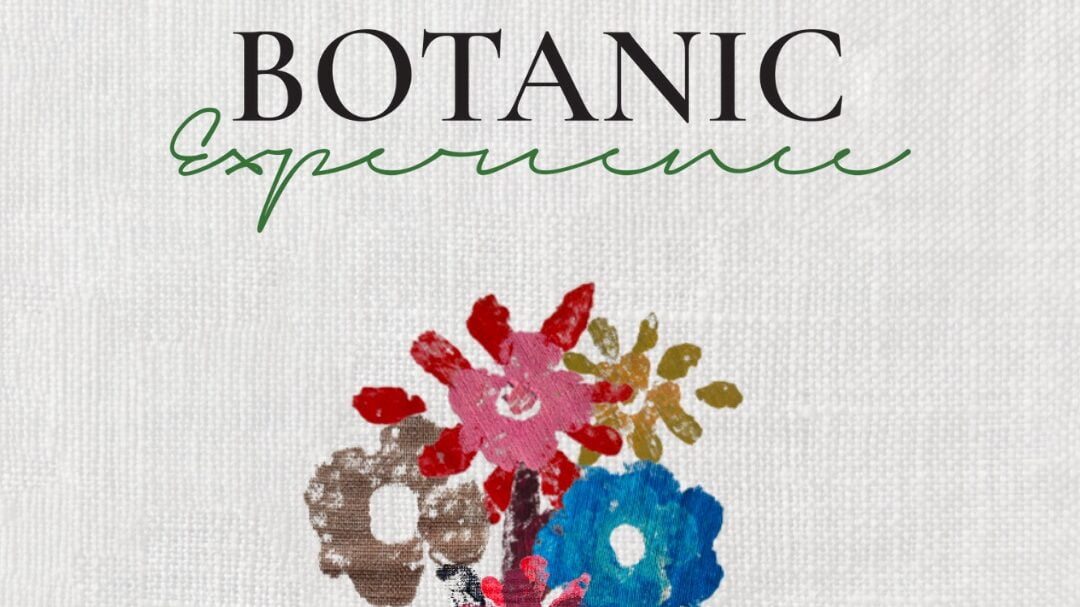Da Parlamento europeo stop a fast fashion: “Moda sia più sostenibile”
Combattere la fast fashion, la moda ‘usa e getta’. Con 68 voti a favore, nessun contrario e una astensione la commissione ambiente (Envi) del Parlamento europeo ha approvato una relazione d’iniziativa con una serie di raccomandazioni per introdurre misure a livello europeo per garantire che i tessuti siano prodotti in modo circolare, sostenibile e socialmente giusto. Nel quadro del pacchetto sull’economia circolare la Commissione europea ha adottato a marzo dell’anno scorso ha presentato la strategia dell’Ue per i tessili sostenibili e circolari per affrontare l’intero ciclo di vita dei prodotti tessili e proporre azioni per cambiare il modo in cui produciamo e consumiamo i prodotti tessili. La relazione adottata in Envi dovrebbe finire al voto dell’intera plenaria a Strasburgo prima dell’estate.
Una nota del Parlamento spiega che per “contrastare la sovrapproduzione e il consumo eccessivo di abbigliamento e calzature”, la commissione invita la Commissione e i Paesi dell’Ue ad adottare misure che mettano fine alla “fast fashion”, a partire da una chiara definizione del termine basata su “alti volumi di capi di qualità inferiore a bassi livelli di prezzo”. I consumatori dovrebbero essere meglio informati per aiutarli a fare scelte responsabili e sostenibili, anche attraverso l’introduzione di un “passaporto digitale dei prodotti” nella prossima revisione del regolamento sulla progettazione ecocompatibile, come prevede anche la proposta della Commissione europea. I deputati chiedono inoltre alla Commissione e agli Stati membri di garantire che i processi di produzione diventino meno dispendiosi in termini di energia e acqua, evitino l’uso e il rilascio di sostanze nocive e riducano l’impronta dei materiali e dei consumi. I deputati chiedono inoltre che la revisione della direttiva quadro sui rifiuti includa specifici obiettivi separati per la prevenzione, la raccolta, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti tessili, nonché l’eliminazione graduale dello smaltimento in discarica dei tessili.
Altre raccomandazioni includono: l’inclusione di un esplicito divieto di distruzione dei prodotti tessili invenduti e restituiti nelle regole di ecodesign dell’Ue; regole chiare per porre fine alle pratiche di greenwashing, attraverso il lavoro legislativo in corso sulla responsabilizzazione dei consumatori nella transizione verde e sulla regolamentazione delle dichiarazioni verdi; garantire pratiche commerciali eque ed etiche attraverso l’applicazione degli accordi commerciali dell’Ue; lanciare senza ulteriori ritardi l’iniziativa della Commissione per prevenire e ridurre al minimo il rilascio di microplastiche e microfibre nell’ambiente.