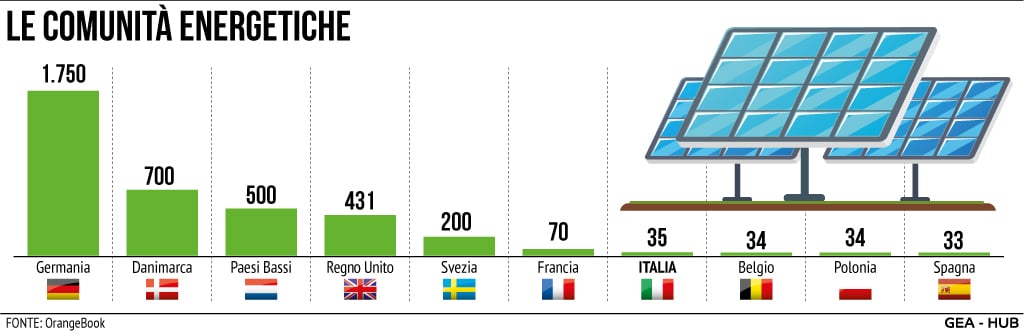Italgas sempre più sostenibile: nel piano -34% emissioni al 2028
Nei prossimi anni, il Gruppo Italgas continuerà a giocare un ruolo di primo piano nel raggiungimento dei target climatici Ue attraverso iniziative di efficientamento energetico e di digitalizzazione e ottimizzazione del sistema di controllo. L’amministratore delegato Paolo Gallo – nel corso della presentazione del Piano Strategico 2022-2028 – ha dettato la linea relativa alle prospettive future del Gruppo: “In uno scenario europeo che ha nel REPowerEU la nuova stella polare per rafforzare la resilienza del sistema energetico e accelerare la transizione ecologica, Italgas può cogliere i frutti di una visione che aveva individuato nelle reti digitali, flessibili e intelligenti come principali abilitatori della decarbonizzazione dei consumi”.
Al fine di favorire il processo di decarbonizzazione, la società ha esteso al 2028 il target di riduzione dei consumi energetici netti rispetto al 2020, portandolo a -27% e ponendosi un nuovo target di -33% al 2030. Il raggiungimento di tali obiettivi contempla le iniziative sostenibili e di digitalizzazione e ottimizzazione del sistema di controllo. Inoltre, grazie al miglioramento della rete, all’azione capillare di ricerca delle dispersioni e alla pianificazione mirata degli investimenti, Italgas prevede di ridurre del 34% le emissioni climalteranti al 2028 e del 42% al 2030. Infine, tramite un’intensificazione dell’engagement con i propri fornitori, il Gruppo auspica a un calo delle emissioni di gas a effetto serra del 30% al 2028 e del 33% al 2030 rispetto al 2024.
Raddoppia anche l’impegno verso il business dell’efficienza energetica. Il nuovo Piano, infatti, assegna 340 milioni di euro allo sviluppo delle ESCO (interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica) del Gruppo. “Tramite questo investimento, quasi il doppio rispetto al precedente piano, intendiamo dar vita a uno dei principali player a livello nazionale, con focus su innovazione e digitalizzazione, contribuendo al consolidamento di un settore ancora molto frammentato”, ha garantito Gallo. L’innovazione si conferma, dunque, il principale driver di crescita di Italgas.
L’investimento complessivo, mirato anche e soprattutto all’innovazione, sarà pari a 8,6 miliardi di euro, un aumento di 0,7 miliardi di euro rispetto al precedente. “La quota più rilevante – ha puntualizzato l’ad Gallo – è ancora una volta destinata all’estensione, trasformazione digitale e repurposing del network di distribuzione al fine di creare per tempo le condizioni per un utilizzo diffuso dei nuovi gas, come biometano, idrogeno verde e metano sintetico, che presto dovremo accogliere nelle nostre reti in quantità crescenti”.