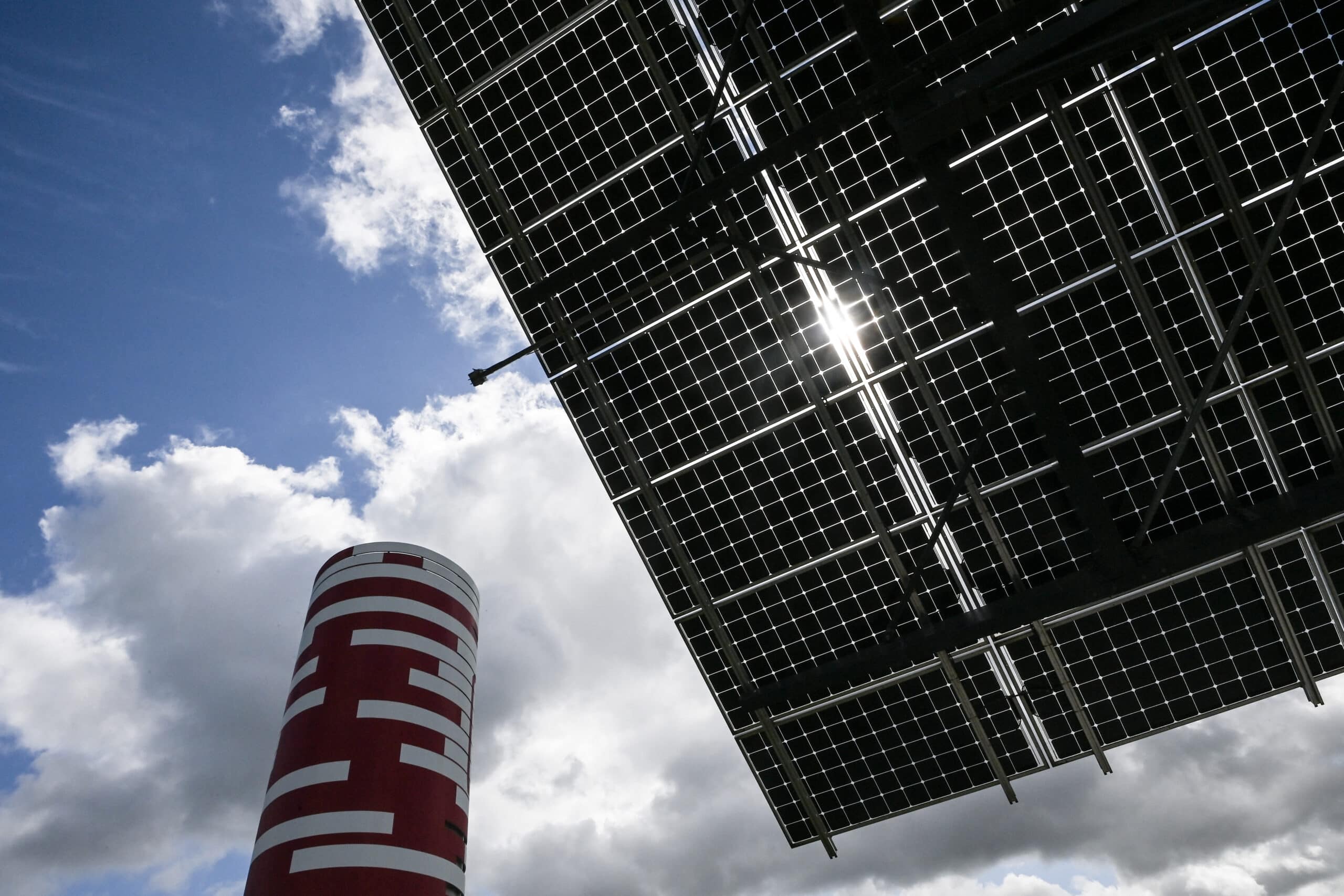I permessi frenano i progetti, ma sull’eolico l’Italia potrebbe puntare al podio globale
L’Italia è il terzo mercato a livello mondiale per potenziale di sviluppo dell’eolico offshore galleggiante e, in prospettiva, leader della filiera tecnologica in Europa. Questo il messaggio forte uscito dall’evento organizzato a Milano da Anie, la Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche, e da Elettricità Futura, la principale associazione nazionale della filiera industriale del settore elettrico.
Sono 76 i GW di rinnovabili da installare in Italia dal 2024 al 2030 per centrare gli obiettivi climatico-energetici fissati dall’Unione Europea. Considerando che circa 8 GW degli impianti esistenti dovranno essere sostituiti perché obsoleti, per raggiungere i 143 GW al 2030 sarà necessario realizzarne oltre 12 GW all’anno. Secondo dati Terna, a fine 2021 la potenza totale rinnovabile in Italia era pari a 58 Gw. Nel 2022 sono stati però installati solo 3 GW di rinnovabili in Italia, contro gli 11 in Germania, i 6 in Spagna e i 5 in Francia, numeri che danno evidenza della necessità di accelerare notevolmente il rilascio di nuove autorizzazioni nel nostro Paese. Stando all’Osservatorio Permitting di Anie, alla data del 30 giugno 2023 erano depositate presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica istanze di progetti di impianti a fonte rinnovabile per la Valutazione di Impatto Ambientale (Via) per complessivi 108 GW. Tuttavia, per il 2023, la stima dell’installato elaborata da Anie ed Elettricità Futura, in base a dati Terna, è di appena 6 GW di rinnovabili.
La domanda di turbine da parte degli sviluppatori è frenata dalla lentezza dei processi di approvazione dei nuovi progetti e da norme inadeguate in materia di licenze e permessi in generale in tutta Europa, nonostante l’adozione di nuovi obiettivi per l’energia pulita fissati dai governi, sottolinea Wind Europe, che rappresenta a livello continente i principali attori dell’energia del vento. Nel 2022, infatti, i Paesi europei hanno investito in nuovi parchi eolici l’importo più basso dal 2009 (17 miliardi di euro rispetto ai 41 miliardi di euro del 2021). Lo scorso dicembre il Consiglio della Ue ha approvato una proposta della Commissione europea volta a semplificare temporaneamente e di conseguenza ad accelerare la procedura di concessione delle autorizzazioni. La direttiva Ue aggiornata sulle energie rinnovabili include tali misure su base permanente, il che dovrebbe quindi facilitare il processo di autorizzazione quando la direttiva entrerà in vigore. In ogni caso si prevede che nei prossimi cinque anni in Europa verranno sviluppati meno progetti eolici offshore rispetto a quanto previsto in precedenza. Il Global Wind Energy Council ha infatti rivisto al ribasso le sue previsioni per la nuova capacità eolica offshore installata nel Vecchio Continente tra il 2023 e il 2027 da 40,8 GW nel rapporto dello scorso anno a 34,9 GW.
Non a caso i colossi europei produttori di turbine sono in crisi. Vestas ha registrato una perdita ante imposte di 130 milioni di euro nel secondo trimestre, Siemens Energy ha riportato una perdita netta di 2,9 miliardi a causa di problemi nel business delle turbine eoliche Siemens Gamesa, che è stato colpito da difetti tecnici e problemi di qualità in alcuni componenti delle turbine installate, tra cui pale del rotore e cuscinetti. Godono dunque i big cinesi, che controllano già il 55% del mercato mondiale. Secondo Wood Mackenzie stanno sfruttando la loro forte posizione finanziaria e l’enorme portata della loro catena di fornitura nazionale per sfidare le società occidentali, anche nei mercati emergenti.
Il cinese MingYang si sta preparando a diventare il nuovo leader di mercato, capitalizzando il portafoglio ordini di 6,5 GW e un portafoglio di prodotti esteso che copre turbine sia a bassa che ad alta velocità. SEwind perderà invece slancio – in base all’analisi di Wood Mackenzie – a causa dei margini ridotti e della forte concorrenza, in particolare da parte dei nuovi concorrenti offshore Windey, Crrc e Sany. La forte concorrenza all’interno della Cina sta a sua volta abbassando il prezzo medio delle turbine offshore da 10 MW e oltre in Cina del 19% nel primo semestre del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. Da qui la perdita di redditività delle società europee.