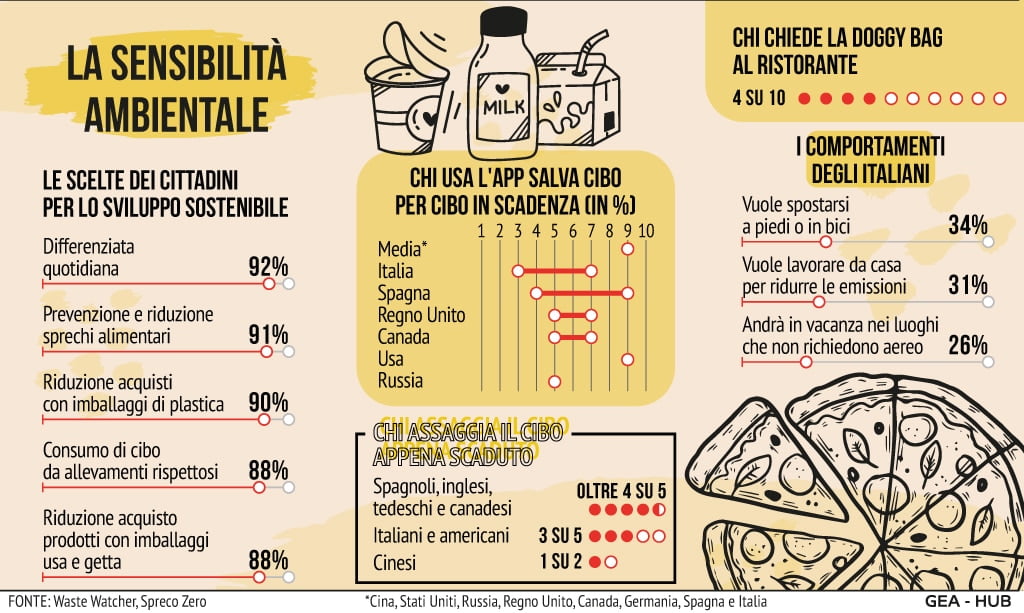Italiani e vacanze green: come cambiano le richieste dei viaggiatori
Quali sono i desideri che guidano i viaggiatori italiani quest’anno? A restituire una fotografia dai contorni piuttosto nitidi è l’osservatorio EY Future Travel Behaviours che ha condotto un’indagine su un campione di oltre mille soggetti, attraverso rilevazioni esplicite e tecniche di neuroscienze cognitive. Tra i fattori emersi dalla ricerca spicca un dato in particolare: il 46% degli intervistati considera essenziale l’impatto delle proprie scelte sull’ambiente. Cresce anche l’ansia verso i problemi climatici con il 75% del campione contro il 67% della scorsa edizione (i test condotti sono di natura implicita). Nell’analisi si rintraccia, in particolare, una preferenza sempre più netta verso esperienze diversificate e personali. Tra i profili dei viaggiatori del 2022 si registra una lieve crescita (+1%) dei cosiddetti Health and environmental concerned travelers, ovvero coloro che non hanno intenzione di aumentare il numero di viaggi per via di preoccupazioni legate all’ambiente e alla salute.
Una sensibilità ambientale che si accentua nelle generazioni più giovani. Utravel, corporate startup del Gruppo Alpitour dedicata agli under 30, ha stilato delle linee guida per viaggiare a impatto quasi zero. “Vogliamo farci portavoce di una nuova generazione di giovani viaggiatori – afferma Martina Antoniotti, Head of Marketing & Communication di Utravel – che vuole scoprire il mondo con attenzione all’ambiente, curiosità, rispetto e voglia di integrarsi con i territori”. Tra i consigli redatti dall’azienda, che pianta un albero per ogni viaggio venduto, quello di “portarsi sempre dietro una borraccia, ma anche utilizzare sapone solido, non stampare le prenotazioni e mangiare piatti a km 0” conclude Antoniotti.
Più in generale, la consapevolezza ambientale inizia ad avere il suo peso nelle scelte di viaggio degli italiani. “È entrato a far parte della cultura un pensiero rivolto all’ambiente, anche per i numerosi provvedimenti che abbiamo preso in Europa. – spiega a Gea Ivana Jelinic, presidente di Fiavet (Federazione Italiana Imprese Viaggi e Turismo) – Si tendono a preferire destinazioni poco esplorate, una ricettività che rispetti l’ambiente, magari anche all’aria aperta senza perdere però nessuna comodità. Si preferiscono soluzioni di viaggio a minore impatto ambientale, se possibile con mezzi di trasporto ecosostenibili. L’esempio più importante sono proprio le navi da crociera che hanno fatto investimenti sulla sostenibilità molto all’avanguardia”.
Il Pnrr con i fondi stanziati per la competitività delle imprese turistiche arriva, in questo senso, a potenziare la transizione sostenibile delle attività ricettive e di accoglienza. La domanda di un turismo green non assomiglia, infatti, a una tendenza passeggera. “È una solida consapevolezza: lo dimostrano gli investimenti multimilionari delle aziende su questo tema. Se fosse un trend passeggero, non ci sarebbero piani industriali” dichiara la presidente di Fiavet.