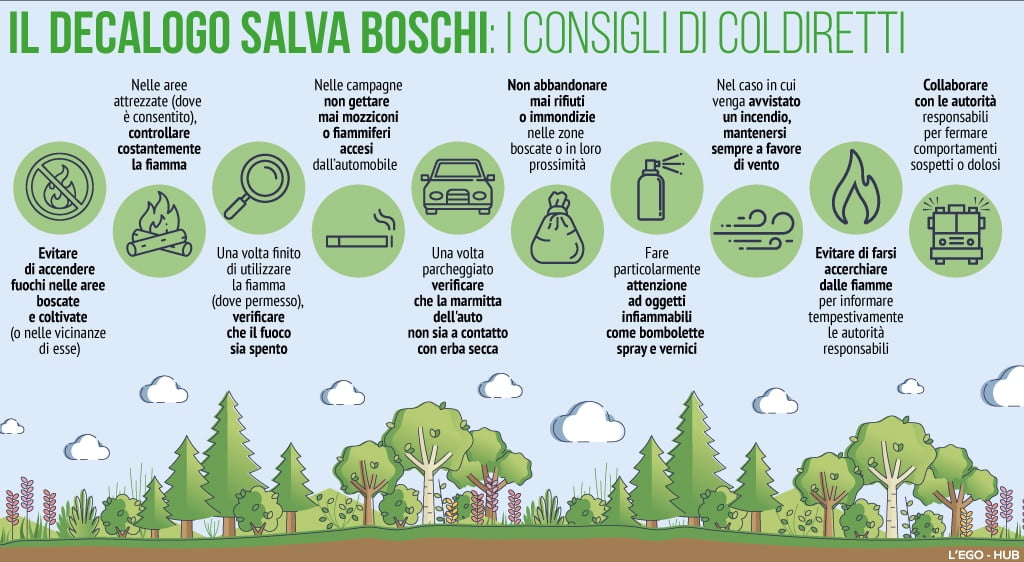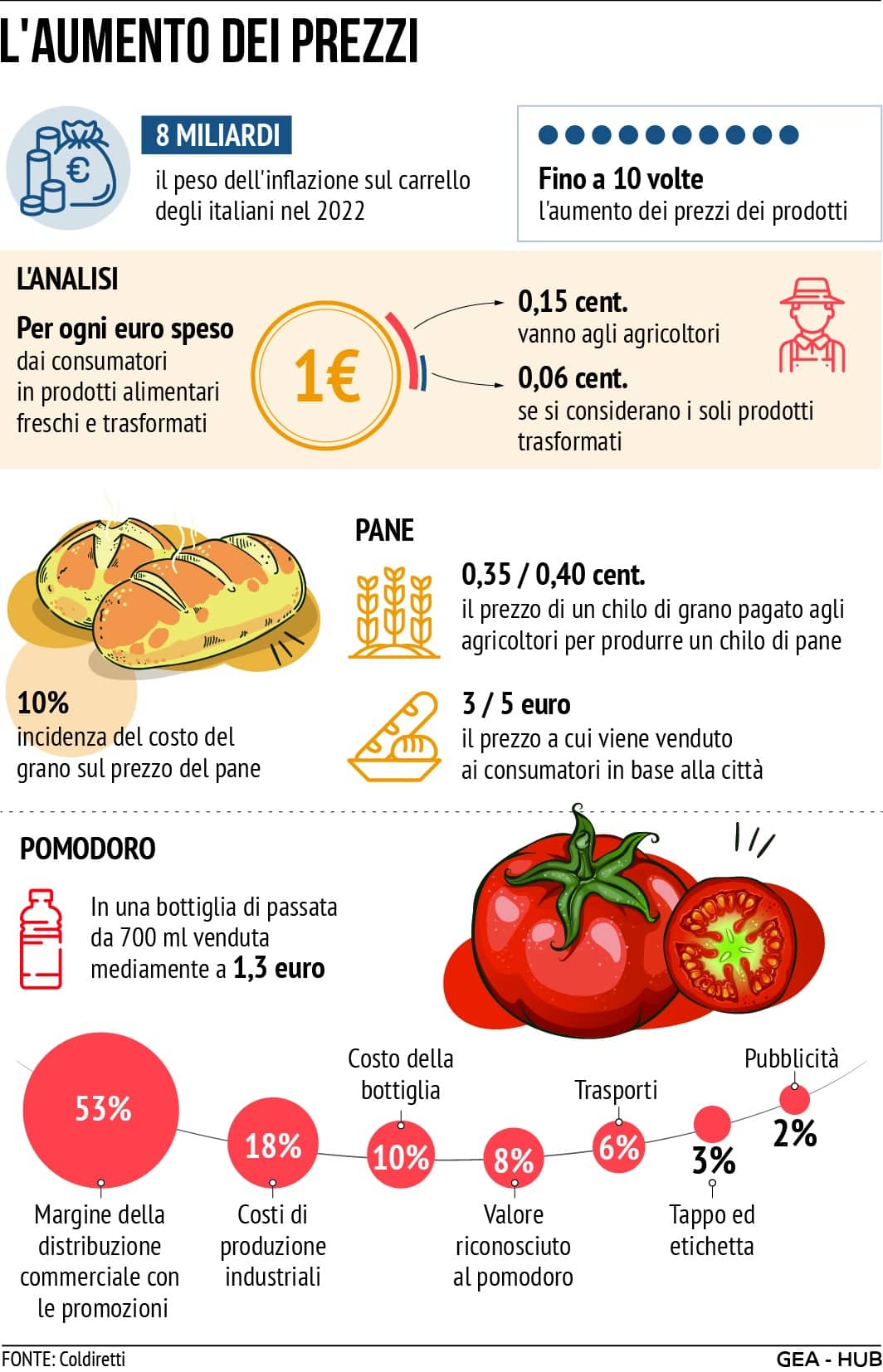Il settore agricolo è sempre più green e con donne ai vertici
“Un’agricoltura sempre più giovane e dinamica, con tantissime imprese a conduzione femminile e con una crescente attenzione agli sviluppi della ricerca e alle sue applicazioni, ma anche alla digitalizzazione“. Le parole del presidente di Copagri, Franco Verrascina, inquadrano efficacemente i primi risultati del settimo censimento dell’agricoltura dell’Istat relativo all’annata 2019-2020 (in confronto con il 2010 e il 1982). Il report infatti fotografa un settore in buona salute, sia per quanto riguarda le coltivazioni sia per gli allevamenti, e conferma il sostegno al Pil nazionale da parte del Made in Italy agroalimentare. Tuttavia è il dato storico a preoccupare: a ottobre 2020 risultano attive in Italia 1.133.023 aziende agricole, ma nell’arco di 38 anni sono scomparse quasi due aziende agricole su tre. Rispetto al 1982 c’è stata una flessione del 63,8% e la riduzione è stata più accentuata negli ultimi 20 anni: il numero di aziende agricole si è infatti più che dimezzato rispetto al 2000, quando era a circa 2,4 milioni.
Secondo il CensiAgri, inoltre, dal 2010 le aziende agricole sono in netto calo e soprattutto al Centro-Sud: almeno -22,6% in tutte le regioni, ad eccezione delle province autonome di Bolzano (-1,1%) e di Trento (-13,4%) e della Lombardia (-13,7%). Il calo più deciso si registra in Campania (-42,0%). Nel decennio la riduzione del numero di aziende è maggiore nel Sud (-33%) e nelle Isole (-32,4%) mentre nelle altre ripartizioni geografiche si attesta sotto la media nazionale.
LE COLTIVAZIONI
Dal censimento emerge che oltre la metà della Superficie agricola utilizzata (Sau) continua a essere coltivata a seminativi (57,4%), seguono i prati permanenti e pascoli (25,0%), le legnose agrarie (17,4%) e gli orti familiari (0,1%). Più nel dettaglio, i seminativi sono coltivati in oltre la metà delle aziende italiane, ossia più di 700mila (-12,9% rispetto al 2010), per una superficie di oltre 7 milioni di ettari (+2,7%) e una dimensione media di 10 ettari. In Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Puglia è concentrato il 41,4% della superficie nazionale dedicata a queste colture. Tra i seminativi, i più diffusi sono i cereali per la produzione di granella (44% della superficie a seminativi). In particolare, il frumento duro è coltivato in oltre 135mila aziende per una superficie di oltre 1 milione di ettari.
ALLEVAMENTI
Quanto all’allevamento, la Sardegna primeggia in Italia con circa 24mila aziende (10% del totale italiano), seguita da Veneto (8,3%) e Lombardia (8,2%), con circa 20mila aziende, e dal Piemonte (7,6%) con 18mila. Il contributo minore è dato invece dalle regioni dove predomina la catena alpina o la costa rocciosa, ossia la Valle d’Aosta (circa 1.400 aziende, lo 0,7% del totale), la Liguria e Trentino, entrambe con circa 4mila aziende (il 2% del totale). All’1 dicembre 2020 in Italia si contano 213.9841 aziende agricole con capi di bestiame (18,9% delle aziende attive). In termini assoluti, i capi allevati in Italia sono 203 milioni, dei quali 8,7 milioni suini, 7 milioni ovini e 5,7 milioni bovini (a cui si aggiungono ovviamente galline, tacchini, conigli etc…). Il contributo maggiore di animali allevati spetta al Nord-est, dove si trova la metà di tutti i capi censiti (quasi un terzo nel solo Veneto).
DONNE E GIOVANI
Il CensiAgri Istat si concentra anche sulla demografia delle imprese agricole italiane. Spicca ad esempio il dato sulla presenza femminile, che in termini numerici diminuisce tra il 2010 (36,8%) e il 2020 (30%) mentre aumenta la partecipazione in ruoli manageriale: i capi azienda sono donne nel 31,5% dei casi (era il 30,7% nel 2010). A livello anagrafico, è ancora limitata la presenza di capi azienda nelle fasce di età più giovanili: nel 2020 i capi azienda fino a 44 anni sono il 13%, in calo rispetto al 2010 (17,6%). Ad ogni modo il CensiAgri sottolinea che le aziende con a capo un under45 sono 4 volte più informatizzate rispetto a quelle gestite da un capo over 64 (32,2% e 7,6%). E l’incidenza delle aziende digitalizzate è maggiore nel caso in cui esse siano gestite da un capo azienda istruito e ancora di più nel caso in cui il percorso di studi sia orientato verso specializzazioni di tipo agrario. A proposito di innovazione, l’11% delle aziende agricole coinvolte nel censimento ha dichiarato di aver effettuato almeno un investimento innovativo tra il 2018 e il 2020. I maggiori investimenti innovativi sono stati rivolti alla meccanizzazione (55,6% delle aziende che innovano), seguono l’impianto e la semina (23,2%), la lavorazione del suolo (17,4%) e l’irrigazione (16,5%).
INNOVAZIONE E TRANSIZIONE GREEN
In tema di innovazione e investimenti le aziende agricole guardano sempre di più alle fonti di energia alternative e pulite. Secondo un’analisi Coldiretti, dal 2010 è triplicato il numero di imprese del settore che producono energia, dal biometano al solare. La crescita è monstre: +198% nel giro di un decennio. “L’obiettivo – spiega la Coldiretti – è ridurre la dipendenza del Paese dall’estero e fermare i rincari che stanno mettendo in ginocchio famiglie e imprese, mentre il prezzo della benzina sale ancora arrivando a 2,073 al litro e al G7 si discute sul tetto al gas e al petrolio da Mosca”. Partendo dall’utilizzo degli scarti delle coltivazioni e degli allevamenti è possibile arrivare alla realizzazione di impianti per la distribuzione del biometano a livello nazionale per alimentare le flotte del trasporto pubblico come autobus, camion e navi oltre alle stesse auto dei cittadini.
“In questo modo – spiega una nota dell’associazione agricola – sarà possibile generare un ciclo virtuoso di gestione delle risorse, taglio degli sprechi, riduzione delle emissioni inquinanti, creazione di nuovi posti di lavoro e sviluppo della ricerca scientifica in materia di carburanti green“. Gli impianti di biogas in Italia – spiega la Coldiretti – oggi producono 1,7 miliardi di metri cubi di biometano ma è possibile quadruplicare questa cifra in meno di dieci anni con la trasformazione del 65% dei reflui degli allevamenti. Ma un aiuto importante potrebbe venire anche dal fotovoltaico pulito ed ecosostenibile per il quale – ricorda Coldiretti – sono tra l’altro previsti 1,5 miliardi di euro di fondi nell’ambio del Pnrr. Secondo uno studio di Coldiretti Giovani Impresa solo utilizzando i tetti di stalle, cascine, magazzini, fienili, laboratori di trasformazione e strutture agricole sarebbe possibile recuperare una superficie utile di 155 milioni di metri quadri di pannelli con la produzione di 28.400Gwh di energia solare, pari al consumo energetico complessivo annuo di una regione come il Veneto.