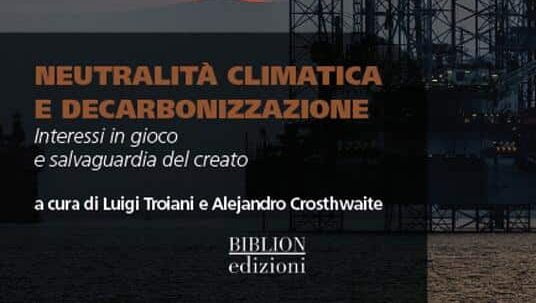Gozzi: “Timmermans ha smesso di fare danni ma la sua eredità è pesante”
Frans Timmermans, olandese, socialista, Vice-Presidente della Commissione europea con delega al cosiddetto ‘Green Deal’, ha lasciato il suo incarico per candidarsi primo ministro dello schieramento di sinistra per le elezioni che si terranno prossimamente nel suo Paese.
Gli ultimi mesi della sua attività europea sono stati frenetici nel tentativo di far passare, nel complesso meccanismo legislativo comunitario (Commissione, Consiglio Europeo e Parlamento, il cosiddetto Trilogo), il maggior numero di norme e regolamenti riguardanti la transizione energetica e la lotta al climate change.
Timmermans, che parla un perfetto italiano e che è tutt’altro che un idealista sognatore ma, a detta di chi lo conosce bene, un politico scaltro e navigato che ha cavalcato l’onda ambientalista, è stato l’esempio e l’alfiere di un approccio ideologico ed estremista che ha pervaso tutta l’azione europea degli ultimi anni in tema di transizione, decarbonizzazione, emissioni di CO2. Un approccio fatto di obiettivi irraggiungibili in tema di decarbonizzazione (Fit for 55), di sovrana noncuranza per le conseguenze economiche, industriali e sociali delle scelte estremiste che hanno trasformato le politiche ambientali e la lotta al cambiamento climatico in una nuova religione pagana del nostro tempo, che demonizza il progresso economico e tecnologico e predica un futuro di sacrifici dolorosi oppure l’Apocalisse imminente.
In molti hanno salutato il suo ritiro dalla scena europea dicendo che “ha finito di fare danni”.
In particolare sembra finalmente farsi strada, all’interno del mondo industriale europeo, una più forte riflessione e consapevolezza sulle conseguenze e sui danni provocati da un approccio estremista alla transizione. Non stiamo parlando di posizioni negazioniste, ma al contrario di soggetti attivi che perseguono convintamente politiche di decarbonizzazione dei processi industriali, fatte però con razionalità e pragmatismo e senza fanatismi ideologici.
Alla Assemblea di Assolombarda tenutasi nel luglio scorso il presidente Alessandro Spada ha ad esempio affermato: “L’Unione Europea con i suoi ambiziosi obiettivi ambientali sta forzatamente intaccando la competitività delle imprese manifatturiere europee. E quello che è del tutto irragionevole è l’accelerazione impressa dalla Commissione Europea che con questi tempi e modalità sta dimostrando di voler scaricare sulle imprese i costi della transizione ecologica”.
Una riflessione matura sul tema apre molteplici interrogativi.
Quale è la ragione per la quale un’area del mondo, l’Europa, responsabile di meno dell’8% delle emissioni globali di CO2 deve adottare un atteggiamento così estremista e così negativo per il futuro economico, industriale e quindi sociale del continente quando a livello mondiale le emissioni crescono ogni anno soprattutto per la fame di energia e di crescita che caratterizza quelli che una volta si chiamavano paesi in via di sviluppo?
Se con un colpo di bacchetta magica l’industria europea, tutta l’industria europea, che è responsabile di meno della metà di quell’8%, chiudesse i battenti (con le conseguenze economiche e sociali facilmente immaginabili) a livello mondiale non cambierebbe praticamente niente in termini di emissioni di CO2.
Quale è la ragione per la quale l’Europa è l’unica tra le grandi aree del pianeta ad aver vietato dal 2035 la produzione di auto a combustione interna e per ridurre le emissioni ha scelto di puntare tutto sull’elettrico (senza peraltro dire come verrà prodotta tutta questa energia elettrica) anziché farlo anche attraverso l’uso di altri combustibili come biocarburanti, carburanti sintetici ecc.?
Le conseguenze di questa scelta, fatta sulla base di un postulato ideologico (rifiuto della neutralità tecnologica ma scelta di una sola tecnologia per la decarbonizzazione e cioè l’elettrico), sono l’aver creato una nuova gigantesca dipendenza dalla Cina, primo paese al mondo per la produzione di auto e di auto elettriche e quasi monopolista nel controllo di tutte le materie prime necessarie alla produzione di batterie (litio, cobalto, vanadio, nichel). Su queste basi il futuro è quello di una grave perdita di quote di mercato dell’industria dell’auto europea a favore di quella cinese.
Quale è la ragione per la quale l’Europa si appresta a perdere una parte consistente della sua produzione di acciaio fatto con gli altoforni e con il carbone quando questo acciaio, detto da ‘ciclo integrale’, è indispensabile alla produzione automobilistica?
E ancora: se perderemo quote importanti di produzione di acciaio, settore in cui l’Italia eccelle (perché applica per più dell’80% della sua produzione la tecnologia del forno elettrico che ha ridottissime emissioni di CO2) perché dobbiamo farlo a favore di Cina, India, Indonesia ecc. mettendoci in condizione di esportare lavoratori disoccupati e di importare CO2?
Abbiamo sostenuto più volte, anche da queste pagine, che l’applicazione delle direttive europee nei prossimi anni comporterà la desertificazione industriale del continente con la scomparsa e/o il ridimensionamento di settori strategici quali l’acciaio, la chimica, la carta, il cemento, il vetro, la ceramica.
Perché tutto questo? Ritorniamo alla domanda iniziale.
L’atteggiamento di Timmermans e della maggioranza della sinistra europea può essere spiegato con il fatto che, persa la rappresentanza della classe operaia e dei ceti produttivi (ad esempio, il 75% degli operai iscritti alla Fiom di Brescia, sulla base di un sondaggio coraggiosamente pubblicato dalla Fiom stessa, ha votato Lega) ha sposato l’ecologismo estremista come nuovo rifugio ideologico.
La sinistra radicale, che non ha mai vinto le elezioni in Europa, non può fare a meno di un nemico (i capitalisti che inquinano) e di un totem ideologico (la decrescita infelice).
Questo estremismo della sinistra, che purtroppo ha condizionato e talvolta improntato le politiche europee, nasce anche da un senso di colpa sui temi dell’ambiente che considerata la situazione dell’Europa è totalmente ingiustificato. Questo senso di colpa non tiene conto infatti degli importantissimi risultati positivi messi a segno, in questi anni, dalla UE sul fronte della difesa dell’ambiente.
Secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, che tiene conto delle pressioni esercitate sull’ambiente da ogni singola nazione, l’Italia figura, nell’elenco dei virtuosi, terza al mondo dopo Regno Unitoe Spagna e, tra i paesi che emettono meno CO2, sette sui primi dieci in classifica, tra cui anche Germania e Francia oltreché l’Italia, appartengono all’Unione Europea.
Il perché di una posizione ambientalista radicale, astratta e ideologica della sinistra può dunque essere spiegato come sopra, anche se è in contraddizione con la tradizione di quello schieramento politico storicamente attento all’economia e ai problemi del mondo del lavoro.
Ma perché il Partito Popolare e le altre forze moderate, compreso Renew Europe di Macron, hanno seguito questo approccio in maniera quasi acritica? Mistero.
Un mistero che ha aperto spazi e consenso a movimenti populisti e sovranisti di destra cresciuti in molti paesi riscuotendo sostegno in fasce di popolazione che non si sono sentite rappresentate (gilets jaunes in Francia, il partito dei contadini in Olanda, AfD in Germania).
A me sembra che oggi si presenti l’occasione di rilanciare una nuova visione europeista, non sovranista né populista, che non neghi i problemi del climate change, che continui ad essere attenta ai problemi della transizione energetica, ma che lo faccia con gradualità e buon senso e con la consapevolezza che solo le tecnologie e le imprese possono essere i motori di questa transizione. Ciò significa mettere al centro dell’agenda europea la difesa dell’industria, la sua competitività, il suo accompagnamento e sostegno nel difficilissimo sentiero della transizione.
Tale visione deve essere comune a tutte le grandi famiglie politiche europee: Popolari, Liberal-democratici, e perfino i Verdi tedeschi che ultimamente sembrano riflettere sugli errori commessi seguendo l’approccio radicale alla Timmermans. Le recenti dichiarazioni della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sembrano andare in questa direzione anche se non si può negare che l’appoggio dei verdi e dei socialisti alla sua presidenza l’abbia condizionata non poco.
Anche i socialisti dovrebbero adottare una visione più realistica e razionale invece di continuare ad assecondare la retorica ideologica degli ambientalisti estremisti di fatto nemici dell’Europa. Un aiuto più importante del Sindacato in questo senso forse aiuterebbe, richiamando la sinistra al fatto che senza economia e senza lavoro l’unica transizione è verso la miseria e sarebbero i ceti più deboli a pagarne le peggiori conseguenze.