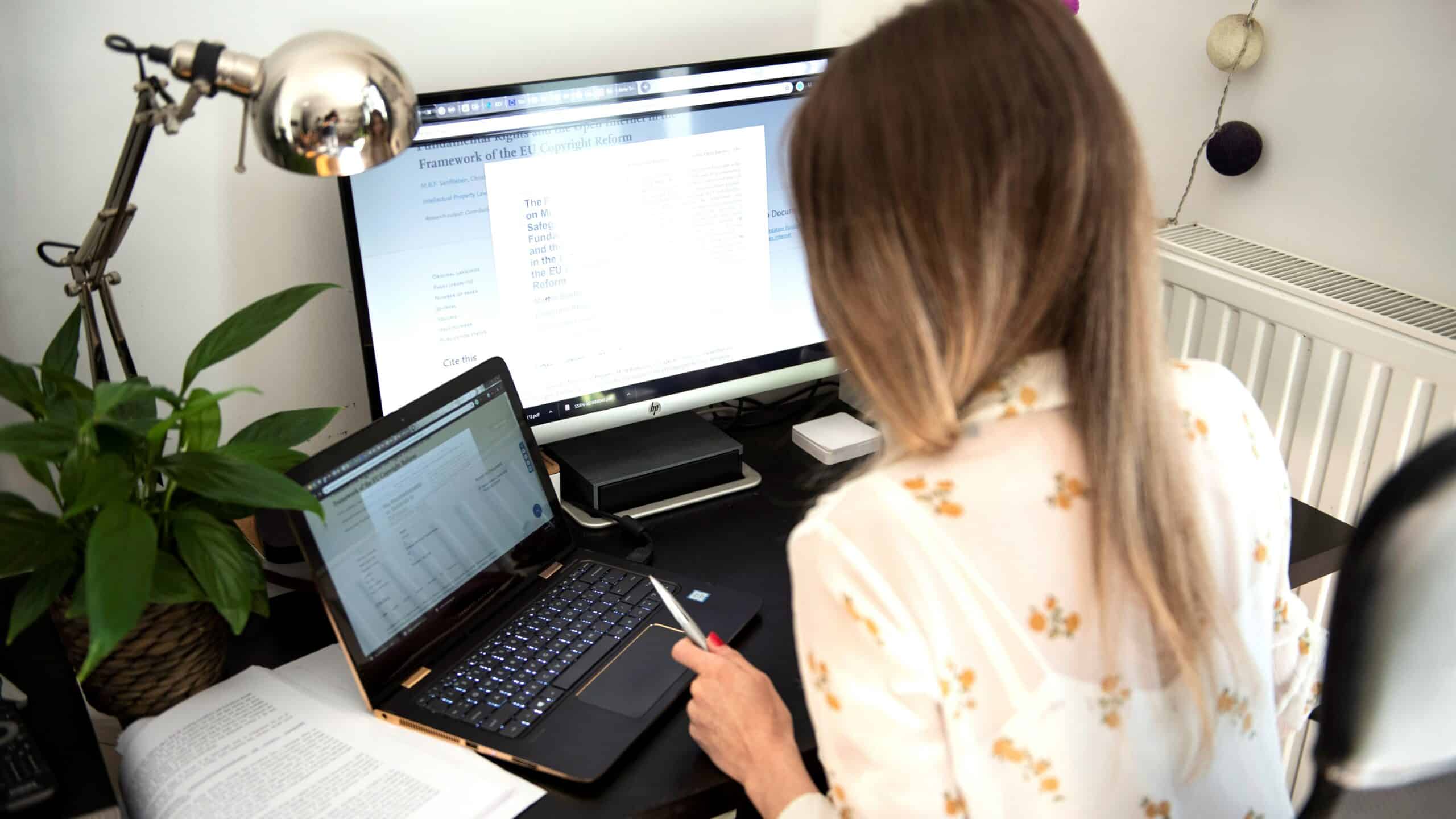Clima, l’aumento di CO2 e di metano minaccia il Mediterraneo
L’area del Mediterraneo è sempre più a rischio a causa del continuo aumento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di metano (CH4). È quanto emerge dal Report dell’Osservatorio Climatico ENEA ‘Madonie – Piano Battaglia’ che dal 2005 effettua misure settimanali della concentrazione dei due gas e di altri parametri climatici. I dati, che dimostrano la minaccia per il Mediterraneo, sono sovrapponibili a quelli rilevati dall’Osservatorio ENEA di Lampedusa e, su scala globale, da differenti istituzioni internazionali e sono stati presentati alla vigilia della Giornata Meteorologica Mondiale che ricorre domani, 23 marzo 2024, quest’anno dedicata al tema ‘In prima linea nell’azione per il clima’.
“La concentrazione atmosferica di CO2 a Madonie-Piano Battaglia è aumentata dal 2005 con un tasso di crescita di 2.16 ppm/anno a causa delle emissioni antropiche”, evidenzia Francesco Monteleone del Laboratorio ENEA di Osservazioni e misure per l’ambiente e il clima. “Inoltre – aggiunge – si osserva una forte crescita anche per la concentrazione atmosferica di metano, e lo stesso trend si sta registrando, con una crescita accelerata negli ultimi 15 anni, anche su scala globale”.
L’alta quota, la posizione geografica, l’assenza di contaminazioni locali e l’accuratezza delle misure fanno dell’Osservatorio Climatico ENEA un sito di eccellenza per il monitoraggio e lo studio dei meccanismi legati al cambiamento climatico su scala regionale e globale. Per queste caratteristiche l’Osservatorio ha ottenuto il riconoscimento di stazione regionale, rappresentativo per tutta l’area del Mediterraneo centrale, nell’ambito del Global Atmosphere Watch (GAW), che è la rete mondiale per lo studio del clima globale dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO).
L’Osservatorio Climatico di Piano Battaglia dispone di vari strumenti di misura tra cui una stazione meteorologica e un sistema di campionamento dell’aria per determinare la concentrazione di CO2, metano e monossido di carbonio, i cui campioni vengono spediti e analizzati all’Osservatorio Climatico ENEA di Lampedusa. I dati messi a disposizione della rete mondiale del WMO sono utili alle amministrazioni locali per pianificare le azioni volte a una gestione sostenibile del territorio e a sensibilizzare la popolazione.