
Il lato oscuro della decarbonizzazione: i costi nascosti del net zero in Cina
Espropri, conversione dei terreni agricoli, compromessi ecologici e sociali, cambiamento degli ecosistemi. L’annuncio della Cina di voler raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2060 potrebbe comportare costi nascosti e scelte ambientali difficili.
Il Paese emette il 27% dell’anidride carbonica globale e un terzo dei gas serra del mondo, ma sembra lanciato verso la decarbonizzazione. In un articolo pubblicato su Communications Earth & Environment, Stefano Galelli, professore associato presso la Cornell University’s School of Civil and Environmental Engineering, e colleghi hanno cercato di quantificare come la decarbonizzazione della China Southern Power Grid, che fornisce elettricità a più di 300 milioni di persone, avrà un impatto negativo sui bacini fluviali, la maggior parte dei quali scorre dalla Cina verso i Paesi a valle, e ridurrà la quantità di terreni coltivati. “Se pensiamo a qualsiasi grande cambiamento tecnologico, ha sempre dei costi e delle conseguenze indesiderate”, dice Galelli. “Prima ce ne rendiamo conto e le affrontiamo, più sostenibile ed equa sarà la transizione energetica. Dobbiamo farlo bene”.
La decarbonizzazione della rete entro il 2060 potrebbe essere tecnicamente fattibile, ma richiederebbe la costruzione di numerose dighe per la produzione di energia idroelettrica (circa 32 GW) e la conversione di circa 40.000 chilometri quadrati di terreni coltivati per sostenere la crescita del solare e dell’eolico La maggior parte delle dighe verrebbe collocata su fiumi transfrontalieri, cioè condivisi da due o più Paesi, con potenziali impatti ecologici negativi sia in Cina che nei Paesi a valle.
Due dei principali bacini fluviali transfrontalieri che subiranno un impatto sono il Salween e il Mekong, entrambi importanti hotspot di biodiversità. Il Salween è condiviso dalla Cina (a monte) e dal Myanmar; il Mekong dalla Cina (a monte), dal Myanmar, dalla Thailandia, dal Laos, dalla Cambogia e dal Vietnam. Le dighe bloccano il trasporto di sedimenti e nutrienti dal corso superiore alla foce del fiume, riducendo la produttività degli ecosistemi e della pesca. E se i sedimenti non raggiungono il delta, l’intrusione salina diventa un problema maggiore. Le dighe, poi, possono anche avere un impatto sulle specie ittiche migratorie.
La decarbonizzazione porterebbe anche a compromessi ecologici e sociologici in termini di utilizzo del territorio, spiega Galelli. “Escludendo i siti protetti – città e parchi nazionali, per esempio, ciò che rimane sono i terreni coltivati su cui costruire l’energia solare ed eolica”, osserva.
Le centrali a carbone sono state storicamente la fonte dominante di elettricità per la China Southern Power Grid, ma la costruzione di un numero sufficiente di impianti eolici e solari per sostituirle richiederà molto spazio. Che rischia di non essere equamente suddiviso. La ricerca mostra che il 43% del fabbisogno totale di terreni si concentrerebbe probabilmente nella provincia di Guangxi, dove le coltivazioni e i pascoli costituiscono la stragrande maggioranza delle attività sul territorio. Questo potrebbe essere un pesante fardello per la provincia e comportare costi ecologici, sociali e finanziari significativi per le comunità locali.
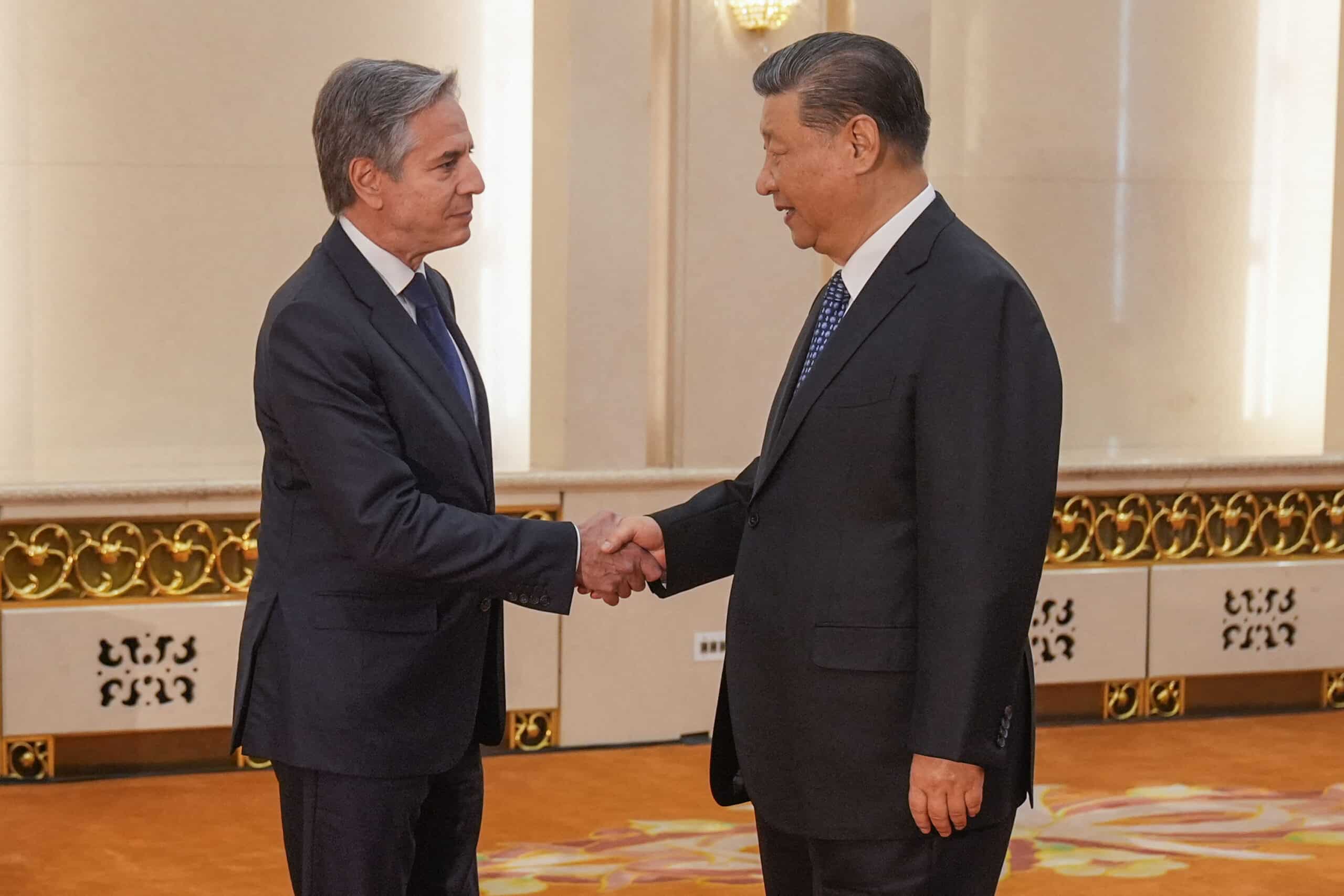


 Il progetto mira a integrare le varie funzioni all’interno di un unico blocco in cui tutte le esigenze funzionali sono centralizzate, rendendo il progetto più economico ed efficiente. L’intervento ha voluto rispettare la scena esistente e rispondere alle caratteristiche del sito, tenendo conto del paesaggio urbano e dei requisiti di pianificazione generale. L’immobile si affaccia su due strade principali della città di Shanghai: Wuning Road a est e Zhongshan North Road (Inner Ring Elevated) a sud, posizione che gli conferisce il potenziale per diventare un punto di riferimento cittadino.
Il progetto mira a integrare le varie funzioni all’interno di un unico blocco in cui tutte le esigenze funzionali sono centralizzate, rendendo il progetto più economico ed efficiente. L’intervento ha voluto rispettare la scena esistente e rispondere alle caratteristiche del sito, tenendo conto del paesaggio urbano e dei requisiti di pianificazione generale. L’immobile si affaccia su due strade principali della città di Shanghai: Wuning Road a est e Zhongshan North Road (Inner Ring Elevated) a sud, posizione che gli conferisce il potenziale per diventare un punto di riferimento cittadino.



