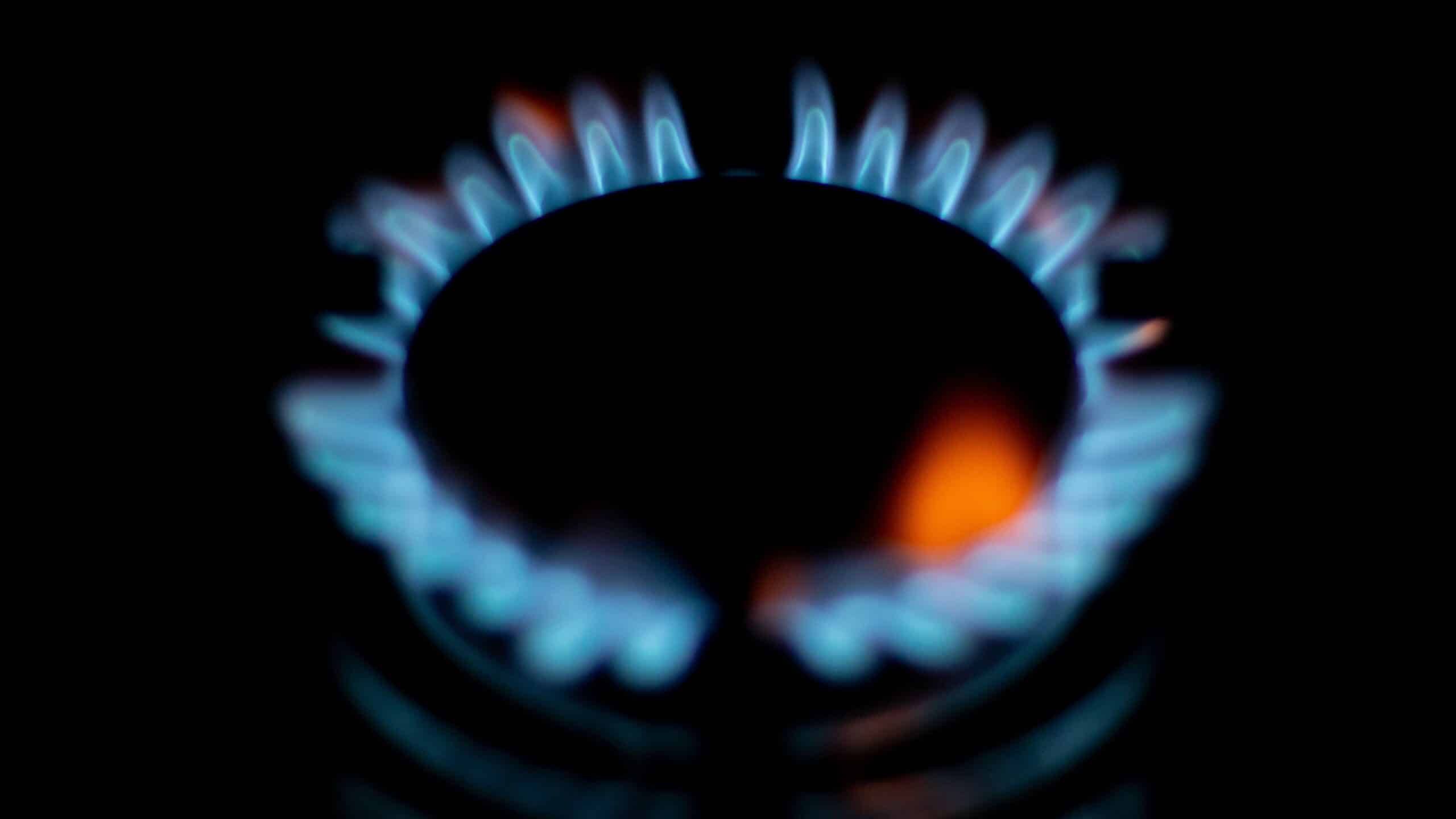Agroalimentare, per l’ingresso dell’Ucraina in Ue servirebbero 100 miliardi di euro in più alla PAC
100 miliardi per salvare la Pac. Ecco quanto servirebbe per sostenere la Politica Agricola Comune se l’Ucraina entrasse in Unione Europea. Un tema, questo, al centro dei dibattiti di questi giorni, che ha guidato anche l’evento, organizzato dalla piattaforma editoriale Withub, tenutosi oggi a Bruxelles, ‘Nuove coordinate per la sostenibilità dell’agricoltura Ue’, alla presenza delle principali associazioni di categoria – Cia, Coldiretti, Confagricotura, Eat Europe e Filiera Italia – e del Commissario Europeo per l’Agricoltura, Janusz Wojciechowski.
PAC: + 100 MILIARDI O MENO SOSTEGNO PER TUTTI. Quali sarebbero gli effetti sulla Pac dell’ingresso in Europa di un gigante agricolo come l’Ucraina? L’Europa assegna i finanziamenti ai paesi membri prevalentemente in base all’estensione in ettari della superficie agricola. Oggi, i 27 Stati dell’Ue hanno una superficie agricola di 157 milioni di ettari, la sola superficie coltivabile dell’Ucraina è di 41 milioni di ettari (dati 2020 estrazione a partire da Eurostat, Servizio Statistico Ucraino). Secondo l’elaborazione del Centro Studi GEA su una simulazione a cura del professor Angelo Frascarelli dell’Università di Perugia, basata su un calcolo effettuato sui criteri della Pac attuale, se l’Ucraina entrasse in Ue oggi, dovrebbe ricevere – in base agli ettari coltivati – fondi per oltre il 20% del budget annuale dell’intera Europa dedicato al sostegno agli agricoltori. Questa proiezione non tiene presente le future azioni correttive dell’effettivo negoziato di adesione dell’Ucraina all’Unione europea, ma calcola l’ipotesi di un’erogazione del sostegno europeo sulla base della superficie agricola per il primo pilastro della PAC, ipotizzando l’ingresso dell’Ucraina alle stesse condizioni degli attuali Paesi membri dell’Ue. Si tratta, quindi di un’importante, ma necessaria, semplificazione dello scenario secondo la quale, tuttavia, l’equilibrio degli altri Paesi Ue sarebbe sconvolto. In un’Unione Europea a 28 Stati, infatti, gli ettari coltivati salirebbero a 198 milioni e mezzo rispetto ai 157 milioni e mezzo attuali. A parità di budget, stando alla simulazione, per ogni ettaro coltivato si riceverebbero 272,34 euro anziché gli attuali 343,52. Ciò significa, facendo il calcolo sull’Italia, che il nostro Paese passerebbe da un contributo di 5,6 miliardi di euro l’anno a 4,2 miliardi. Se invece si volessero continuare a sostenere tutti gli agricoltori dei Paesi Ue con le stesse cifre di oggi e a questi si aggiungessero quelli ucraini, servirebbero appunto 98,9 miliardi di euro in più (per un settennio del quadro finanziario pluriennale), che si andrebbero a sommare ai 378,5 miliardi, il budget pluriennale della Pac attuale.
PAC IN ITALIA. LE CONSEGUENZE REGIONE PER REGIONE. Secondo le elaborazioni dell’università di Perugia su dati Eurostat registrate dal centro studi GEA, inoltre, le 10 regioni che perderebbero di più con l’entrata in Ue dell’Ucraina, immaginando di mantenere i livelli attuali di sostentamento agli agricoltori, sarebbero: la Lombardia (che perderebbe il 52%, passando da oltre 600 milioni a meno di 300); la Calabria (con -48%, quindi da quasi 400 milioni a 200), il Veneto (-47%, da quasi 500 milioni a circa 250). A seguire il Piemonte, l’Emilia Romagna, le Marche, il Friuli Venezia Giulia, la Campania e l’Umbria.
NON SOLO PAC: F2F E FERTILIZZANTI. Cosa comporterà l’applicazione delle norme sulla riduzione del 20% dei fertilizzanti chimici contenute nella Farm2Fork? Secondo un’elaborazione del Centro Studi GEA su dati dell’Università Cattolica del Sacro Cuore campus di Piacenza e Cremona – Vsafe e Federchimica Assofertilizzanti, una diminuzione in produzione per le principali colture italiane: -14,5% per il frumento duro, -12,3% per il frumento tenero, -12% per il mais, -12,6% per il pomodoro, -6,6% per la soia, -9,9% per l’uva da vino. Una calo di produzione che si rifletterebbe sull’economia italiana con una perdita pari a 5,4 miliardi di euro. In questo scenario, potrebbero avere un ruolo importante i biostimolanti. Secondo un’elaborazione del Centro Studi GEA su dati dell’Università Cattolica del Sacro Cuore campus di Piacenza – ISA (Innovation for Sustainable Agriculture R&D), questi prodotti, potrebbero arginare le perdite generate dall’adeguamento richiesto dalla Farm to Fork. Dai test effettuati dall’Università Cattolica di Piacenza, infatti, è evidente come i biostimolanti compensino la riduzione di input chimici e aiutino la pianta in condizioni di stress. Nei test effettuati sulle colture di pomodoro, ad esempio, riducendo i fertilizzanti ma impiegando biostimolanti, la resa non è statisticamente diversa da quella ottenuta con fertilizzazione 100% in termini di altezza delle piante, produzione di frutti e foglie.
FILIERA ITALIA. “I 378 miliardi di PAC attuali rappresentano una risorsa fondamentale che aiuta gli agricoltori a sostenere i costi di standard produttivi di sicurezza e ambientali più elevati al mondo e rendere competitiva con la fase di produzione agricola l’intera filiera e sono tutto il contrario di un sostegno passivo al reddito degli agricoltori. Se non ci fossero, 300 miliardi sarebbero stati caricati direttamente sul carrello della spesa dei consumatori con conseguenze tutt’altro che positive soprattutto per le fasce più povere, alle quali non sarebbe permesso di accedere a un’alimentazione di qualità che caratterizza i paesi europei e l’Italia in particolare”, ha detto Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia e presidente di Eat Europe. E sull’Ucraina: “È fondamentale sostenerla in questo momento difficile ma non è accettabile che a pagare il prezzo di una possibile entrata del Paese in UE sia la filiera agroalimentare, anche considerando che sempre di più fondi speculativi internazionali stanno mettendo le mani su una parte crescente dell’agricoltura ucraina danneggiando gli stessi piccoli agricoltori ucraini, Quindi aiutare l’Ucraina (ma non certo la speculazione), tutelando anche la nostra filiera”.
CONFAGRICOLTURA. “Confagricoltura da sempre sostiene che l’attuale Pac sia inadeguata oggi e inadatta a rispondere alle prossime sfide, poiché mette a rischio non solo un settore produttivo, ma la sicurezza alimentare globale. Per rispondere alle esigenze emerse chiaramente in questi ultimi anni e in prospettiva di un futuro allargamento dell’Ue, anche il budget dedicato deve essere rivisto tenendo conto pure degli aumenti dei costi di produzione e dell’inflazione. Il tema della dimensione del bilancio agricolo Ue impone poi un approfondimento alla luce del fatto che la sicurezza alimentare dell’Europa dipende dai livelli di efficienza e competitività delle imprese, e dal reddito che gli agricoltori riescono ad ottenere dal proprio lavoro”, ha detto Cristina Tinelli, Direttrice Relazioni Ue e internazionali di Confagricoltura e Presidente del gruppo Sviluppo rurale di Copa-Cogeca.
CIA. “Serve un cambio di rotta deciso da parte dell’Ue per costruire un futuro che consenta la sopravvivenza della produzione europea, redditi dignitosi, mantenimento e crescita delle aree rurali, sostenibilità economica, ambientale e sociale”, ha dichiarato il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini. “Questo significa ragionare su una nuova Pac, con meno burocrazia e regole semplificate per facilitare i pagamenti, a partire dagli ecoschemi, cancellando l’obbligo del 4% per l’incolto. Abbiamo già subito una drastica riduzione delle rese a causa della crisi climatica, è assurdo che la Ue ci dica di tenere dei terreni a riposo. In più, la Pac non può più essere l’unica politica a rispondere alle sfide della transizione verde. Poi c’è lo scenario politico internazionale: considerato il ruolo strategico dell’Europa sul fronte della sicurezza alimentare, nonché il potenziale ingresso dell’Ucraina nell’Unione, il prossimo quadro finanziario pluriennale dovrà essere in linea con tali ambizioni, richiedendo maggiori risorse e tutele sul mercato. Per tutto questo, è importante lavorare affinché il futuro Commissario europeo all’Agricoltura abbia un peso politico importante e sia in grado di creare consenso sui dossier più caldi, come le TEA, e favorire l’intesa tra tutti gli Stati membri”.
COLDIRETTI. “Abbiamo bisogno di tempi certi e urgenti per la maggiore flessibilità sugli aiuti di Stato e sulle semplificazioni della Pac annunciate dalla Commissione europea per gli agricoltori. Serve una risposta sulla moratoria dei debiti per le aziende agricole, in risposta all’aumento dei tassi di interesse. Molte delle nostre proposte sono state accolte dal Commissario europeo all’agricoltura, ma non basta se non si capisce una volta per tutte che i tempi dei nostri agricoltori non sono quelli della burocrazia europea. Ci aspettiamo che nel Consiglio europeo di marzo ci sia la svolta necessaria e anche in prospettiva chiediamo una Pac più vicina alle imprese”, ha detto Ettore Prandini, presidente di Coldiretti.