
Medioriente, rischio effetto domino su economia. Italia rinvia anche Med Dialogues
Il rischio di un effetto domino sull’economia è più che concreto. Non è difficile immaginare che sulla scrivania di Giorgia Meloni, al piano nobile di Palazzo Chigi, passino continui aggiornamenti sull’andamento delle borse, oltre a un flusso di informazioni costante sulle evoluzioni delle tensioni in Medio Oriente.
Il fronte è caldissimo non solo per la questione umanitaria, su cui anche la premier continua a battere sperando che si possa aprire uno spiraglio che consenta di far tacere le armi, ma anche per le conseguenze che il conflitto può, anzi sta già avendo sui mercati di gas, petrolio e molte altre voci che compongono il paniere del commercio internazionale. Il quantum dei vari rimbalzi sulla vita di famiglie, cittadini e imprese si comprenderà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, ma gli effetti si stanno già riverberando sull’attività di ogni governo. Compreso quello italiano, costretto a tirare il freno dei negoziati con i Paesi dell’Africa su quello che la premier ha chiamato Piano Mattei. Un progetto di cooperazione per fare dell’Italia l’hub energetico d’Europa, attraverso accordi per investire in diversi Paesi della sponda sud del Mediterraneo. La presentazione sarebbe dovuta avvenire il prossimo mese di novembre, al vertice Italia-Africa in programma a Roma, ma i venti di guerra del Medio Oriente hanno costretto a cancellare le date e spostare tutto al prossimo anno.
Adesso arriva anche un altro slittamento importante. A comunicarlo è la Farnesina: “A causa della congiuntura internazionale attuale, anche la IX edizione dei Med Dialogues, prevista a Roma dal 2 al 4 novembre prossimi, è rinviata al 2024, a data da destinarsi”. Un segnale che dà chiaramente la misura del livello di incertezza che offre lo scenario internazionale. Così come le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine ‘Al merito del lavoro’, sono un monito da tenere in grande considerazione. “La storia ci chiama a un’ora di responsabilità”, dice infatti il capo dello Stato, sottolineando che “l’aggressione russa in Ucraina, il barbaro attacco di Hamas contro Israele con la spirale di violenze che si è perseguita, la destabilizzazione che rischia di coinvolgere l’intero Medio Oriente, per restare solo nell’area del Mediterraneo allargato, reclamano un’Europa capace di esercitare la propria positiva influenza”, testimoniando “con convinzione i propri valori di pace, cooperazione, rispetto dei diritti delle persone e dei popoli”.
Tra gli effetti della guerra israelo-palestinese sull’Italia, c’è anche quello sui flussi di persone e merci sul territorio nazionale. Il governo, infatti, ha deciso di reintrodurre i controlli delle frontiere interne terrestri con la Slovenia, in base all’articolo 28 del Codice delle frontiere Schengen. La decisione è stata comunicata dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, alla vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, al commissario agli Affari interni, Ylva Johansson, alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, al segretario generale del Consiglio dell’Ue, Thérèse Blanchet, e ai ministri dell’Interno degli Stati membri Ue e dei Paesi associati Schengen. Palazzo Chigi spiega che “l’intensificarsi dei focolai di crisi ai confini dell’Europa ha aumentato il livello di minaccia di azioni violente anche all’interno dell’Unione. Un quadro ulteriormente aggravato dalla costante pressione migratoria cui l’Italia è soggetta, via mare e via terra (140 mila arrivi sulle coste italiane, +85% rispetto al 2022)”. L’esempio portato è il Friuli Venezia Giulia: “Dall’inizio dell’anno sono state individuate 16mila persone entrate irregolarmente” e “nelle valutazioni nazionali le misure di polizia alla frontiera italo-slovena non risultano adeguate a garantire la sicurezza richiesta”. L’Italia comunque assicura che “le modalità di controllo saranno attuate in modo da garantire la proporzionalità della misura, adattate alla minaccia e calibrate per causare il minor impatto possibile sulla circolazione transfrontaliera e sul traffico merci”.






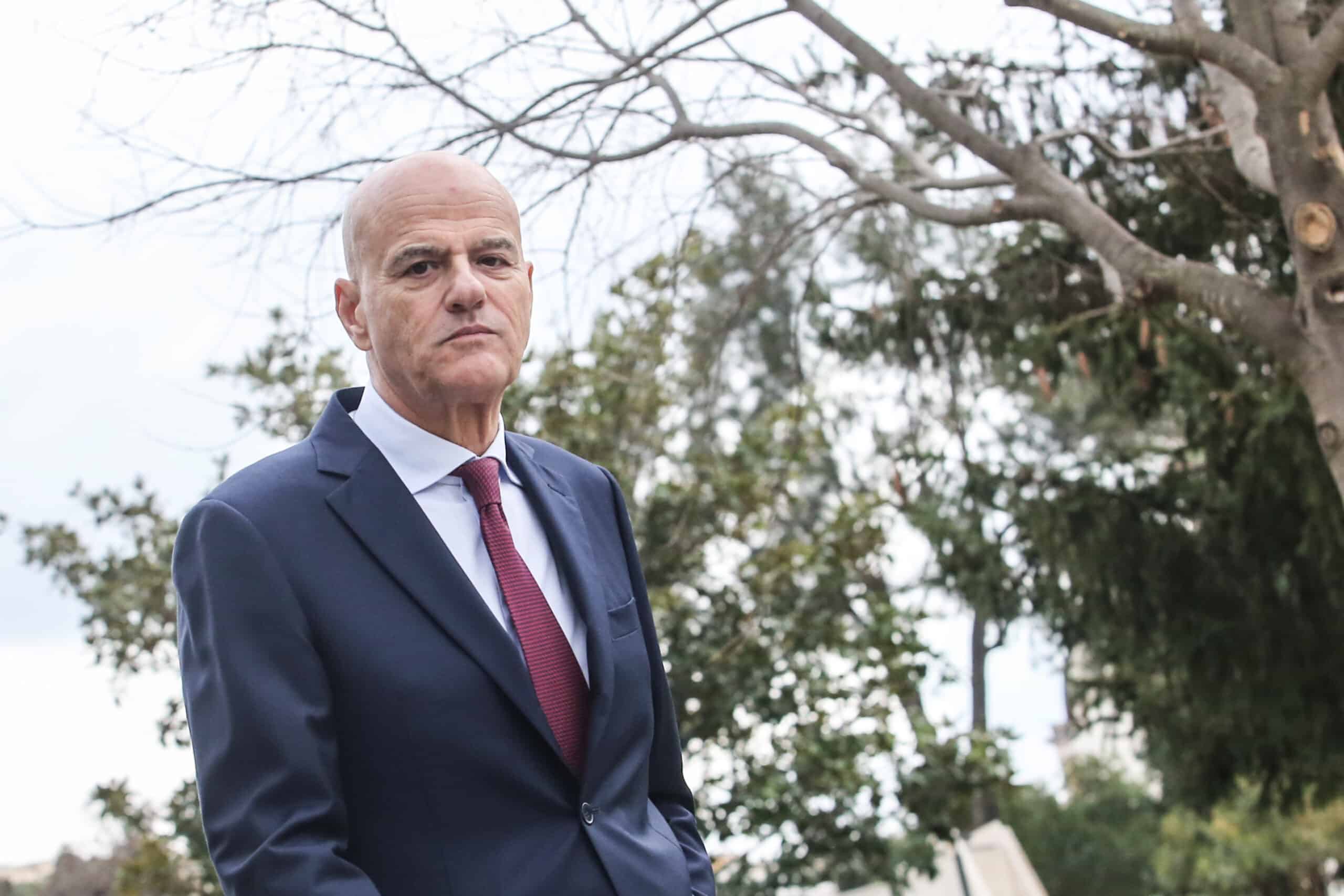
 Un ragionamento molto articolato, che parte dallo scenario in cui si trovano l’Europa e, di conseguenza, l’Italia: “Siamo un grande complesso di trasformazione industriale” ma senza “energia propria, quindi siamo in una grande macchina che però non ha energia. Come se avessimo comprato una Ferrari ma non abbiamo la benzina. Questa è la situazione”, spiega. Dunque, “quando si parla di sovranità o autonomia, vuol dire riuscire ad avere l’energia necessaria per far muovere la propria macchina, le proprie imprese”.
Un ragionamento molto articolato, che parte dallo scenario in cui si trovano l’Europa e, di conseguenza, l’Italia: “Siamo un grande complesso di trasformazione industriale” ma senza “energia propria, quindi siamo in una grande macchina che però non ha energia. Come se avessimo comprato una Ferrari ma non abbiamo la benzina. Questa è la situazione”, spiega. Dunque, “quando si parla di sovranità o autonomia, vuol dire riuscire ad avere l’energia necessaria per far muovere la propria macchina, le proprie imprese”.
