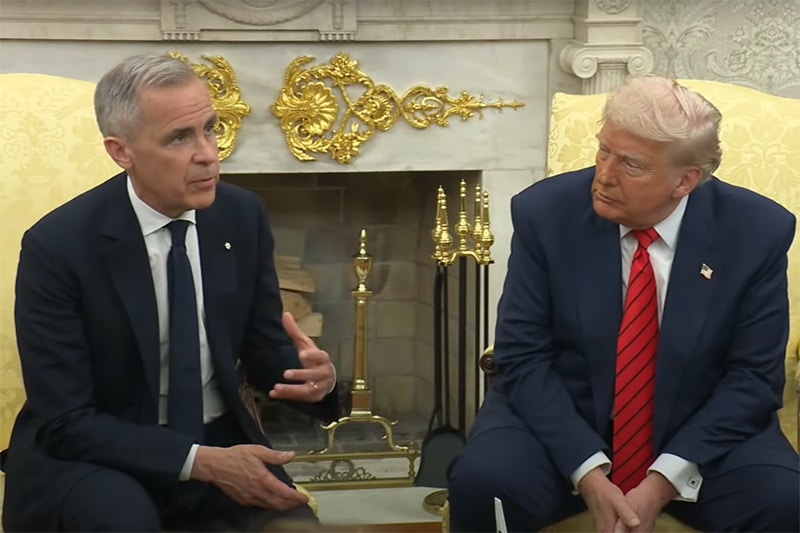Dazio di 3 euro sui pacchi extra Ue da 1 luglio 2026. Italia anticipa a 1° gennaio
Tre euro per pacco, a partire dal 1° luglio 2026: gli Stati europei hanno raggiunto un accordo sulla tassazione dei piccoli pacchi importati nell’Unione europea, con l’obiettivo di contrastare l’afflusso di prodotti cinesi a basso prezzo sul mercato europeo. Nel 2024 sono entrati in Ue circa 4,6 miliardi di spedizioni di valore inferiore a 150 euro, ovvero più di 145 al secondo. Di queste, il 91% proveniva dalla Cina.
Un mese fa, i ministri delle Finanze dei 27 hanno approvato l’abolizione, a partire dal prossimo anno, dell’esenzione dai dazi doganali di cui beneficiano questi “piccoli pacchi”. La misura si applicherà ai pacchi provenienti da tutti i paesi extra Ue, ma mira soprattutto a combattere l’ondata di prodotti cinesi a basso prezzo e spesso non conformi alle norme europee, acquistati su piattaforme asiatiche come Shein, Temu o AliExpress. Questo afflusso di pacchi importati senza alcun dazio doganale è denunciato con sempre maggiore vigore come una forma di concorrenza sleale dai produttori e dai commercianti europei. Inoltre, la mole di prodotti che arrivano negli aeroporti e nei porti europei è tale che i doganieri sono spesso incapaci di controllarne la conformità. In queste condizioni è difficile intercettare i prodotti pericolosi o contraffatti prima che arrivino nelle mani dei consumatori.
“L’introduzione di un importo forfettario sui piccoli pacchi è una vittoria importante per l’Unione europea”, ha dichiarato il ministro dell’Economia francese Roland Lescure, che ha portato avanti questa battaglia a Bruxelles. “Questi pacchi, oggi, (rappresentano) una concorrenza sleale rispetto al commercio dei centri cittadini che paga le tasse, quindi è essenziale agire e agire in fretta, altrimenti sarà troppo tardi”, aveva spiegato all’AFP prima di questa decisione.
La misura era in realtà già prevista nell’ambito della riforma dell’Unione doganale (il sistema doganale europeo), ma dovrebbe essere applicata solo nel 2028. I ministri dell’Economia dell’Ue hanno quindi concordato a Bruxelles un dispositivo transitorio, che si applicherà a partire dal prossimo 1° luglio e fino all’entrata in vigore di una soluzione permanente che dovrebbe accompagnare o precedere la riforma doganale.
A tal fine, dovevano trovare una soluzione semplice da attuare, in attesa che la piattaforma di dati doganali prevista dalla riforma, che dovrebbe facilitare notevolmente la riscossione dei dazi doganali, diventasse operativa. Applicare a partire dal 2026 ai piccoli pacchi i dazi doganali abituali, le cui aliquote variano a seconda delle griglie di categorie o sottocategorie di prodotti e in funzione dei paesi di importazione, sarebbe stato un compito titanico, con il rischio di congestionare ancora di più i servizi doganali già sovraccarichi.
La Francia aveva proposto ai suoi partner di imporre una “tassa forfettaria”, ovvero di importo fisso, piuttosto che una tassa proporzionale come raccomandato dalla Commissione europea. Ed è stata approvata l’opzione sostenuta da Parigi, molto più dissuasiva. Tuttavia, la misura entrerà in vigore solo a luglio, mentre Parigi aveva chiesto che fosse applicata già dal primo trimestre.
La tassazione dei piccoli pacchi è solo un primo passo nell’offensiva dell’Ue contro la valanga di prodotti cinesi che entrano nel suo territorio: dovrebbe essere accompagnata dall’introduzione, a partire da novembre 2026, di spese di trattamento su questi stessi pacchi di valore inferiore a 150 euro. Bruxelles ha proposto a maggio di fissarle a due euro per pacco. Questa somma contribuirà a finanziare lo sviluppo dei controlli e, secondo l’Ue, insieme alla riscossione dei dazi doganali, aiuterà a riequilibrare le regole del gioco tra i prodotti europei e la concorrenza “made in China”. Inoltre, diversi paesi membri, hanno già annunciato l’introduzione di tali spese di gestione a livello nazionale. Tra questi c’è anche l’Italia: un emendamento del governo alla Legge di Bilancio, infatti, prevede di tassare tutti i piccoli pacchi in entrata e provenienti da paesi extraeuropei a partire dal 1° gennaio 2026, quindi prima dell’introduzione della tariffa prevista a livello europeo.