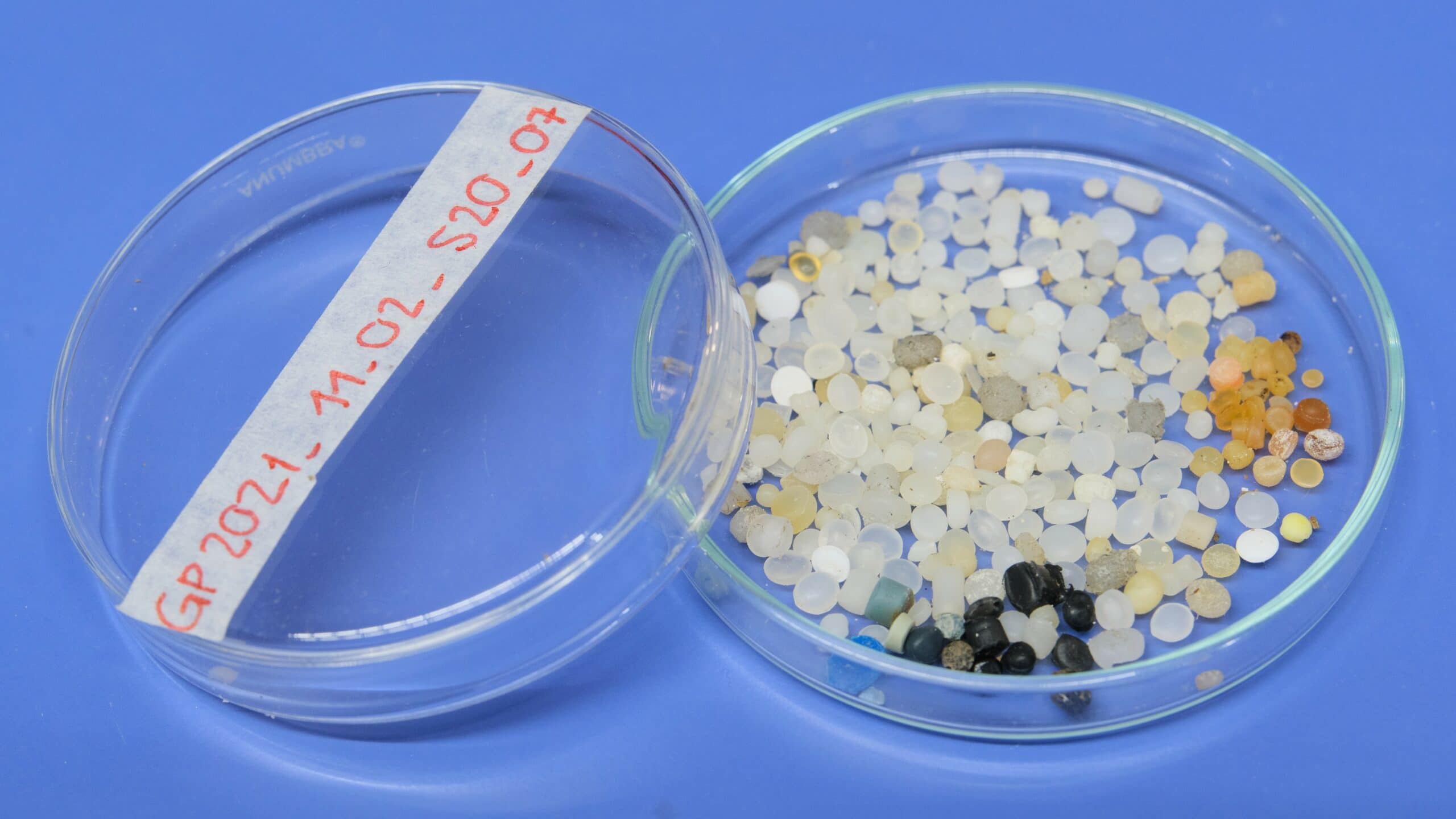Un italiano su due pedala. Ma l’Italia non è (ancora) un Paese per bici
Se c’è un mezzo di trasporto che di fronte alla parola ‘emissioni’ può ritenersi al sicuro da ogni responsabilità, quello è la bicicletta. Amata e utilizzata regolarmente – ogni giorno o, almeno, una volta alla settimana – dal 50% degli italiani, può contare su 4700 chilometri di piste ciclabili (in crescita di oltre il 15% dal 2015). I dati, contenuti nel rapporto del Mims ‘Verso un nuovo modello di mobilità locale sostenibile’, raccontano che la densità è molto maggiore nelle città del nord (57,9 km per 100 km2, contro 15,7 del centro e 5,4 del Mezzogiorno). Tra i capoluoghi metropolitani, Torino e Milano presentano i valori più elevati (166,1 e 123,3 km per 100 km2), seguiti da Bologna e Firenze (poco meno di 100). E proprio il Piemonte punta a diventare la prima regione in Europa per chilometri ciclabili attrezzati. Per farlo sono stati messi in campo 40 milioni di euro di fondi europei per attuare il Piano regionale della mobilità ciclistica. Il Pnrr, poi, a livello nazionale, prevede investimenti per 600 milioni di euro per finanziare la realizzazione delle ciclovie turistiche (400 milioni) e delle ciclovie urbane (200 milioni), per un totale di 1.800 chilometri.
Recentemente il ministro dei Trasporti e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha ricordato che nel 2022 le Regioni si sono “azzuffate” sulle risorse da destinare alle piste ciclabili, “proprio come hanno sempre fatto su strade e ferrovie“. “Segnale – ha detto – che la mentalità è cambiata“. Della stessa opinione anche Alessandro Tursi, presidente della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta), che ricorda come la bici sia “una soluzione climatica, energetica, sociale e urbanistica fondamentale, e come tale deve diventare una priorità”. E anche l’Europa, come spiega la commissaria per l’Energia, Kadri Simson, “fa riferimento alla sostenibilità della mobilità ciclabile per aumentare l’indipendenza a livello energetico“.
I capoluoghi italiani con servizi di bike sharing sono 53 (di cui solo 8 nel Mezzogiorno). L’offerta pro capite è più che triplicata nel corso degli ultimi anni, passando da 6 a 19 biciclette ogni 10.000 abitanti tra il 2015 e il 2019. Anche in questo caso l’offerta è più elevata nei comuni capoluogo di provincia del Centro (17) e del Nord (32), a fronte di valori modesti nel Mezzogiorno (2). Il fenomeno è concentrato prevalentemente nei comuni capoluogo delle città metropolitane come Firenze (109 biciclette ogni 10.000 abitanti), Milano (96), Bologna (68) e Torino (35).
Sul fronte economico i dati sono incoraggianti. La mancanza di prodotto, le difficoltà globali di approvvigionamento e i ritardi nelle consegne, che interessano la filiera del pedale negli ultimi anni, non frenano il desiderio di bici degli italiani. Secondo i dati di Confindustria Ancma, dopo i numeri record del 2020, con oltre 2 milioni di pezzi venduti – merito anche del bonus bici – il mercato 2021 sfiora infatti il dato dell’anno precedente, fermandosi a 1.975.000, pari a un -2%. Eppure, nonostante i dati positivi, “non siamo ancora davvero un Paese ciclabile”, dice Piero Nigrelli, responsabile comparto bici di Ancma. “I cittadini lo stanno dicendo: ‘È bello avere la bici, ma è ancora più bello poterla usare al meglio’. I due anni di pandemia lo hanno dimostrato”. Ecco allora che, ancora una volta, il Pnrr potrebbe venire in soccorso. “È tutto pronto”, afferma Nigrelli, per far partire i cantieri delle nuove ciclovie, “ma mancano i tecnici per seguirli. Ci auguriamo che i soldi vengano utilizzati e spesi beni. Per farlo ci va coraggio”.
Intanto dal 16 al 22 settembre si svolgerà la ‘Settimana europea per la mobilità’. Per l’edizione 2022 la Commissione Europea ha scelto di sottolineare l’importanza di una maggiore sinergia per aumentare la consapevolezza verso la mobilità sostenibile e per promuovere un cambiamento degli stili di vita in favore di una mobilità attiva.