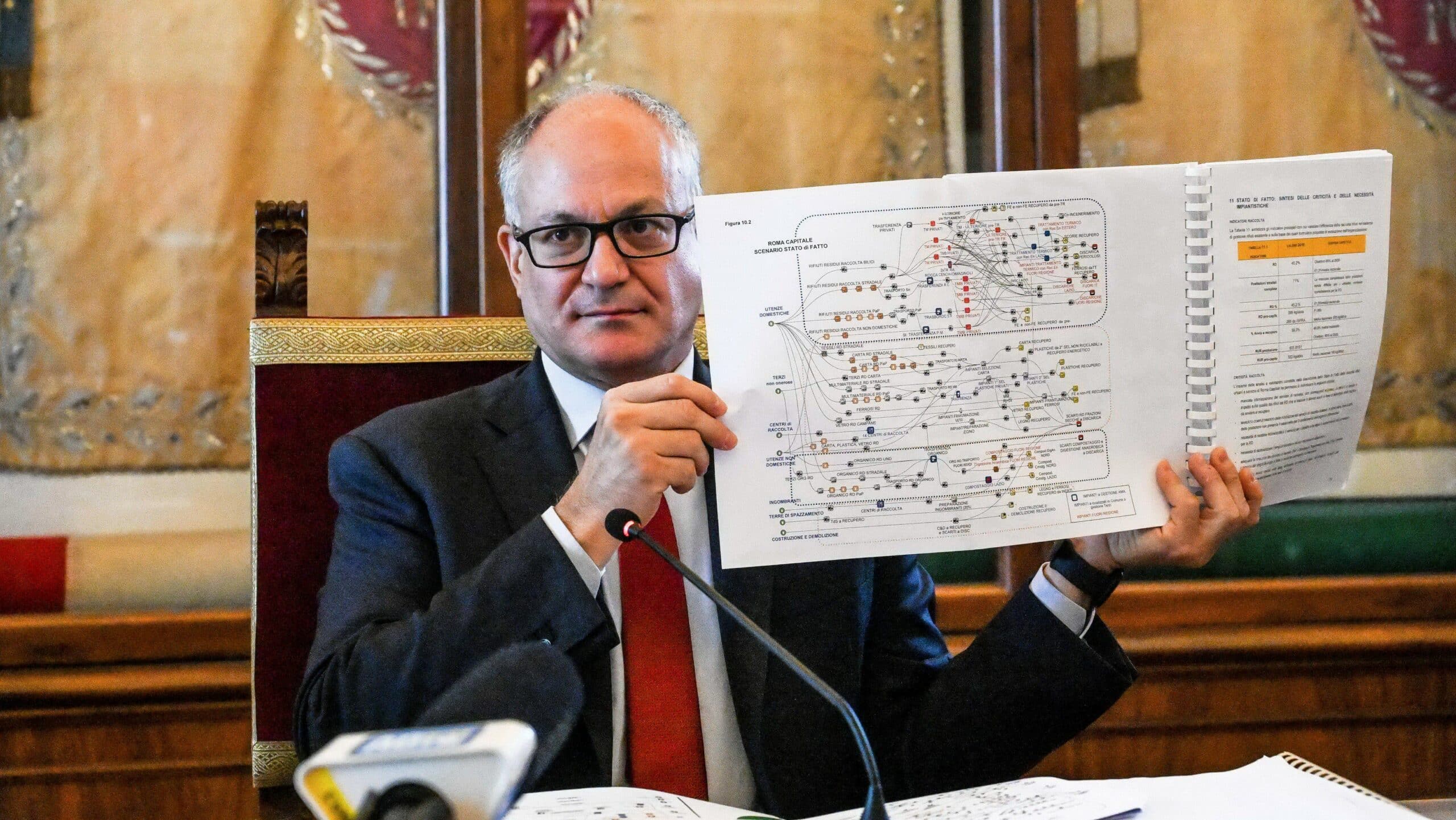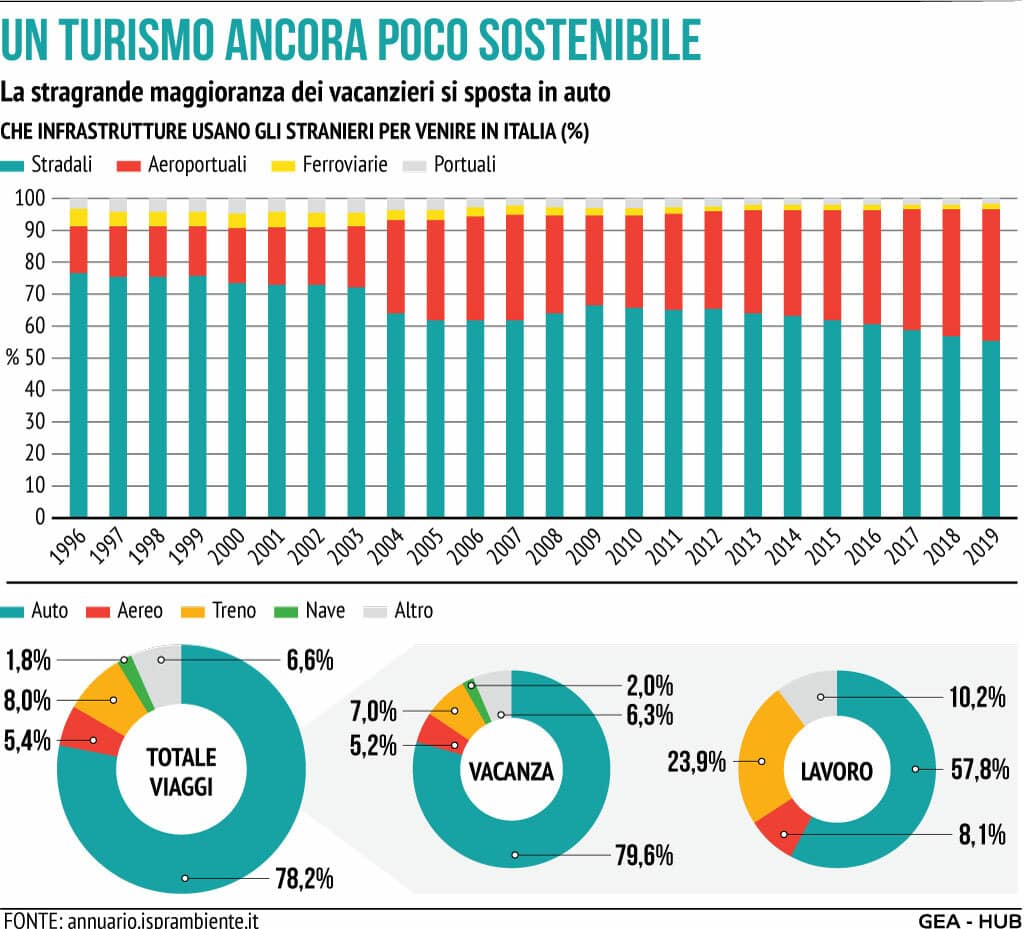La povertà energetica affligge 30 milioni di persone in Ue
Non poter tenere accesi i riscaldamenti per il tempo che servirebbe, o addirittura non poterli accendere affatto. Un problema che affligge oltre 30 milioni di persone in tutta l’Unione europea. Un fenomeno, quello della povertà energetica, anche non semplice da quantificare. Sono sempre mancati sistemi efficienti di dati, e tra i Ventisette è sempre mancata una definizione univoca di ‘povertà energetica’ con criteri armonizzati di calcolo e misurazione. La Commissione europea ha provato a fare un censimento, e il risultato, aggiornato al 2018, parla di 33,8 milioni di persone in questa condizione (dato a 27, senza il Regno Unito poi uscito dall’Ue), non in grado di vivere in ambienti caldi. Ma le stime realizzate successivamente, nel 2020, vedono interessato l’8% della popolazione dell’Ue, vale a dire circa 35,8 milioni di cittadini e cittadine dei diversi Paesi. Un dato aggravato dalla pandemia e dalla cresciuta domanda per consumi spostati dall’ufficio professionale allo studio domestico, e in prospettiva, complice il caro-prezzi, la dimensione del fenomeno potrebbe crescere ancora.
“La povertà energetica è una delle principali sfide dell’Unione europea”, riconoscono i tecnici dell’esecutivo comunitario nei loro documenti di lavoro, quelli che accompagnano le scelte del collegio e le proposte di misure. Ed è innegabile che la soluzione non è né semplice né immediata, perché la povertà energetica “è il risultato di più fattori”, quali bassi livelli di reddito, bollette elevate, edifici vecchi dalle grandi dispersioni. Servirà un mix di misure, che passano da una riforma del mercato del lavoro e interventi sui salari, calmierazione dei prezzi, ristrutturazioni. La transizione verde, dunque, soprattutto per quanto riguarda efficienza energetica nell’edilizia e produzione di rinnovabili “è sia una sfida, sia un’opportunità”. Di questo a Bruxelles sono convinti.
Velocizzare le riforme necessarie in termini di sostenibilità, potrà permettere di strappare i cittadini dalla povertà energetica e invertirne l’andamento del tasso. Intanto però c’è il corrispettivo di oltre metà Italia alle prese con la carenza di energia che servirebbe per vivere comodamente. I 33,8 milioni del 2018 e i 35,8 milioni del 2020 rappresentano anche più abitanti del Benelux, o, per fare ancora un altro paragone, una fascia di popolazione più ampia di quella di Paesi scandinavi (Danimarca, Finlandia e Svezia) e repubbliche baltiche (Estonia, Lettonia, Lituania) messi assieme. Spetterà anche all’Italia il compito di trovare una risposta a tutto questo, dato che il Paese è sesto nell’Ue per quota di famiglie incapaci di mantenere l’abitazione adeguatamente riscaldata o climatizzata. Il tasso tricolore risulta al 14,1%. Peggio solo Bulgaria (33,7%), Lituania (27,9), Grecia (22,7%), Cipro (21,9%) e Portogallo (19,4%). Risalta come l’Italia sia l’unica delle principali economie dell’eurozona a registrare così tanti cittadini affetti da povertà energetica. Nel piano nazionale d’azione per l’energia e il clima notificato alla Commissione alla fine del 2019, l’allora governo Conte confermava intenzione e impegno a contrastare il fenomeno, ma poi quel governo è caduto, è sopraggiunta la guerra in Ucraina con le ripercussioni sui prezzi dell’energia, e da ultimo la crisi del governo Draghi. Tutte cose che certamente non agevolano il compito.