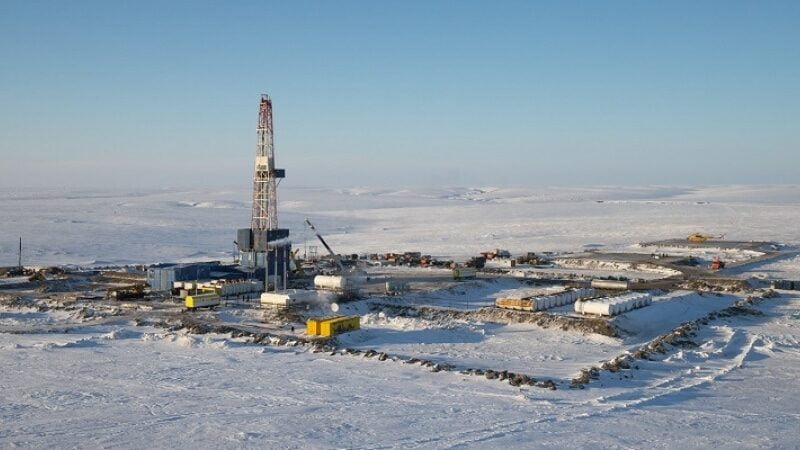Ecuador, il petrolio è l’oro nero ma sta uccidendo l’Amazzonia
Tutto ebbe inizio un giorno di febbraio del 1967. Il ‘pozzo Lago Agrio n. 1’ fu il primo pozzo petrolifero trivellato in Ecuador, dal consorzio americano Texaco-Gulf, aprendo l’era dell’oro nero nell’Amazzonia ecuadoriana. “Quel giorno, ministri e funzionari fecero il bagno nel petrolio. Poi gettarono tutto nel fiume dietro di loro… fu un buon inizio”, racconta Donald Moncayo, coordinatore generale dell’Unione delle vittime della Texaco (Udapt). Cinquantasei anni dopo, il petrolio, principale esportazione del Paese, continua a scorrere. Lago Agrio è diventata la capitale petrolifera del Paese, la foresta si sta costantemente ritirando e l’inquinamento continua a causare danni, dicono gli attivisti locali.
Del pozzo n. 1 rimane la pompa in acciaio con la testa di cavallo, congelata in mezzo a un prato verde, sormontata da un bel segno di ricordo. È stato chiuso nel 2006, dopo aver prodotto quasi 10 milioni di barili. Ma in tutta la regione, che è stata colonizzata economicamente dallo Stato fin dagli anni ’60, milioni di ettari di pozzi, oleodotti, cisterne, autocisterne, stazioni di lavorazione e torce sono tutti lì… in una strana sovrapposizione di petrolio nero e vegetazione lussureggiante.
Il petrolio in Ecuador significa quasi 500.000 barili al giorno e una media di 13 miliardi di dollari all’anno di entrate. Una benedizione per le casse dello Stato e per lo “sviluppo” del Paese, secondo le autorità. Una maledizione sinonimo di debito, povertà e inquinamento su larga scala, afferma Donald Moncayo senza alcuna concessione. L’uomo, 49 anni, “nato a 200 metri da un pozzo petrolifero”, dagli anni ’90 conduce una difficile e interminabile crociata contro la Texaco, insieme a un manipolo di altri attivisti.
La storia è nota: nel 1993, circa 30.000 abitanti della regione hanno presentato una denuncia contro il gigante americano (dal 2001 di proprietà della Chevron) presso un tribunale di New York. In 30 anni di attività, l’azienda ha scavato 356 pozzi e per ognuno di essi ha creato bacini di ritenzione (880 in totale) che raccolgono resti di petrolio, rifiuti tossici e acqua contaminata (60 milioni di litri in totale, secondo l’Udapt). Queste ‘piscine’, sparse per la foresta, hanno causato un grave disastro ecologico, spesso citato come uno dei peggiori disastri petroliferi della storia. Dopo molti procedimenti e colpi di scena, nel 2011 la Texaco, ora Chevron, è stata condannata dalla giustizia ecuadoriana a pagare 9,5 miliardi di dollari per riparare i danni. Nel 2018, però, il colosso americano ha ottenuto l’annullamento della sentenza davanti alla Corte permanente di arbitrato dell’Aia. “Texaco ha saccheggiato questa parte dell’Amazzonia. Da allora, hanno fatto di tutto per sfuggire alla giustizia e non hanno pagato un centesimo per riparare i danni. Che paghino”, ha detto Moncayo. La Chevron ha dichiarato che la Texaco ha pagato 40 milioni di dollari per ripulire l’area.
Abbandonato nel 1994, il pozzo “Agua-Rico 4” è ora nascosto nella foresta alla fine di un piccolo sentiero. Basta un bastone per rompere lo strato di humus che ricopre la vecchia vasca e far uscire un liquido nero e denso. Anche un ruscello sottostante è sporco. “È così dappertutto”, dice Donald Moncayo, i cui guanti bianchi da chirurgo sono imbrattati dalla spugna grezza sul terreno. Qui è stata costruita una capanna di legno accanto a una vecchia piscina. Qui le mucche pascolano sull’erba, mentre il greggio emerge dal sottosuolo. “Il bestiame lo mangia come una gomma da masticare”, brontola l’attivista.
All’epoca, fu la Chiesa cattolica locale a lanciare l’allarme per l’inspiegabile aumento di problemi di salute, aborti e tumori. Quando Texaco ha lasciato l’Ecuador negli anni ’90, ha ceduto i suoi pozzi alla Petroecuador, di proprietà dello Stato, che ha continuato a operare. Secondo l’Udapt, le piscine lasciate dalla compagnia statunitense non sono state in gran parte decontaminate. Chevron sostiene che Texaco era allora “solo un partner di minoranza” in un consorzio con Petroecuador. E che quest’ultima, nonostante un accordo del 1995 con Texaco, “non ha effettuato la bonifica ambientale che era obbligata a fare e ha continuato a operare e sviluppare le sue attività”.
“I problemi sono continuati con Petroecuador”, dice Moncayo. Dal 1995, la compagnia ha reiniettato l’acqua contaminata nel terreno, un processo considerato più pulito. “Ma a mio parere, solo dove monitoriamo. Altrove, gettano l’acqua tossica nei fiumi”, dice. L’inquinamento deriva anche dalle perdite di greggio dagli oleodotti (tra 10 e 15 al mese, secondo uno studio dell’Università di Quito e dell’Udapt) o dalle 447 torce che bruciano notte e giorno.
Dopo essere salito al potere nel 2021, il presidente Guillermo Lasso ha promesso di raddoppiare la produzione di petrolio fino a un milione di barili al giorno.