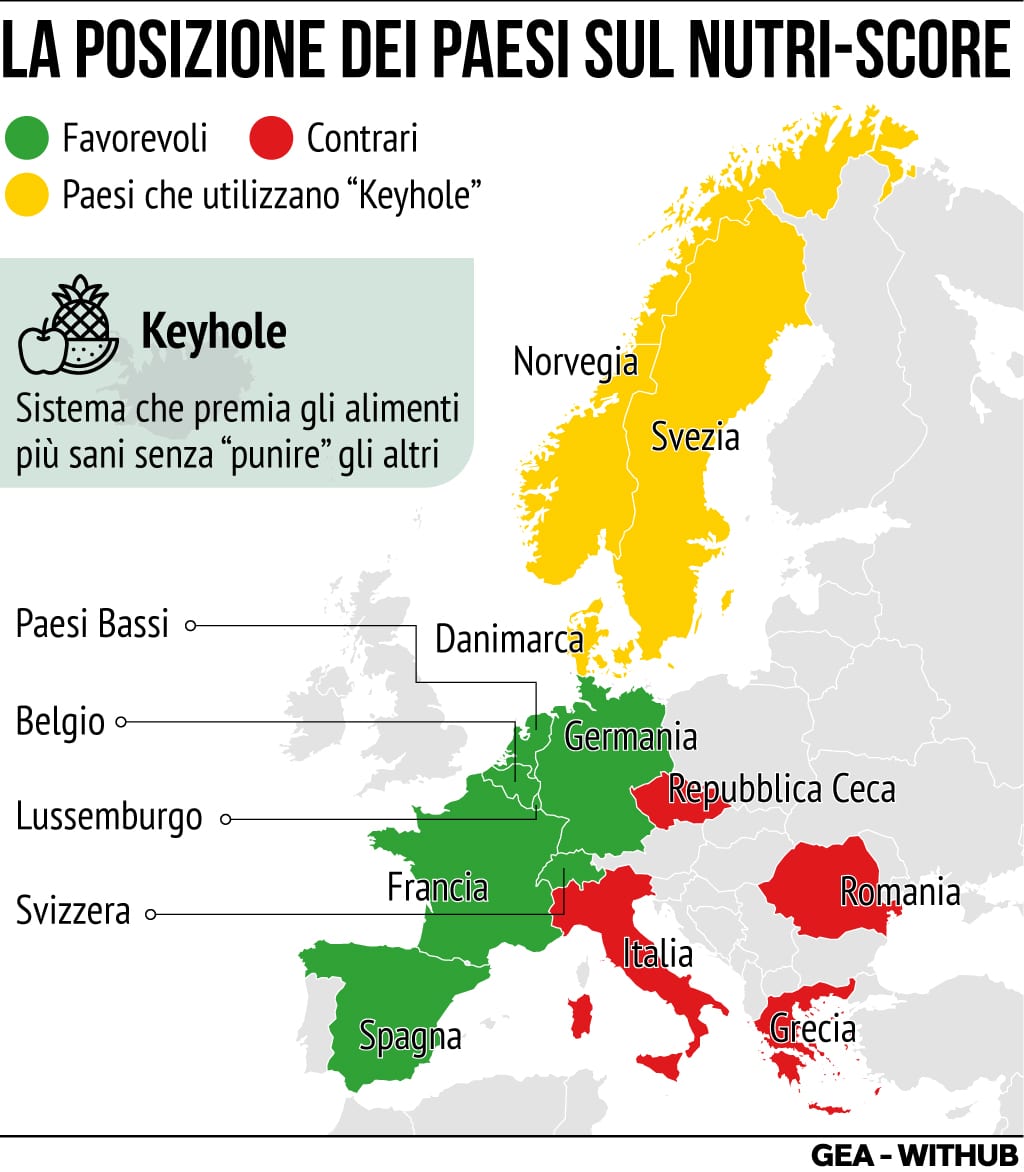Meloni: “Su governace Ue passi avanti, ma insufficienti. Escludere le transizioni”
Zagabria, Europa. Forse di quella con la visione che Giorgia Meloni sente più vicina alla sua. Dalla Croazia, al termine dell’incontro bilaterale con il primo ministro della Repubblica croata, Andrej Plenković, la premier torna a lanciare messaggi alle istituzioni continentali, mentre la partita del negoziato sulla nuova governance è più o meno alla metà del tempo regolamentare. Parole decisamente chiare, quelle della presidente del Consiglio: “Mi pare che dei passi avanti si facciano, ma per per quello che riguarda l’Italia sono ancora insufficienti, quindi bisogna lavorare molto di più”.
Meloni spinge sul fatto che “il ritorno ai vecchi parametri, che scatterebbero molto presto, sarebbe esiziale per la nostra economia”. Tradotto, se dal 1 gennaio del prossimo anno si ritornasse ai vincoli pre-pandemia del Patto di stabilità e crescita, il tetto del 3% del rapporto tra Deficit e Pil difficilmente verrà raggiunto. Molto probabilmente, non solo dal nostro Paese. Ma questo Meloni non può saperlo, né può dirlo. Il capo del governo italiano si ‘limita’ a ricordare che “il tema delle nuove regole della governance è fondamentale per l’agenda strategica Ue”, perché “se pensiamo di poter rafforzare la nostra competitività, il nostro ruolo strategico senza adeguare le regole alle strategie che ci diamo, rischiamo di sembrare miopi”.
La premier ribadisce un concetto già espresso molte volte: “Siamo impegnati a portare avanti delle transizioni che sono scelte strategiche per rafforzare la competitività del continente: penso alla transizione verde e alla transizione digitale, così come, all’indomani dell’aggressione russa all’Ucraina, ci siamo resi conto del fatto che anche il tema difesa necessitava di un rafforzamento”. Ergo: “E’ evidente che gli investimenti fatti su queste materie devono essere presi in considerazione nel momento in cui si discute la governance, altrimenti è come se indicassimo una strategia e contemporaneamente la facessimo pagare alle nazioni virtuose nel realizzarla. Questo sarebbe miope”.
Intanto, a proposito di transizione energetica, dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica arrivano buone notizie. Perché c’è il via libera ad uno stanziamento di 502 milioni di euro per promuovere, nel triennio 2024-2026, la ricerca e lo sviluppo di tecnologie energetiche innovative a zero emissioni di carbonio. Questo è il target che si pone il decreto firmato dal ministro, Gilberto Pichetto, che fissa le linee di attività e le modalità attuative del programma internazionale ‘Mission Innovation‘ a cui l’Italia aderisce insieme ad altri 24 Paesi. “Il nostro impegno per sostenere la transizione energetica del Paese si rafforza ulteriormente con un consistente aumento di risorse pubbliche dedicate al sostegno della ricerca e dell’innovazione di tecnologie pulite per contenere le emissioni climalteranti”, commenta il responsabile del Mase. Che poi conclude: “Andiamo avanti su questa strada con convinzione e pragmatismo per arrivare con ancora maggiore determinazione al negoziato della Cop 28 di Dubai”.