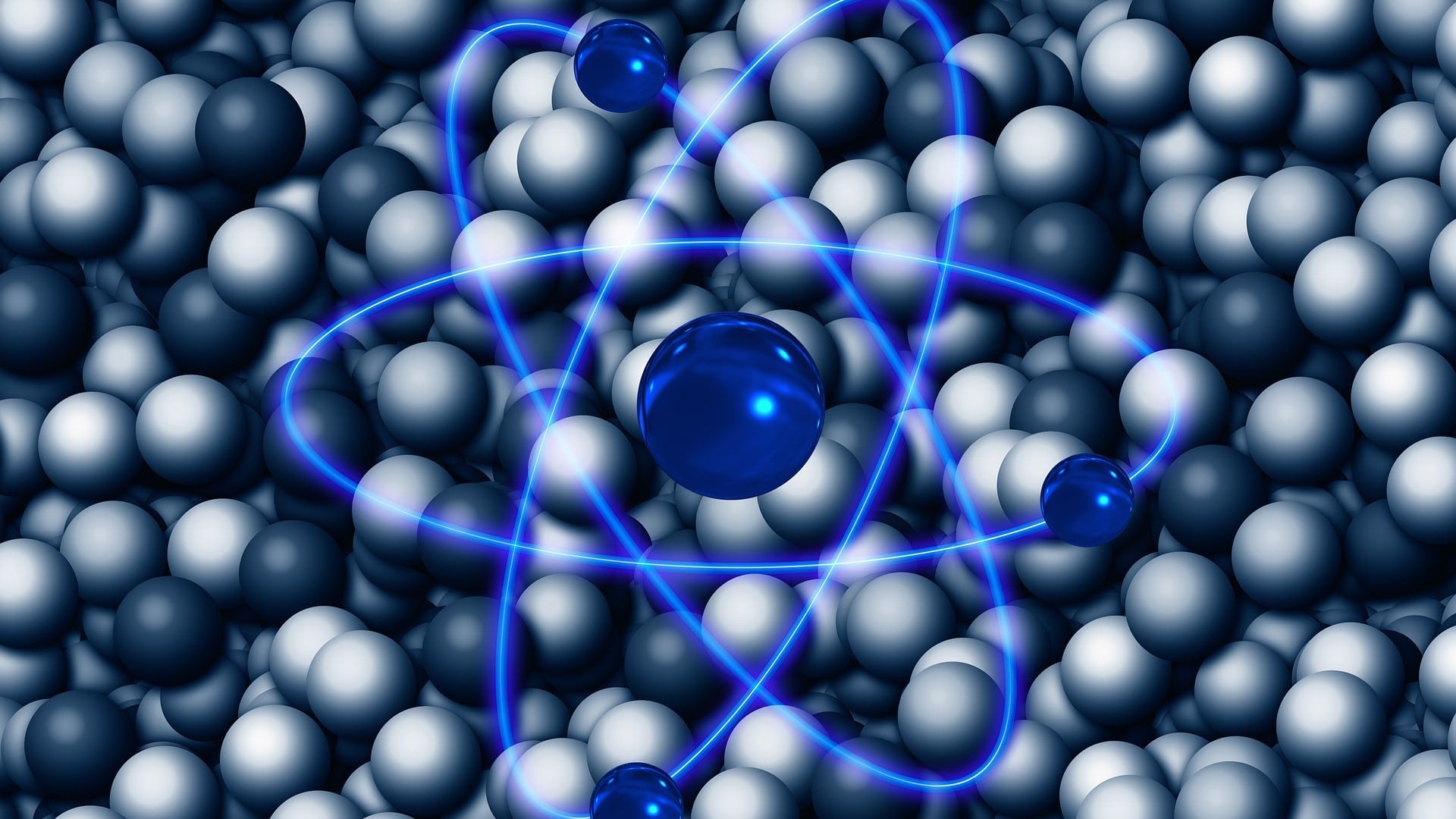Appello a Europa di Confindustria-Medef-Bdi: “Siamo troppo indietro, rischiamo declino”
Italia, Francia e Germania insieme, per far correre l’Europa più forte. Le tre associazioni degli industriali (Confindustria, Medef e Bdi) si danno appuntamento a Roma per il settimo Forum Trilaterale e firmano una dichiarazione congiunta che è un appello urgente a Bruxelles: “Si rischia il declino industriale”, denunciano.
Con i presidenti Emanuele Orsini, Peter Leibinger e Patrick Martin, nella Capitale, tra le corsie di Santo Spirito in Sassia, arriva anche Stéphane Séjourné. Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea promette, presto, decisioni strategiche, su auto, chimica e acciaio: “Dovremo prenderle nelle prossime settimane”, afferma. Dall’inizio del mandato, la Commissione europea ha cambiato radicalmente il suo approccio, ricorda: “Stiamo integrando l’industria ovunque, ci siamo allontanati da questo approccio a compartimenti stagni, stiamo organizzando un dialogo continuo”. La politica di decarbonizzazione, ma anche l’occupazione, la concorrenza e tutte le politiche commerciali estere, rivendica il vicepresidente, “vengono ora esaminate alla luce delle sfide che il settore industriale si trova ad affrontare”.
“Oggi l’Europa si trova a un bivio. Il mondo sta cambiando e l’Europa non può restare a guardare”, si legge nel testo sottoscritto dalle organizzazioni. “Ora più che mai, deve affermare la propria indipendenza, proteggere la sicurezza comune e assumere la leadership nello sviluppo delle tecnologie essenziali per i propri interessi strategici”. Gli imprenditori delle prime tre economie dell’Unione europea ritengono sia giunto il momento di riconoscere che l’Europa sta “seriamente rimanendo indietro e che il rischio di declino e deindustrializzazione è oggi più alto che mai”. Gli industriali si richiamano ai Rapporti Draghi e Letta per chiedere che si compia un passo avanti decisivo, per rafforzare la resilienza e l’autonomia strategica del continente, colmare il divario di competitività nelle principali catene del valore e promuovere la ricerca e l’innovazione. Per invertire la rotta, le tre organizzazioni individuano sei priorità: semplificare le regole e completare il mercato unico; fare della decarbonizzazione un motore di competitività; rafforzare la sovranità tecnologica; costruire un bilancio orientato alla crescita; pensare a una strategia per le scienze della vita; investire nell’autonomia strategica con la difesa e lo spazio. Nel documento conclusivo, le tre organizzazioni avvertono che, senza una politica industriale forte, l’Europa rischia di perdere influenza, sicurezza e benessere. In collaborazione con BusinessEurope, si impegnano a promuovere una visione di Europa industrialmente solida, digitalmente autonoma e sostenibile. “La competitività deve diventare la bussola di ogni politica, regolamentazione e investimento europeo”, è l’appello finale degli imprenditori francesi, tedeschi e italiani.
Quelli appena trascorsi, sono stati tre giorni di incontri “molto importanti”, sottolinea Orsini parlando con i cronisti. Il presidente degli industriali italiani lamenta una mancanza di proattività nelle istituzioni comunitarie: “Purtroppo un’Europa che non fa è un’Europa che non serve e lo dico da europeista convinto”, confessa. Il vero problema, per Orsini, è che i tempi dell’industria non sono sincroni con i tempi dell’Europa e il rischio di una deindustrializzazione europea a favore della competitività di altri continenti come la Cina e gli Stati Uniti è “molto forte”. Quindi, insiste: “Abbiamo bisogno di azioni vere, forti e subito”.
Per l’industria francese la priorità è “lavorare insieme”, fa eco Fabrice Le Saché, vicepresidente di Medef. Ricorda che Parigi, Roma e Berlino insieme valgono il 60% del Pil europeo e rivendica la possibilità di ‘guidare’ il vecchio Continente a tre sui dossier più caldi che coinvolgono l’industria. “Siamo 27 Paesi, se dobbiamo sempre avere discussioni molto lunghe non si va avanti”, ribadisce, precisando che “la cosa più importante è che Confindustria, Medef e BDI oggi abbiano deciso lavorare di più insieme a Bruxelles e Strasburgo, perché se vanno d’accordo l’Europa avanza molto più velocemente”. RIB