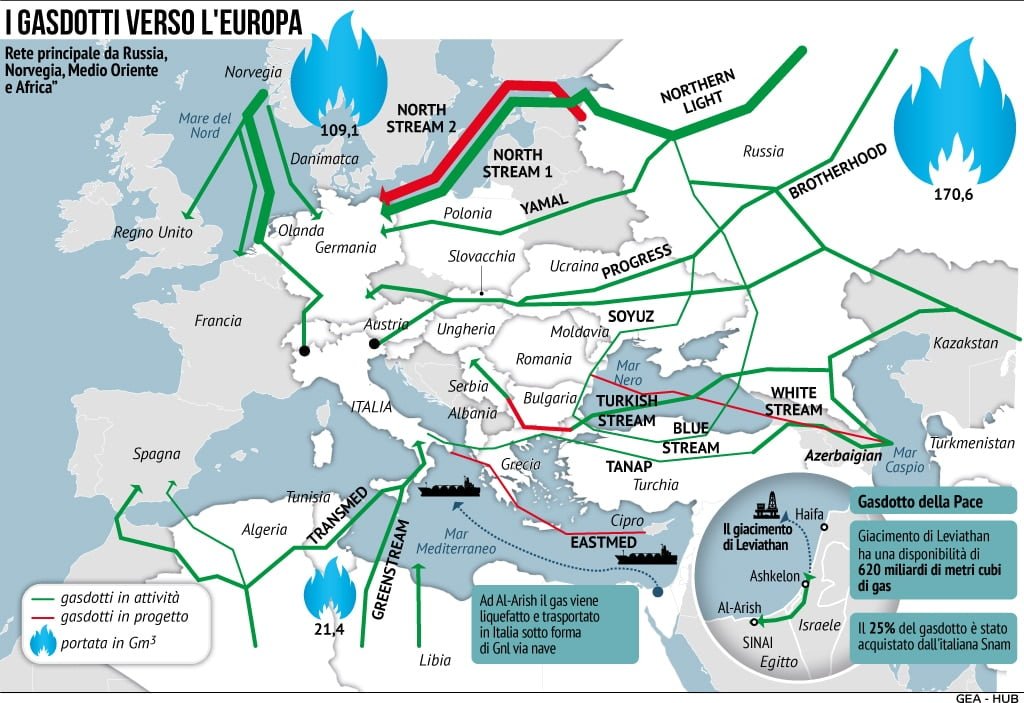Energia, Cingolani: Alleanza globale come Covid. Nucleare utile
Il tetto europeo al prezzo del gas è un’ottima notizia, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Ne è consapevole il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che mette in fila tutte le varianti per uscire dalla dipendenza russa (“letale per l’economia“) e avviare una nuova strategia energetica che metta al riparo da speculazioni e oscillazioni del mercato, soprattutto quelle speculative. Perché ormai “siamo già in recessione“. Alla base di tutto, però, c’è la necessità di creare una “alleanza globale” anche per l’energia, sulla falsariga di quanto avvenuto in questi anni per contrastare la pandemia: “Avevamo detto che per sviluppare un vaccino per il Covid ci volevano 8-10 anni, ma abbiamo collaborato e l’abbiamo sviluppato in 8 mesi“, è l’esempio che porta il ministro. Anche perché la guerra in Ucraina “avrà un forte impatto sulla transizione ecologica“, avverte. Ricordando che “la grande sfida” in questa fase storica è “mantenere la barra dritta, investire nelle nuove tecnologie e rivedere le regole di mercato, altrimenti arriveremo al 2030 inadatti ad accogliere le sfide della decarbonizzazione“.
Le responsabilità, però, hanno un passato lungo. “Avremmo dovuto avere una visione più chiara – sottolinea Cingolani – avremmo dovuto essere più intelligenti per gestire al meglio il mix energetico“, ecco perché “è ora di cambiare“, servono “fonti verdi programmabili ed è necessario lo sviluppo di nuove tecnologie” nell’ambito “della cattura del carbonio, della fusione nucleare, di piccoli reattori moderni“. Già, quel nucleare che fa sobbalzare dalla sedia associazioni e partiti politici, ma che nella sua accezione moderna è “una strada che va esplorata e considerata in questa fase“, secondo il ministro. “E’ un esempio di tecnologia utile, basata su materiali con radiazioni molto più basse” rispetto al passato e “gli stabilimenti possono essere costruiti off shore, funzionano, vanno bene, se vengono spenti non creano fenomeni pericolosi e dopo 30 anni vengono smantellati“, elenca. Ribadendo il concetto: “Si tratta di un sistema molto utile in una fase di transizione. Può essere una fonte importante, anche se non esclusiva” e soprattutto “offre molte opportunità“, quindi “è un bene investire in questo tipo di tecnologia“.
Perché la realtà dei fatti va guardata a 360 gradi e senza pregiudizi. Grandi alternative, al momento, non sono esplorabili, come l’energia delle onde, perché “quella derivata dal mare è troppo cara“. Anche se “buona e illimitata, non possiamo permetterci delle energie che siano così costose e difficili da produrre“, ammonisce Cingolani, che invece punta su “fonti accettabili anche in termini economici“. Per inciso, il responsabile del Mite conferma, ancora una volta, che in funzione della carenza di energia “molti Paesi stanno riprendendo le centrali a carbone“, ma all’Italia “questo non succederà“. Semmai occorre puntare su strumenti come il riciclaggio e la seconda vita dei prodotti, su cui “stiamo investendo molto“, perché “l’economia circolare è una risorsa fondamentale per la transizione energetica“.
Altro capitolo che resta cruciale è quello delle rinnovabili, su cui l’Italia mette diverse fiches nella strategia nazionale, anche se “il processo di transizione verso il sistema energetico decarbonizzato basato sulle fonti rinnovabili necessità di un rafforzamento e potenziamento Rete elettrica di trasmissione nazionale“, ammette Cingolani. Ricordando che il gestore del servizio elettrico nazionale, Terna, ha “una programmazione con investimenti per oltre 18 miliardi di euro nel decennio“. Il cerchio, infine, si chiude tornando al price cap, che una parte di maggioranza vorrebbe non solo europeo, ma anche nazionale sulla scorta di quanto fatto da Spagna e Portogallo. Modello che per il ministro “non è replicabile come formula nel nostro Paese“.
Oltre al problema dell’approvvigionamento energetico, l’Italia sconta anche altri effetti negativi dall’azione speculativa dei mercati e dal conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina. Come quello dell’aumento dei prezzi dei carburanti. Finora il governo è intervenuto per mitigare l’effetto dei rincari ed è pronto a farlo ancora. Anzi, “è molto probabile” che Palazzo Chigi vari nuovi provvedimenti a breve sulle accise, come anticipa ai microfoni di ‘RaiNews24‘ la sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia Guerra: “L’aumento – spiega – fa crescere anche il gettito dell’Iva“, che “non vogliamo mettere nelle casse dello Stato“, ma utilizzarlo per “tenere calmierato” il costo dei carburanti. La partita strategica, dunque, resta apertissima.