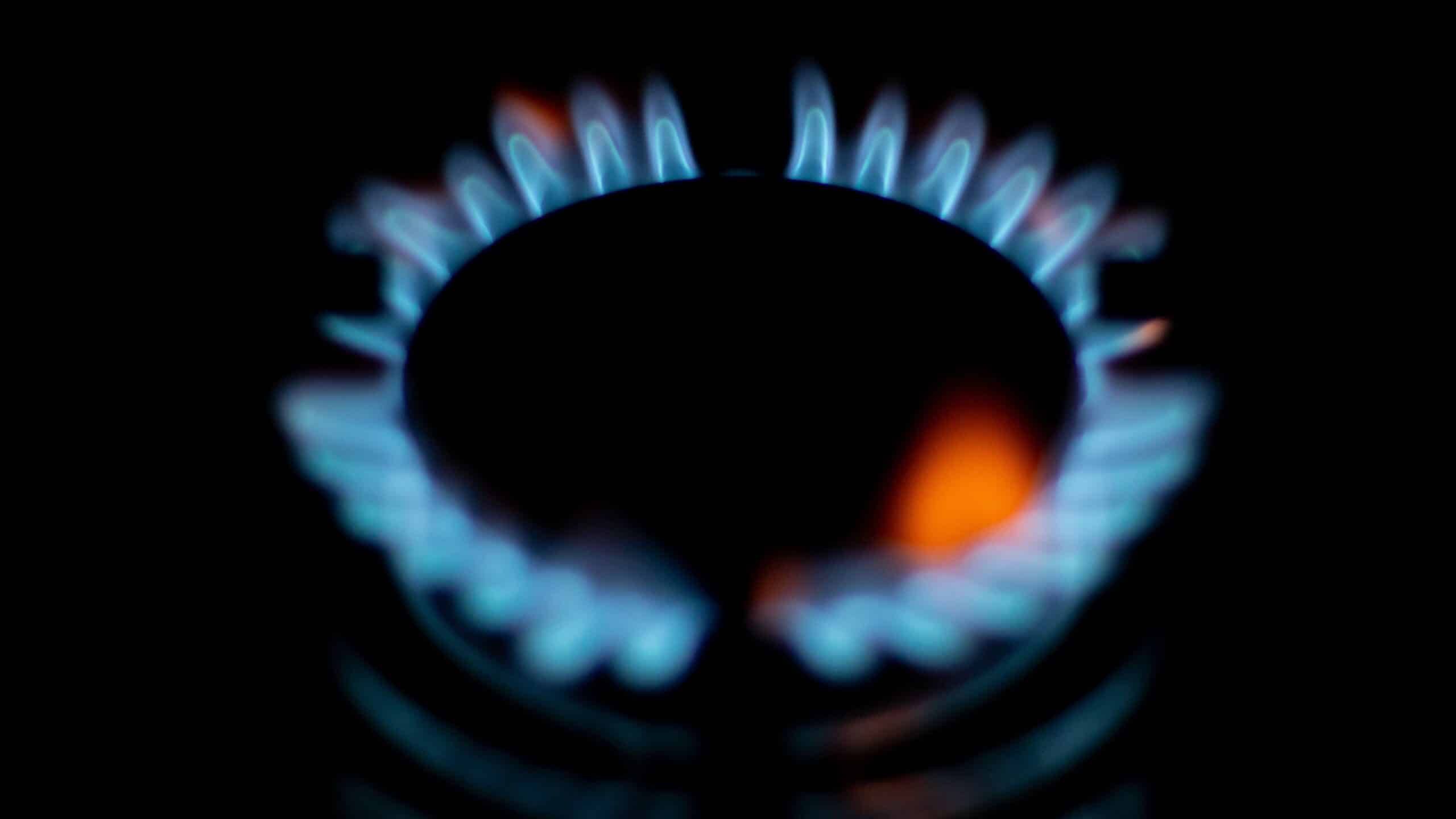Trilaterale Italia-Francia-Germania, Urso: “Passare a un’economia Ue dei produttori”
Sostegno mirato alle imprese, soprattutto Pmi, meno burocrazia e più competitività per non perdere la sfida con Cina e Usa. Dalla nuova riunione trilaterale Italia-Francia-Germania si delinea in maniera ancora più definita l’idea di politica industriale per l’Europa post elezioni. A Parigi i tre ministri che nei rispettivi governi gestiscono la delega rinforzano la partnership e concordano sulla necessità di andare avanti con la doppia transizione, ecologica e digitale, seppur con meno vincoli rispetto al Green Deal originario, e sulla “necessità di un’azione urgente per sbloccare il potenziale tecnologico e innovativo delle imprese europee“. Noi “non vorremo che l’Europa, da continente della tecnologia e dello sviluppo diventasse un museo all’aria aperta“, spiega il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell’incontro. Sottolineando che occorre “passare da un’economia dei consumatori a un’economia dei produttori“, perché “in questi anni abbiamo sviluppato e incentivato i consumi e questo è andato sempre più questo a beneficio dei prodotti e delle imprese di altri continenti, che non rispondono alle nostre stesse regole in termini di standard ambientali e sociali, quindi spesso anche attraverso concorrenza sleale“.
Ben venga, dunque, anche la proposta del ministro dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale della Francia, Bruno Le Maire: una sorta di ‘preferenza’ alle imprese continentali negli appalti Ue. Anche se non è l’unica soluzione che incontra il favore dell’Italia: “Abbiamo detto con chiarezza ai nostri colleghi che condividiamo tutte quelle misure che possono consentire di passare dall’Europa dei consumatori all’Europa dei produttori. Quindi, a una politica industriale che tuteli, rafforzi e rilanci il sistema delle imprese europee“, spiega ancora Urso. Aggiungendo che “questo lo si può fare con misure come quella proposta da Le Maire, ma anche con il nuovo focus della Commissione Ue per accertare se c’è concorrenza sleale e dumping nella vendita di macchine elettriche cinesi” o “con i criteri di qualità, come stiamo facendo noi in Italia, sugli incentivi pubblici per realizzare impianti fotovoltaici ai fini dell’autoconsumo”. Dunque, “da questo punto di vista il governo è neutrale sugli strumenti da utilizzare, ma ben consapevole di quale sia la rotta da determinare per il continente europeo“.
Il ministro federale tedesco dell’economia e dell’azione per il clima, Robert Habeck, parla di “tecnologie innovative, come le biotecnologie e le tecnologie verdi nell’industria eolica, solare e di trasformazione, che sono fondamentali per la crescita economica. La neutralità climatica e la nostra sovranità tecnologica nel prossimo futuro e necessitano quindi di un ambiente favorevole agli investimenti – sottolinea -. Il nostro scambio ha anche sottolineato la necessità di maggiori sinergie europee nelle nostre industrie della difesa, che a mio avviso è fondamentale“.
Tra le soluzioni studiate al vertice di Parigi c’è quella sulla semplificazione e accelerazione delle autorizzazioni e l’accesso ai programmi di finanziamento europei e agli aiuti di Stato, in particolare per le pmi, eliminando le sovrapposizioni normative e riducendo gli obblighi di rendicontazione “ben oltre l’obiettivo della Commissione Ue del 25%“. O ancora “incrementare gli investimenti pubblici e privati per rafforzare l’innovazione, la produttività e la competitività” e portare a compimento, con successo, la doppia transizione. Con un “sostegno mirato alle imprese dei settori industriali più strategici“. In questo senso, dunque, vanno rafforzati i finanziamenti dell’Ue per i beni pubblici europei e le infrastrutture e coinvolgendo maggiormente la Banca europea per gli investimenti. Ma serve anche un “ampio mix di nuove risorse proprie“, con un’Unione europea capace di “finanziare progetti tecnologici di innovazione, in particolare per le tecnologie pulite e net zero, l’intelligenza artificiale dai chip alla capacità di calcolo e ai modelli di grandi dimensioni, i semiconduttori e la cybersicurezza“.
Altro punto rilevante, messo nero su bianco nella dichiarazione congiunta finale, riguarda la necessità di “applicare meglio, approfondire e rafforzare il mercato unico per sfruttare appieno i vantaggi dell’integrazione economica europea, garantendo regole comuni e una forte supervisione, nonché l’applicazione delle norme, in particolare per i prodotti importati“. L’obiettivo, infatti, è “garantire una concorrenza efficace nel mercato unico e affrontare adeguatamente i problemi strutturali della concorrenza nel contesto globale, in particolare nei settori che hanno una dimensione internazionale e sono di grande importanza per l’economia generale dell’Ue“. Urso, Le Maire e Habeck, infine, auspicano “un controllo efficace delle fusioni che impedisca le ‘acquisizioni killer’ con certezza giuridica e chiedono un’attuazione e un monitoraggio approfonditi della legge sui mercati digitali“.
Photo credit: account X Adolfo Urso