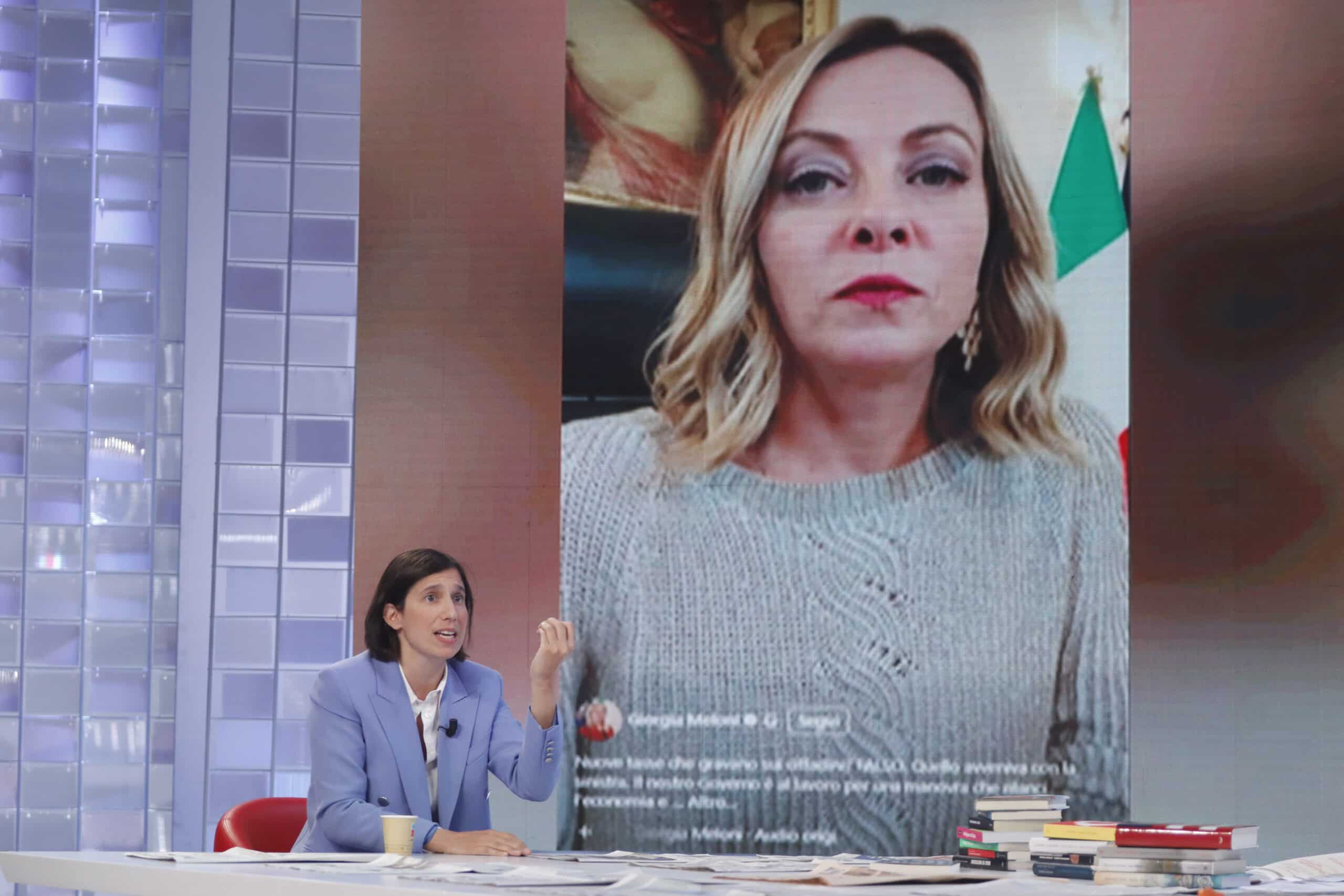Report authority Ue: “Produzione idrogeno verde lontana da obiettivi europei al 2030”
Il mercato dell’idrogeno verde in Europa sta iniziando a prendere forma, sostenuto da strategie ambiziose a livello dell’Unione Europea e politiche nazionali. Tuttavia, nonostante i progressi significativi, permangono sfide per raggiungere gli obiettivi. E’ quanto emerge dal report di Acer, l’autorità di regolamentazione dell’energia dell’Unione europea. La Ue si è posta come obiettivo strategico di arrivare a consumare 20 milioni di tonnellate (Mt) di idrogeno rinnovabile entro il 2030. Tuttavia, il consumo attuale si attesta a 7,2 Mt, con il 99,7% dell’idrogeno ancora derivante da fonti fossili. La produzione tramite elettrolisi però è ancora marginale, pari a circa 22 kilotonnellate (kt). Anche se gli obiettivi europei in ambito energetico e di decarbonizzazione sono molto chiari, l’adozione di idrogeno rinnovabile da parte di settori come il trasporto e l’industria è lenta, rendendo difficile il raggiungimento del target per il 2030.
Attualmente, l’Europa conta su una capacità installata di elettrolizzatori di poco più di 200 MW. Tuttavia, progetti in costruzione porteranno una capacità aggiuntiva di 1,8 GW entro il 2026, e altri 60 GW di capacità sono stati annunciati, con inizio operazioni previsto entro il 2030, ma molti di questi sono in attesa di decisioni finali sugli investimenti. Sebbene gli strumenti di finanziamento stiano diventando sempre più accessibili, l’incertezza sulla domanda e sulle previsioni di costi dell’idrogeno rappresentano ancora rischi significativi per la loro realizzazione tempestiva.
Gli Stati stanno fissando i propri obiettivi di produzione di idrogeno, capacità degli elettrolizzatori e piani di espansione delle infrastrutture, concentrandosi principalmente sull’idrogeno rinnovabile. Certo è che i livelli di ambizione variano da paese a paese, portando a piani di sviluppo disomogenei. Questa frammentazione si riflette anche negli approcci regolatori: nessun Paese ha ancora integrato nel proprio ordinamento nazionale il pacchetto di decarbonizzazione del gas e dell’idrogeno recentemente pubblicato dall’Ue, sebbene ad esempio Danimarca e Germania abbiano avviato consultazioni su pianificazione delle reti e tariffe di accesso.
Uno degli ostacoli principali alla crescita dell’idrogeno rinnovabile è il suo costo. Attualmente, l’idrogeno prodotto tramite elettrolisi costa da due a tre volte di più rispetto a quello prodotto dal gas naturale. Ma la prima asta della Banca Europea dell’Idrogeno – sottolinea Acer – ha rivelato sviluppi promettenti, con alcuni acquirenti disposti a pagare prezzi vicini ai costi dell’idrogeno rinnovabile, anche sotto i 3 euro/kg. Questo dimostra che ci potrebbero essere riduzioni dei costi in futuro. Tuttavia, l’attuale gap di costo pone rischi per i primi investitori, causando ritardi nelle decisioni e nella presa di impegni a lungo termine.
Un elemento chiave per il successo del mercato dell’idrogeno sarà lo sviluppo di infrastrutture che colleghino i siti di produzione con i centri di domanda, anche se molte delle attuali pianificazioni delle reti si basano su proiezioni di domanda future, anziché su esigenze di mercato immediate, il che potrebbe portare a un sovradimensionamento delle infrastrutture e a un loro scarso utilizzo. E poi, conclude Acer, per raggiungere l’obiettivo di produzione di 10 Mt di idrogeno rinnovabile, l’Europa dovrà fare affidamento su quasi tre quarti dell’elettricità rinnovabile attualmente prodotta nell’Ue. Una necessità che comporterà investimenti significativi nelle infrastrutture di idrogeno ed elettricità per connettere gli elettrolizzatori con i siti di produzione di energia rinnovabile.