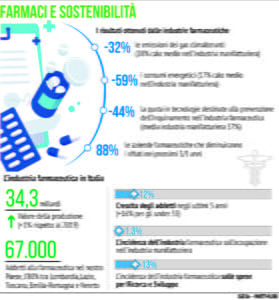Via libera dal Consiglio Ue: stop a motori diesel e benzina dal 2035. L’Italia si astiene
Lo stop ai motori a combustione dal 2035 diventa legge. Dopo settimane di stallo, dal Consiglio Energia europeo riunito a Bruxelles è arrivato oggi l’ultimo via libera al regolamento per ridurre le emissioni di CO2 nelle nuove autovetture, parte cruciale del pacchetto sul clima ‘Fit for 55’. E il testo è passato con l’astensione dell’Italia, della Bulgaria e della Romania. Solo la Polonia ha votato contro il provvedimento, mentre la Germania ha confermato il sì dopo aver strappato alla Commissione Ue una deroga per i carburanti sintetici, gli e-fuels.
La norma – su cui Parlamento e Consiglio europeo avevano già raggiunto un accordo a ottobre – prevede una riduzione graduale delle emissioni di CO2 dalle nuove autovetture immatricolate: devono diminuire del 55% entro il 2030 e del 100% entro il 2035. Questo significa la fine dei motori a combustione interna entro quella data. In una intesa annunciata nel fine settimana, la Commissione europea ha promesso a Berlino di creare un quadro di approvazione per i motori a combustione alimentati da carburanti sintetici, gli e-fuels. E questo ha portato la Germania a sbloccare lo stallo e dare via libera alla normativa.
L’Italia aveva chiesto la stessa apertura sui biocarburanti, ma nonostante non ci sia stata ha deciso di astenersi, anziché votare contro come aveva annunciato fino a poche ore fa.
Astensione, non voto contrario. Ai fini del raggiungimento della maggioranza qualificata (necessaria al via libera) in seno al Consiglio non cambia molto. Il cambio di passo dell’Italia è però significativo dal punto di vista politico. A spiegare le ragioni dell’astensione è il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, subito dopo il voto al Consiglio. Da un lato, l’apertura sui carburanti sintetici voluta dalla Germania per l’Italia significa “salvare” il motore endotermico dopo il 2035. “Abbiamo apprezzato il cambiamento di direzione da parte della Commissione nell’accogliere la possibilità di immatricolare anche motori endotermici dopo il 2035 e non più solo elettrici”, ha sintetizzato Pichetto.
L’altra ragione è che l’Italia pensa di poter dimostrare il principio di neutralità tecnologica “anche ai biocarburanti in una valutazione prima del 2026”, quando il regolamento ha previsto la clausola di revisione. L’Italia – ha detto Pichetto – “è produttore di biocarburanti e abbiamo ottenuto di poter aprire la discussione nel provare che i biocarburanti” possono bilanciare l’emissione con la cattura di CO2 “provenendo da vegetali”. La realtà dei fatti è che la Germania, una volta ottenuta la garanzia da parte della Commissione sui carburanti sintetici, ha lasciato l’Italia sola nell’opposizione al provvedimento con un gruppo minore di Paesi, incapaci di raggiungere la soglia per rappresentare una minoranza di blocco. A quel punto, più che dare un parere contrario ha preferito astenersi, anche se da parte della Commissione europea non c’è stata alcuna apertura sui biocarburanti come richiesto dal governo di Roma.
In base all’intesa con la Germania annunciata sabato mattina, la Commissione europea presenterà un atto delegato sul ruolo dei carburanti sintetici, e-fuels, per ridurre le emissioni di CO2. I carburanti sintetici vengono realizzati utilizzando elettricità rinnovabile e anidride carbonica catturata dall’atmosfera, dunque compensano la quantità di CO2 emessa. Dopo l’intesa con Berlino, la Commissione europea ha chiarito in una dichiarazione i termini del ‘considerando 11’ del testo del regolamento, impegnandosi a proporre “in linea con l’abilitazione legale nell’autunno del 2023, un atto delegato che specifichi come i veicoli alimentati esclusivamente con carburanti sintetici (e-fuels) contribuiranno agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, in relazione alla regolamentazione degli standard di emissione di CO2 per le automobili e i veicoli commerciali leggeri. Nel caso in cui i colegislatori respingano la proposta, la Commissione seguirà un altro percorso legislativo, come la revisione della normativa sulle emissioni di CO2, per attuare almeno il contenuto giuridico dell’atto delegato”, si legge. L’atto delegato riguarderà solo i sintetici, nessuna apertura sui biocarburanti.