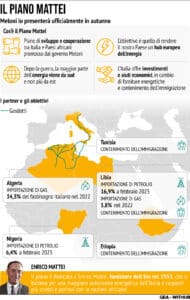Riaprire il tribunale del Levante, ecco cosa fare veramente e rapidamente
Il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, interviene nel suo editoriale su ‘Piazza Levante‘ sul tema della riapertura del Tribunale di Levante.
“Questo giornale ha sempre sostenuto che la perdita del Tribunale è stato un durissimo colpo per la città di Chiavari e per il suo ruolo di capoluogo del Tigullio.
È sempre utile ricordare il clima in cui maturò a livello governativo quella scelta scellerata.
Fu una scelta demagogica del governo Monti.
Non riuscendo a procedere con altri tagli di spesa pubblica che l’Europa chiedeva all’Italia dopo la tempesta speculativa che aveva costretto il Governo Berlusconi alle dimissioni, il premier professore pensò bene di procedere alla chiusura dei piccoli tribunali non collocati in capoluoghi di provincia, per dare prova della capacità del suo governo di praticare veramente politiche di austerità.
Si trattò appunto di una scelta demagogica perché in realtà i risparmi di spesa furono minimi o nulli e i disagi per i cittadini utenti del servizio di giustizia enormi.
L’esempio del Tribunale di Chiavari è sotto gli occhi di tutti.
Si trattava di un Tribunale ben organizzato e molto efficiente nella qualità e nei tempi del servizio di giustizia, che serviva un vasto bacino di popolazione compresa una parte dell’entroterra ligure e cioè la Val Fontanabuona, la Valle Sturla e la Val Graveglia tradizionalmente gravitanti su Chiavari.
Si trattava di un Tribunale di presenza antica, abolito sotto il fascismo che detestava ogni forma di decentramento, e riaperto con la Liberazione e la Repubblica.
Si trattava di un’attività direzionale di rango superiore con un importantissimo indotto anche sulle altre attività di servizio e commerciali della città e punto di riferimento di un ceto professionale fatto di avvocati, commercialisti, notai, ingegneri, geometri, periti che caratterizza da sempre la città.
Si trattava di un Tribunale che aveva condotto lo Stato a un ingente investimento per la realizzazione di una nuova sede più moderna ed efficiente, realizzata in aderenza al carcere mandamentale e al commissariato di Pubblica Sicurezza secondo criteri di efficienza anche logistica del servizio di giustizia.
Tutti questi elementi non furono minimamente tenuti in conto, anche per la debolezza politica e di rappresentanza del Tigullio, che non avendo ‘santi in Paradiso’ ancora una volta pagò pegno a favore di Genova matrigna.
Non ci fu un solo politico genovese che prese le parti delle esigenze di Chiavari e del Tigullio e anzi con il tipico egoismo del capoluogo la chiusura del Tribunale di Chiavari e l’accentramento dei suoi servizi nel Tribunale di Genova fu vissuta come un atto quasi dovuto alla Superba.
L’onda ‘razionalizzatrice’ e ‘accentratrice’ fu anche cavalcata da vasti settori e correnti della Magistratura e della burocrazia ministeriale da sempre fautori dei grandi tribunali e della loro specializzazione, in spregio ai presidi territoriali e al decentramento delle attività sul territorio.
Fino ad oggi nessuno ha avuto il coraggio di fare il bilancio, numeri alla mano, di quella chiusura spiegando ai cittadini quali sono stati i risparmi, se mai ve ne sono stati, analizzando i costi aggiuntivi che sicuramente l’accentramento ha comportato (spazi mancanti presso il Tribunale di Genova ad esempio), cercando di calcolare il peso e i sacrifici per la popolazione comportati dall’accentramento su Genova.
Una brutta pagina di demagogia e cattiva amministrazione confermata dal fatto che alcuni tribunali non in capoluoghi di provincia (e cioè nella stessa situazione di Chiavari) vennero salvati non si sa in base a quali criteri e valutazioni se non il peso politico di qualche ‘santo protettore’ che Chiavari non aveva avuto.
Con Nordio Ministro di Grazia e Giustizia sembra aprirsi una prospettiva nuova. Noi stimiamo molto l’ex magistrato per la sua visione della giustizia e per il suo garantismo tanto più rilevante perché proviene da un ex pm.
Nordio ha avuto l’onestà di dire alla Camera che le chiusure dei piccoli tribunali molto spesso sono stati atti non giustificati da elementi concreti e ha affermato che il Governo Meloni ha intenzione di riesaminare la questione facendo una corretta e non demagogica analisi costi-benefici riesaminando il dossier caso per caso.
Emergono sia nelle dichiarazioni del Ministro che soprattutto in quelle del sottosegretario onorevole Delmastro due questioni fondamentali al fine di avere qualche chances:
L’eventuale riapertura dei tribunali soppressi potrà avvenire solo se il servizio riguarderà un’area territoriale più vasta di quella servita in precedenza;
La disponibilità di locali idonei e immediatamente fruibili sarà particolarmente importante.
Entrambi gli elementi costituiscono una chiarissima indicazione di un lavoro politico e amministrativo che va svolto con celerità ed intelligenza.
Il Tribunale del Levante (così dovrà chiamarsi e non più Tribunale di Chiavari) quali territori nuovi dovrà servire in più rispetto alla vecchia circoscrizione? Una parte di genovesato? Una parte di provincia di La Spezia? Bisogna convincere le Amministrazioni di quelle località a lavorare per la nuova struttura e a condividere il progetto.
Bisogna al più presto liberare l’edificio del nuovo Tribunale in corso De Michiel dai servizi che vi sono stati collocati dalla Civica Amministrazione negli ultimi anni. Bisogna farlo subito trovando soluzioni di ricollocazione per Inps, GdF, Agenzia delle Entrate, Giudice di Pace e Centro per l’impiego.
La disponibilità immediata dei locali è considerata come si diceva un elemento fondamentale. Bassano del Grappa, nella stessa identica situazione di Chiavari, ha tenuto duro per più di dieci anni tenendo vuoto l’edificio e oggi lo ha pronto e a disposizione.
Noi siamo sempre stati molto critici con l’Amministrazione Di Capua prima e Messuti poi perché il tema di volumi direzionali, fondamentali per presidiare il ruolo di capoluogo di Chiavari, non è mai stato al centro dell’attenzione e anzi si sono perse e si stanno perdendo occasioni per dare volumi direzionali alla città.
Basta fare l’elenco delle occasioni perdute: palazzo Ferden, intervento nell’area Cantero Ginocchio, area Italgas ed altre ancora che se oggi fossero disponibili consentirebbero di rilocalizzare immediatamente i servizi collocati nel nuovo Palazzo di Giustizia liberandolo per la riapertura del Tribunale.
Vediamo cosa farà nelle prossime settimane la Civica Amministrazione e capiremo rapidamente se davvero ci tiene e se crede alla riapertura del Tribunale operando coerentemente in tal senso.
I discorsi stanno a zero: fatti, non parole“.