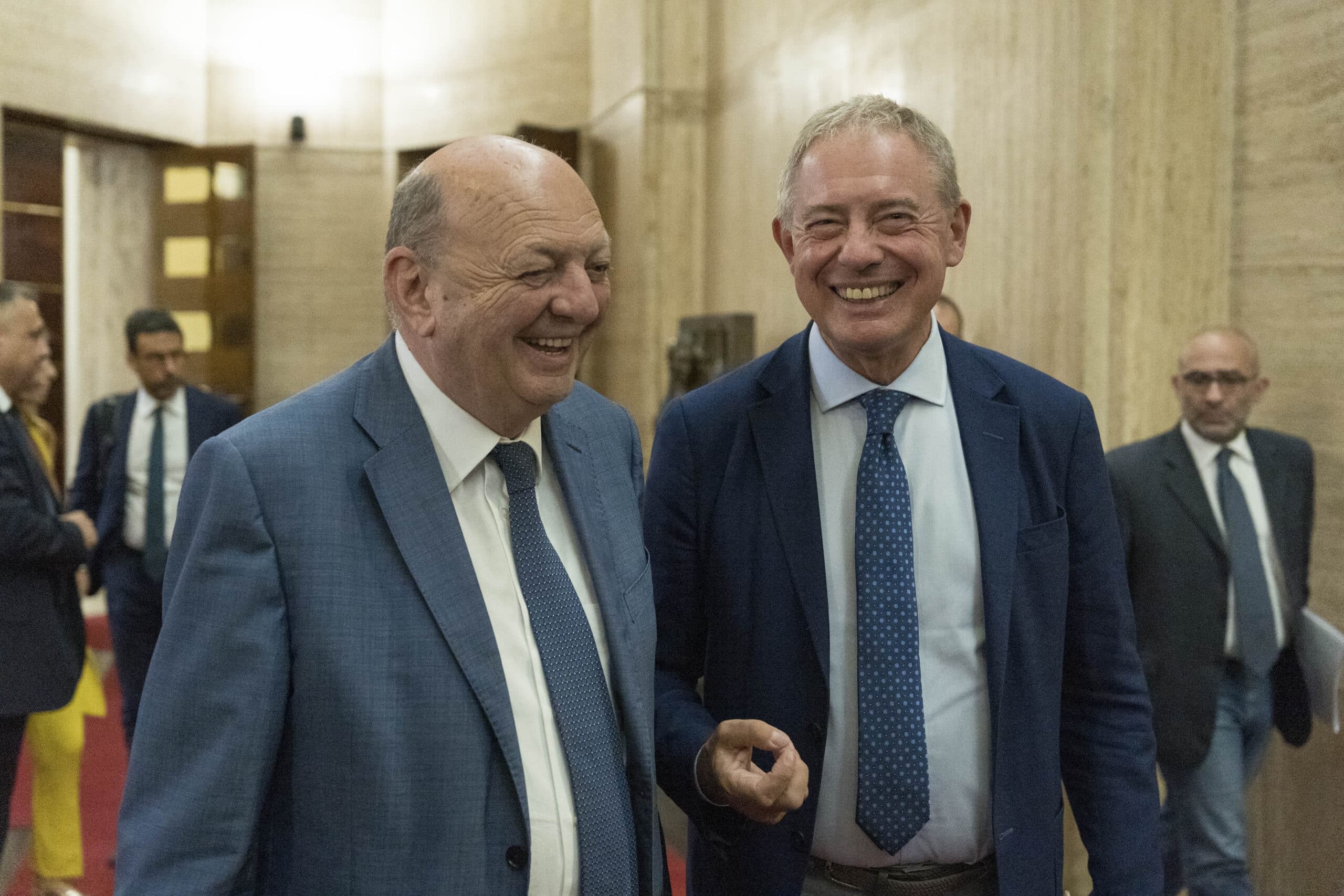Pichetto: “Ddl Nucleare legge entro l’anno”. Enea guarda a fusione col primo magnete per DTT
Il disegno di legge sul Nucleare diventerà legge entro l’anno e l’Italia, dopo 40 anni, potrà tornare in corsa per produrre energia da fissione e in futuro da fusione. E’ l’auspicio di Gilberto Pichetto Fratin, che partecipa alla presentazione del primo magnete per il progetto DTT (Divertor Tokamak Test) nello stabilimento di ASG Superconductors della Spezia.
Il ddl è stato licenziato in consiglio dei ministri alla fine di febbraio, ma deve ancora approdare in Parlamento. “Noi vogliamo accompagnare ma anche accelerare” l’energia Nucleare, spiega il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Non solo quindi l’esecutivo sceglie di produrla, ma prevede anche di avere un ente di controllo e di sostenere la ricerca e la formazione. Si partirà inevitabilmente dai “piccoli reattori” da fissione di “terza generazione avanzata”, per poi arrivare alla fissione di quarta generazione, con raffreddamento a piombo, fino all'”eldorado della fusione“, precisa Pichetto Fratin.
Proprio alla fusione guarda il Dtt, macchina sperimentale 100% italiana in costruzione nel Centro Ricerche ENEA di Frascati. Oggi è stato presentato il primo dei diciotto magneti che costituiranno il “cuore” tecnologico del reattore. “Un ulteriore e importante tassello verso la fusione, da molti considerata la più importante sfida tecnologica del nostro secolo”, ribadisce l’inquilino del dicastero di viale Cristoforo Colombo. Un progetto promosso da un consorzio composto da ENEA, Eni e diverse università e istituzioni di ricerca italiane, con un investimento complessivo superiore ai 600 milioni di euro e che si stima possa generare un impatto economico e occupazionale pari a circa 2 miliardi di euro. Il progetto darà vita anche a uno dei centri scientifico-tecnologici più avanzati a livello mondiale, concepito come un hub internazionale aperto alla collaborazione di ricercatori e scienziati provenienti da tutto il mondo.
In questi decenni, sia nel campo della fusione che quello della fissione l’Italia ha mantenuto “una rete industriale robusta, una importantissima catena di approvvigionamento per impianti europei e internazionali, un sistema di ricerca avanzato e istituzioni accademiche di eccellenza, che forniscono competenze qualificate a livello internazionale – ad esempio in grado di formare, già oggi, circa il 10% degli ingegneri nucleari europei“, ricorda Pichetto Fratin.
Il magnete superconduttore misura oltre 6 metri di altezza e pesa 16 tonnellate. E’ composto con tecnologie costruttive all’avanguardia e materiali innovativi per contenere 33 metri cubi di plasma a una temperatura di oltre 100 milioni di gradi. Il DTT vuole essere un elemento di raccordo tra i grandi programmi internazionali ITER e DEMO e promette di dare risposte cruciali ad alcune delle principali sfide ancora aperte nel percorso verso la produzione di energia da fusione, come ad esempio la gestione dei flussi di potenza estremamente elevati generati dal plasma.
“Siamo particolarmente orgogliosi di contribuire, con le nostre competenze e infrastrutture, a questo risultato che rappresenta un importante passo in avanti nella roadmap per la realizzazione della facility DTT e in generale per l’energia da fusione“, rivendica Giorgio Graditi, direttore generale ENEA. Una tappa fondamentale “non solo per la nostra macchina sperimentale ma per l’intera filiera della fusione in Italia“, spiega Francesco Romanelli, presidente DTT, che parla di una “dimostrazione concreta che ricerca pubblica e industria privata, quando lavorano in sinergia, possono affrontare con successo sfide scientifiche e tecnologiche di portata globale“. Il DTT è nato per “accelerare la transizione energetica, formare nuove generazioni di ricercatori e tecnologi e contribuire in modo determinante alla costruzione dei reattori del futuro, in grado di produrre energia non solo pulita ma di fatto inesauribile. Oggi questo ulteriore risultato concreto – scandisce -, ci consente di guardare avanti con ancora più fiducia e determinazione”.